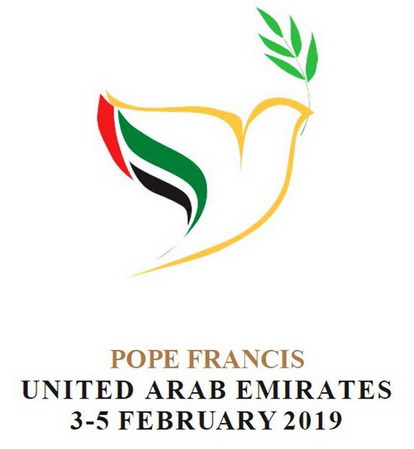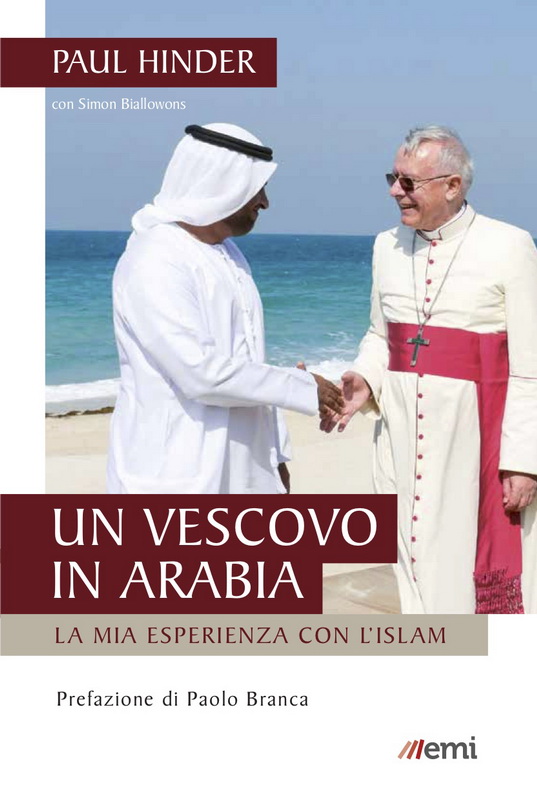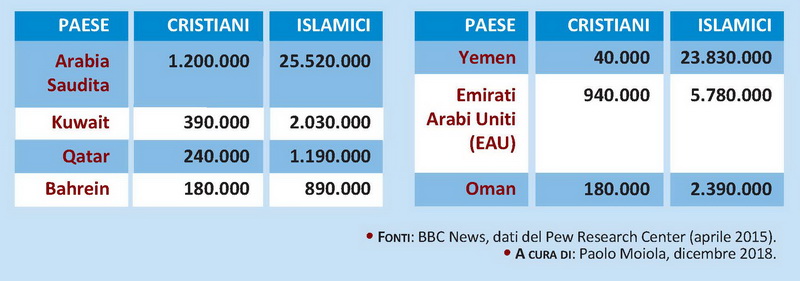Bombe italiane in Yemen
Riguardo agli ordigni prodotti in Sardegna, venduti all’Arabia Saudita e usati dalla coalizione a guida saudita per bombardare lo Yemen, il ministro Roberta Pinotti ha assicurato che l’Italia ha osservato scrupolosamente tutte le norme nazionali e internazionali in materia di produzione e vendita di armi. Io dico invece che la differenza tra un sistema democratico e una dittatura la fa anche la disponibilità ad ammettere i propri errori, la fa anche la voglia di chiedere scusa, la fa anche il desiderio di rimediare ai danni fatti, più o meno consapevolmente, più o meno legalmente.
Uberto Zumpanesi
31/12/2017
Gambo, Etiopia
Buongiorno, io e mio marito siamo appena tornati da un viaggio in Etiopia del Sud, dove abbiamo avuto l’opportunità di stare tre giorni alla missione di Lephis Forest, Ospedale di Gambo. È stata un’esperienza straordinaria, anche se non era la prima volta che visitavamo una missione africana. Vogliamo soprattutto ringraziare Abba Alvaro che, nonostante tutto il daffare che ha, ci ha dedicato il suo tempo prezioso per accompagnarci all’ospedale e alla fattoria. Anche i due volontari italiani presenti e l’infermiera Gabriella ci hanno fatto sentire a casa, ed è stato bello brindare all’anno nuovo alle 20,30 (prima che il generatore si spegnesse dato che il governo non è troppo attento ai bisogni della zona e la corrente è un optional). A breve invieremo una piccola offerta: ci sono tante spese, non guasterebbero dei pannelli solari e delle galline per la fattoria, utili per le uova che sono carissime e servono per nutrire i molti bambini del reparto di pediatria dell’ospedale! Ancora grazie e cari saluti.
Gianna Masoero e Guido Porta
05/01/2018
Permacultura
Sono un vostro abbonato da anni e vi posso dire che la vostra rivista missionaria è una delle più interessanti che arrivano in casa. Ho letto sul numero di novembre l’articolo «Una prospettiva per guardare il futuro». Un articolo interessante i cui contenuti andrebbero giustamente diffusi in ogni comunità. Vorrei però fare un appunto, se mi permettete, non ho trovato nessun accenno alla nostra alimentazione (riduzione o eliminazione delle proteine animali) non solo per il nostro benessere ma per il benessere di tutti i fratelli del mondo e del pianeta Terra. Una proposta interessante nata negli anni Novanta è la campagna dei «Bilanci di Giustizia».
Il mio sogno da anni è che questi argomenti siano presi a cuore dalle nostre comunità cristiane e inseriti in un vero cammino di fede e di amore dei fratelli. Tanti saluti e buon lavoro.
Daniele Engaddi
10/01/2018
Abbiamo inoltrato l’email all’autrice dell’articolo che ha risposto subito.
Gentile Daniele,
in primis La ringraziamo per essere un fedele lettore e per aver mostrato interesse verso l’articolo incentrato sulla Permacultura. Proprio perché lo scritto, in particolare, verteva sulla progettazione, conservazione consapevole degli ecosistemi e su quelle tecniche agricole più rispettose degli equilibri degli habitat del pianeta, non abbiamo ritenuto opportuno aggiungere un argomento così vasto e complesso come quello dell’alimentazione.
Il rapporto tra tutela dell’ambiente e riduzione/eliminazione delle proteine animali è indubbio, ma questo sarebbe necessario approfondirlo in un altro articolo e uno solo non sarebbe nemmeno esaustivo. Ringraziandola ancora per la sua attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Silvia C. Turrin
11/01/2018
Grazie
Caro padre,
non smetta di scrivere e punzecchiare le nostre anime! Io scrivessi come penso, sarei già radiato! Si vede che lei ha superiori più clementi. Tutta la vostra rivista è un dono per noi in questo tempo in cui «anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare».
Don Vincenzo F.
15/12/2017
A proposito di apparizioni e veggenti
Caro Direttore,
[…] nel numero di novembre 2017 avete ospitato la risposta di don Paolo Farinella ad una lettera pervenuta. Sono rimasto basito! È sicuramente degna di rispetto la posizione di don Paolo, ma che un sacerdote parli in questo modo delle apparizioni di Maria, beh, sinceramente fa male; credo che se il beato Giuseppe Allamano avesse visto questa «ospitata» non ne sarebbe rimasto affatto contento… […] Fa veramente male sentire parlare così da parte di sacerdoti delle apparizioni di Maria e mi ha fatto male vedere pubblicato sulla rivista questa posizione.
Benedetto N.
13/12/2017
Prima del sig. Benedetto anche un altro lettore aveva scritto sull’argomento, «sconsolato» dalla stessa risposta, chiedendomi di inviare a don Farinella la sua email (da non pubblicare) nella quale, a sostegno del suo pensiero, citava diversi passaggi dai Quaderni della mistica Maria Valtorta. Don Paolo ha risposto immediatamente con una email che ho inoltrato subito al lettore interessato.
Tenendo conto però dell’importanza dell’argomento, mi permetto di riportare qui la risposta di don Paolo, omettendo tutte le parti più personali. Le scritte tra parentesi quadre sono redazionali per rendere comprensibile il testo nei punti omessi o tagliati.
Ecco la risposta di Don Paolo Farinella.
[…] Rispondendo a una lettera di una lettrice [in MC 11/2017 p.6] scrivevo letteralmente: «Mi dispiace deluderla, io non mi occupo di apparizioni. […] Non capisco queste apparizioni di Madonne che dicono sempre la stessa cosa, ormai da secoli, solo per la soddisfazione di chi dice di avere avuto messaggi personali. Sto con la Chiesa che non mi obbliga a credere ad esse, nemmeno a quelle riconosciute come Fatima o Lourdes. Infatti un cattolico che affermasse: “Io non credo alle apparizioni della Madonna di Fatima o di Lourdes” non sarebbe meno cattolico di chi afferma di credervi». Questa è la posizione ufficiale e costante della Chiesa.
Lei [dissente dalla mia posizione e], per dare forza alla sua critica, cita un passo della Valtorta da «I Quaderni» del 1943, come se fosse «Parola di Dio».
Mi permetta di dirle sinceramente che mi cadono le braccia perché se siamo ancora alla Valtorta, significa che la Chiesa ha ancora un lungo cammino da fare sulla via della purificazione dall’idolatria. La Valtorta non dice nulla di diverso di tutte le altre pseudo e sedicenti apparizioni mariane, come fossero fotocopie e invano papa Francesco ripete, riguardo a Medjugorje, che «la Madonna non è una postina». Se siamo ancora a questo punto, è stato vano il concilio Vaticano II, a cui mi attengo scrupolosamente perché è il magistero più alto della Chiesa cattolica. I Padri conciliari hanno posto rimedio a una stortura teologica che poneva la Madonna al di sopra di Dio stesso anche pastoralmente (prima del concilio ogni domenica c’era una festa della Madonna, cui si sacrificava il senso dell’ottavo giorno in sé, memoriale della Pasqua, della morte e risurrezione del Signore). Il concilio ha posto Cristo al centro della vita, della spiritualità, della preghiera, della liturgia, della morale, e ha ricollocato Maria al suo posto, quello splendidamente descritto da Dante: «Vergine Madre, figlia del tuo Figlio», diversamente Maria non è la Madre di Gesù, ma un idolo separato perché più comodo da gestire, anche a livello sentimentale.
Quanto alla Valtorta […] sappia che, in questo modo, lei si pone fuori della Chiesa che ha condannato due volte quelle fantasiose e romanzate visioni definendole pericolose per la fede. Il 16 dicembre 1959, dall’allora Sant’Uffizio, i volumi usciti furono inseriti nell’«Indice dei libri proibiti» e il 6 gennaio 1960 «L’Osservatore Romano» li definì: «Una lunga prolissa vita romanzata di Gesù… Anzitutto il lettore viene colpito dalla lunghezza dei discorsi attribuiti a Gesù e alla Vergine SS.ma», e aggiunge che è tutto l’opposto dei Vangeli, dove regna la sobrietà.
Evidentemente la condanna ufficiale della Chiesa, quella cui la Madonna della Valtorta dice di ubbidire, ma alla quale la visionaria non ubbidì affatto, non bastò se il 31 gennaio 1985 il card. Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione della Fede (ex Sant’Offizio), dovette dare la stroncatura definitiva.
Dopo avere ripreso e confermata la condanna del 1959, concluse: «Avendo poi alcuni ritenuta lecita la stampa e la diffusione dell’Opera in oggetto (Il Poema dell’Uomo Dio, ndr) … non si ritiene opportuna la diffusione e raccomandazione di un’Opera la cui condanna non fu presa alla leggera ma dopo ponderate motivazioni al fine di neutralizzare i danni che tale pubblicazione può arrecare ai fedeli più sprovveduti (sottolineatura mia) … Joseph cardinale Ratzinger». La condanna si estende a tutti gli scritti della Valtorta. […]
Paolo Farinella
06/12/2017
A questo proposito, ricordo che quando iniziai a lavorare in questa rivista nei primi anni Ottanta, trovai in redazione un intero scaffale pieno di libroni di centinaia di pagine dai titoli come questi: «Lo Spirito Santo parla al cuore di…», «La Madonna ai suoi diletti figli», «Le rivelazioni di Gesù a…» e via dicendo. Ricordo di aver tirato fuori il Vangelo tascabile che portavo con me. La piccolezza di quel libricino – che pure aveva rivoluzionato il mondo – a confronto con quei volumoni era impressionante. Tenni il Vangelo. I libroni finirono nel container della carta per le missioni.
Da Roraima: fratel Carlo Zacquini
I mezzi di comunicazione mi permettono di mantenere con una certa regolarità contatti con molte persone. Mi considero molto fortunato di annoverare un numero piuttosto grande di veri amici che si interessano sovente della mia salute e delle mie attività, e in modo speciale poi degli Yanomami e dei popoli indigeni nel Brasile.
Mi sento un po’ incapace di alimentare – come sarebbe mio dovere – questa catena di persone che sempre si chiedono e mi chiedono se possono fare qualcosa per le finalità a cui mi dedico. Come è difficile poter rispondere con chiarezza; come è difficile fare chiarezza anche dentro di me su quel che sarebbe meglio fare!
Ho l’impressione che in questi ultimi tempi l’attività principale che svolgo stia prendendo una bella piega. In un modo o nell’altro, al momento siamo già in quattro persone fisse a lavorare al Centro di Documentazione Indigena (Cdi). Sembrano molte, ma … pur volendo dedicarci esclusivamente a questo lavoro, per ora siamo lontani dal riuscirci.
Certamente non è per mancanza di lavoro! Ultimamente abbiamo dovuto fare una pausa nelle attività più importanti, non perché stiamo prendendola alla leggera, ma, come sovente capita da queste parti, per le difficoltà e gli imprevisti che ci obbligano a ridurre la velocità dei nostri passi.
Abbiamo sempre più materiale importante che non ci sta nell’attuale edificio che ospita il Cdi. Ci è stato offerto altro materiale da varie parti per arricchire la nostra documentazione. Questo vuol dire che altre persone e enti hanno notato l’importanza del Cdi, e stanno dando credito alle nostre intenzioni e iniziative. Alcuni ci suggeriscono anche di guardare avanti con fiducia e ottimismo, includendo anche altre attività che per ora non sono previste. Io credo che dovremo andare avanti con prudenza, ma anche con fiducia nella Provvidenza. Essa ci farà vedere al tempo giusto come proseguire.
Certamente non sarà mai facile competere con gli avversari dei popoli indigeni; né possiamo illuderci di trasformare i popoli indigeni in società perfettamente adattate a resistere a tutti gli attacchi mossi contro di loro. Sta a noi tutti fare la nostra parte, e dare a loro i mezzi migliori per farsi le ossa!
La situazione attuale di invasione della Terra Indigena Yanomami da parte dei cercatori d’oro è veramente brutta. Si parla di varie migliaia di invasori che portano con sé violenza, droghe, corruzione di minorenni, contaminazione col mercurio, trasmissione di malattie veneree, impunità! Il villaggio degli indigeni isolati è accerchiato ormai da almeno tre gruppi di garimpeiros che hanno già sparato almeno a uno di essi.
Guardando un po’ oltre, è palese lo sfacelo della giustizia a tutti i livelli; e gli esempi più sconvolgenti vengono dalle più alte autorità del paese. Oltre 60mila morti violente in un anno; caos nei servizi pubblici (sanità, scuola, prigioni, …).
Nel nostro piccolo, nella discarica di immondizie della città di Boa Vista, a metà ottobre, sono stati trovati più di cento bambini che vi lavoravano, cibandosi anche di rifiuti.
Adesso la discarica è controllata. Ma durerà?
Con l’afflusso di decine di migliaia di venezuelani (si parla di settantamila, tra cui un buon numero di indigeni Warao e altri) che fuggono dalla violenza, dalla miseria e dalla fame vera e propria, si accentua la situazione di caos negli ospedali, negli ambulatori medici, nelle scuole, col contrabbando, nelle prigioni, …
Pare che anche la natura voglia collaborare al caos; recentemente ci sono già stati almeno 60 casi di bagnanti aggrediti da piranha nelle spiagge del rio Branco, a Boa Vista. Alcuni esperti hanno suggerito che la causa potrebbe essere l’inquinamento delle acque.
Guardandoci attorno si ha l’impressione che si voglia distruggere il pianeta per favorire una piccola minoranza.
Le statistiche dicono che gli otto «uomini» più ricchi del mondo sono padroni di ricchezze maggiori di quelle della metà degli uomini, e 800 milioni di esseri umani fanno la fame.
In Brasile si producono enormi quantità di cibo (granaglie, carne, caffè, frutta, vini) usando con abbondanza diserbanti tossici proibiti in Europa (Combate Racismo Ambiental, 28 nov. 2017). Buona parte di questi cibi va a finire sulle vostre tavole. Tempo fa, ho suggerito che si organizzasse un boicottaggio ai prodotti alimentari provenienti dal Brasile. Chi non lo ha fatto, probabilmente si è alimentato con pericolosi veleni.
Le mie e le nostre speranze sono rafforzate dalla vostra indefessa attività in favore dei popoli indigeni e di altri dimenticati dagli uomini. Con affetto e riconoscenza,
Fratel Carlo Zacquini
da Boa Vista, Roraima, Brasile, 07/12/2017
Le 99 pecore
Carissimo Direttore,
nel riprendere in mano il n.10 del mese di ottobre, ho letto la lettera di Andrea Sari e la sua risposta in un giorno non penso casuale (martedì 12 dicembre). Nel commentare le letture del giorno (il Vangelo di Matteo 18,12-14 che ricorda il pastore che lascia le 99 pecore per cercare quella perduta), il nostro curato ci ha lasciato questo bel pensiero: «Il Signore non è che abbandona le 99 pecore per cercare quella perduta perché sa che il gregge non si allontanerà dal posto dove le ha lasciate. Le 99 sono consapevoli di essere al sicuro e non vanno in cerca di pericoli, mentre quella perduta non era cosciente dei pericoli che poteva incontrare abbandonando il gregge». Ecco, con questo spirito don Luciano ci ha invitati a «sentirci vicino il Signore» anche quando sembra che si allontani per ricercare la pecorella smarrita. Penso che senza tanti lunghi ragionamenti valga l’invito del nostro curato di «vivere con serenità il nostro rapporto con il Signore in ogni momento della giornata» anche quando il Signore si allontana.
Pino Candiani
parrocchia di Loreto, Bergamo, 12/12/2017