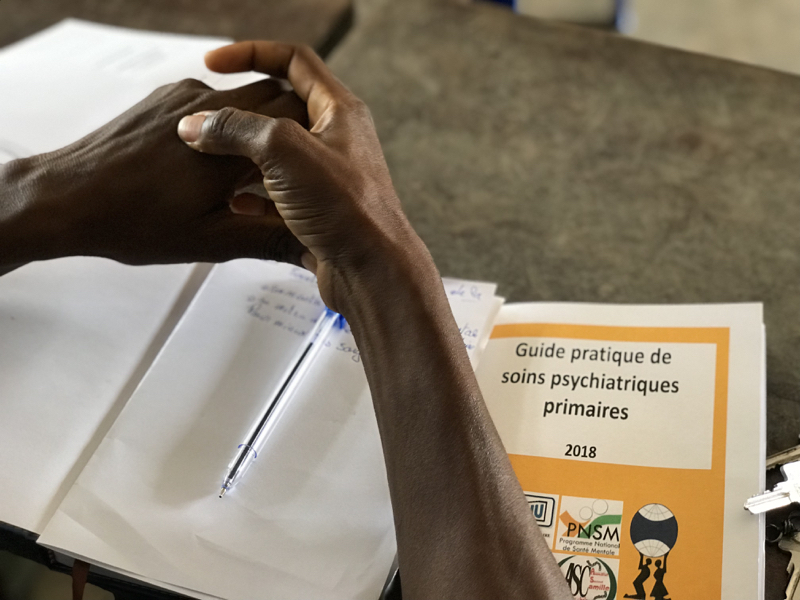Noi e Voi, dialogo lettori e missionari
Dall’umiliazione alla dignità
Dopo aver condiviso le forti impressioni provocate da quanto descritto sull’umiliazione a cui si sottomettono vasti strati impoveriti della popolazione argentina, (vedi «Uomini e maiali» su MC notizie) ho avuto occasione di visitare recentemente una delle comunità indigene che la Provvidenza mi ha permesso di accompagnare vent’anni fa nelle vicinanze di Orán (Salta) nella lotta per il diritto al territorio ancestralmente occupato, contrastato dalla grande multinazionale Seabord Corporation (ex Ingenio San Martín del Tabacal), ma grazie a Dio recuperato.
È stata una mezza giornata di intense emozioni, al ricordare l’esperienza vissuta insieme dal 2004 al 2011, come parte di un’équipe della diocesi di Orán, per accompagnare la dura realtà dei conflitti per la terra di diverse comunità che dovevano affrontare l’opposizione ostile e violenta di potenti gruppi economici presenti nella zona.
Mi sto riferendo concretamente alla comunità Tupí Guaraní Iguopeigenda, situata a pochi chilometri della città di Orán.
La resistenza decisa di questa comunità ha fatto sì che si rafforzasse l’organizzazione comunitaria con criteri e valori propriamente indigeni, a cui è seguita l’elaborazione pratica di progetti di sviluppo produttivo per non finire nel circolo umiliante dell’impoverimento e dell’assistenzialismo. Sin dall’inizio, la resistenza ha avuto un obiettivo chiaro: «Non vogliamo dipendere da un precario pacco di alimenti, ma vivere del lavoro della terra che generosamente ci offre quello che coltiviamo con le nostre mani e che ci appartiene». Era, ed è, una dimostrazione chiara di dignità per affrontare le sfide della sussistenza.
Provvidenzialmente, proprio nel giorno in cui ho visitato questa comunità, mi si mostrava con sano orgoglio un riassunto di tutta l’esperienza, attraverso un cartello che riproduceva la memoria viva lasciata come eredità da Pablo Andrada, un hermano (fratello), morto recentemente.
«Siamo un’eredità viva, presente, dei Tupí Guaraní in questo mondo. E rimaniamo in una comunità radicata nel sud del Río Blanco. Iguopeigenda, la nostra identità.
Abbiamo un consiglio di anziani, e anche un nobile consiglio direttivo, e, insieme a tutti i fratelli, cerchiamo di raggiungere gli obiettivi.
Qui la cultura è trascendentale, così come le nostre tradizioni; professarla sarà veramente fondamentale per le future generazioni.
Come ogni comunità ancestrale, con coraggiosa saggezza, anche noi vigileremo sulla biodiversità e la preservazione dell’ambiente.
Siamo produttori di diversi tipi di frutta di stagione, così come ortaggi, tuberi e moringa per la medicina tradizionale.
Le nostre banane sono il nostro orgoglio, sia perché fonte di sostentamento per tutti sia per la loro pregiata qualità è nota in tutto il paese.
Siamo immensamente ed eternamente grati a tante persone per la loro collaborazione, e alle istituzioni per essere state un ponte verso un futuro migliore.
Allo stimato, padre José Auletta, un degno esempio di benevolenza: “grazie” da parte della comunità, per il suo aiuto, consiglio, saggezza e anche per la perpetua amicizia» (Pablo Andrada, Orán – Salta, 10/04/2021).
Un’ulteriore prova della dignità di questa comunità – che porto nel cuore, insieme a tante altre che la missione mi ha fatto incontrare – è il fatto che durante la mia visita essa abbia condiviso con altre comunità pervenute da diverse località la propria esperienza produttiva e di auto sostegno.
Tutto questo è un segno di speranza per una vita fraternamente sostenibile e degna.
José Auletta
missione di Yuto (Jujuy), Argentina, gennaio 2024
PADRE K’OKAL
Il missionario che spargeva allegria
La notizia arriva nel pomeriggio del 2 gennaio: padre K’Okal è scomparso. Penso subito a un sequestro. In Venezuela è diventata una pratica ricorrente. Poi la doccia fredda: è stato ritrovato il suo cadavere. Non ci credo. Cosa è successo? Mille sono le domande. Nei giorni successivi arrivano altri dettagli. La polizia conclude l’indagine in maniera sbrigativa: per loro si tratta di suicidio.
Non è possibile. Non K’Okal.
Padre Josiah Asa K’Okal («K’» per dire «figlio di», ndr), era riconosciuto in America Latina come difensore dei diritti degli indigeni, in particolare dei Warao, che erano diventati il suo popolo, la sua missione. Lavorava con loro oramai da molti anni, parlava bene la loro lingua, conosceva la loro cultura.
«Tu eri impegnato con i diritti umani del popolo Warao, e stavi alzando la voce per denunciare la sempre più preoccupante tratta di persone, dai villaggi indigeni warao verso Trinidad [e Tobago]. Stavi mettendoti contro una mafia pericolosissima, alla quale il tuo presunto suicidio è convenuto tremendamente, per diffondere tra le comunità il terrore del suo potere. Perché si suiciderebbe qualcuno che si è messo in una lotta tanto ardua?», scrive l’attivista Santiago Arconada Rodriguez. I Warao mettono in dubbio il verdetto della polizia e chiedono un’inchiesta indipendente, un’autopsia indipendente. Lo stesso fanno altri movimenti indigenisti, di difesa dei diritti umani e della società civile venezuelana. Una lunga petizione è firmata da centinaia di organizzazioni e attivisti.
Grande sorriso, sempre allegro, positivo nei confronti della vita. Parlava tante lingue padre Bare Mekoro (il «Padre Nero», come lo chiamavano i Warao), e sempre con un approccio accogliente con tutti. Era keniano, ma era anche venezuelano (nel Paese dal 1997), e fiero d’esserlo.
Ricordo quando ci mostrò la sua carta d’identità di quel paese che amava. Era stato felice di tornarci, quando ci accompagnò per girare parte di «Odissea Warao» sulla migrazione warao dal delta dell’Orinoco verso il Brasile.
«Chi ha conosciuto K’Okal pensa che fosse un santo in carne e ossa. Era un uomo meraviglioso», dice un attivista che ha lavorato con lui.
Le parole di un membro della comunità Warao lo descrivono così: «Padre K’Okal ci ha insegnato ad amare la nostra gente, la nostra cultura. È stato il sale e la luce del nostro popolo, ci ha trasmesso la luce della Parola di Dio e il sale dell’allegria che spargeva ovunque andava».
Marco Bello
Torino, 19/01/2024
Una risata indimenticabile
Ancora lo ricordo mentre balla con un folto gruppo di rifugiati warao a Pacaraima, cittadina brasiliana posta sul confine con il Venezuela.
Stavamo viaggiando per documentare la migrazione di quel popolo indigeno, costretto ad abbandonare i villaggi posti lungo i canali del delta dell’Orinoco. Padre K’Okal, missionario della Consolata e antropologo, era persona fondamentale sia per aver condiviso con i Warao un lungo percorso, sia perché aveva imparato la loro lingua (come lo spagnolo, l’italiano e non so quante altre).
Nel 2022, a Quito, in Ecuador, aveva studiato alla Flacso e la sua tesi era stata proprio sui Warao rifugiati a Boa Vista («Entre vulnerabilización y resistencia estratégica: caso de los desplazados warao en Boa Vista»). Insomma, era una persona di grande intelligenza e preparazione.
Tuttavia, la cosa più bella di Josiah era la sua gioia contagiosa: sorrideva e rideva con estrema facilità e con tutti.
Padre Josiah Asa K’Okal è morto a soli 54 anni. Non di malattia e non per scelta. Una perdita pesante che in tantissimi sentiamo come una grande ingiustizia.
Paolo Moiola
Torino, 19/01/2024
ICE, Iniziative dei Cittadini Europei
Gen.mi direttore e redazione,
sono una vostra lettrice da sempre, e accolgo con gioia MC perché vi trovo parole sagge, notizie di prima mano da tantissime parti del mondo, semi di speranza, pagine di storia e di fede, presentazione di situazioni critiche analizzate senza pregiudizi né ipocrisia, rubriche interessanti. I dossier mi hanno sempre aiutata a capire meglio questo nostro mondo e talvolta li ho presentati anche a scuola (sono un’insegnante in pensione); tramite la vostra rivista sono venuta a conoscenza di problemi di cui i media più diffusi non si occupano, anche con anni di anticipo rispetto al deflagrare di una crisi.
Segno dei tempi, in una rivista missionaria trovano spazio sempre più spesso anche l’Europa e l’Italia, sia perché bisognose di una nuova evangelizzazione, sia perché terre di immigrazione.
A questo proposito mi riferisco al bell’articolo «Sostituzione etnica o necessità?» che leggo nella pagina di «E la chiamano economia» del numero di dicembre ‘23, in cui, dati alla mano, Francesco Gesualdi presenta con chiarezza la situazione italiana con l’immigrazione clandestina, il «curriculum» di Frontex, il ruolo delle Ong, e la costruzione della paura. Condivido al cento per cento la necessità di una «operazione verità» e sottoscrivo la conclusione dell’articolo: «Dovremmo togliere la questione migratoria dalle grinfie dei trafficanti di esseri umani e dei trafficanti della politica. Dovremmo riportare il fenomeno nelle nostre mani per gestirlo con spirito di umanità, solidarietà e lungimiranza». Ora, proprio a questo scopo, perché non far conoscere le seguenti Iniziative dei cittadini europei (Ice)?
La prima è «Stop border violence», nata «per costringere la Commissione europea a garantire e applicare anche nei confronti dei migranti quanto previsto nell’art. 4 della carta dei diritti fondamentali della Unione europea» (che afferma: «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti», ndr).
L’altra è «Dignity in Europe, per garantire un’accoglienza dignitosa dei migranti in Europa».
L’Ice è un prezioso strumento di democrazia partecipativa a disposizione dei cittadini dell’Ue, che possono influire direttamente sulle politiche messe a punto dalla Commissione europea, presentando richieste sottoscritte da almeno un milione di cittadini Ue in almeno sette paesi membri.
Le due Ice di cui sopra sono nate, rispettivamente in Italia e in Francia, da persone di diversa formazione, e indipendenti da partiti politici, ma accomunate dall’angoscia per le violenze subite dai nostri fratelli migranti e per i loro diritti negati.
Penso che anche questi strumenti possano contribuire a creare una società aperta, solidale, consapevole, che cura e ripara.
Grazie per l’attenzione e ancora complimenti e auguri per la rivista.
Giovanna Golzio
02/01/2024
Molte grazie per la segnalazione. Il tema dell’immigrazione ci sta ovviamente molto a cuore, essendo testimoni sul posto delle terribili e disumane realtà di tanti popoli.
Mi viene una «provocazione» leggendo l’art. 4 della carta dei diritti fondamentali della Unione europea: ho pensato che i soggetti cui riconoscere tali diritti siano molti, tra essi, ad esempio, anche i carcerati costretti a vivere in condizioni disumane (cfr. articolo del 15 gennaio in MC notizie sul nostro sito web).
Dossier sul Canada
Ciao Paolo (Moiola),
ho letto quanto hai scritto sul Canada nel dossier del mese scorso. Ho percorso con te, con l’aiuto del computer, il viaggio nell’Ovest del Paese. La lettura è affascinante; penso che anche il viaggio lo sia stato. Hai presentato in forma molto appropriata il tema dello sfruttamento minerario a scapito dell’ambiente e, sicuramente, con ritorni finanziari ingiusti in molti aspetti; la tematica della conquista e spogliazione dei popoli originari; il difficile e doloroso rapporto delle Chiese (e del governo coloniale e post) con essi.
Mi è piaciuto il riquadro sul multiculturalismo, di cui il Canada va giustamente fiero. Credo che tale tema insieme a quello del fenomeno migratorio (Toronto è la più grande «città Italiana» fuori Italia) meriti un approfondimento.
Paolo Fedrigoni, 02/01/2024, Montreal, Canada
Ho letto (il dossier) per intero. È molto, molto interessante. Non so se qualcuno ti ha detto che nella Carta canadese c’è scritto che nel nostro Paese ci sono due lingue ufficiali: l’inglese e il francese. Sono stati i francesi di François I, compreso Jacques Cartier, a dare il nome Canada al Paese. Avevano sentito gli irochesi pronunciare la parola kanata (non sapevano che significasse villaggio) ed è così che il nome è comparso (un po’ storpiato) sulle mappe. Gli inglesi vennero dopo. Mi è piaciuto molto il tuo approccio più antropologico.
Ghislaine Crête, 03/01/2024, Montreal, Canada