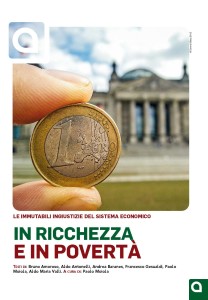Le traduzioni ci sono (ma non per i cinesi)
L’accordo tra Pechino e Vaticano sulle nomine vescovili è stato prolungato per altri quattro anni. A che punto sono le relazioni tra i due soggetti? E come stanno i cattolici cinesi? Lo abbiamo chiesto al professor Sisci.
«La Santa Sede e la Repubblica popolare cinese, visti i consensi raggiunti per una proficua applicazione dell’Accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi, dopo opportune consultazioni e valutazioni, hanno concordato di prorogarne la validità per un ulteriore quadriennio, a decorrere dalla data odierna. La Parte vaticana rimane intenzionata a proseguire il dialogo rispettoso e costruttivo con la Parte cinese, per lo sviluppo delle relazioni bilaterali in vista del bene della Chiesa cattolica nel Paese e di tutto il popolo cinese».
Così recita l’annuncio del Vaticano del 22 ottobre dello scorso anno.
Si tratta del proseguimento di un rapporto iniziato nel settembre del 2018 quando il governo cinese e le autorità vaticane siglano un accordo provvisorio sulle nomine vescovili. L’intesa non solo pone fine a decenni di ordinazioni episcopali avvenute senza il consenso papale, annullando la distinzione tra «Chiesa ufficiale» e «Chiesa clandestina», ma ricongiunge anche la comunità cattolica cinese, che conta tra sei e dodici milioni di fedeli (cfr. MC marzo).
Il significato simbolico è rilevante: per la prima volta, Pechino riconosce l’autorità religiosa del Papa in Cina, una concessione che, in epoca imperiale, i missionari gesuiti non ottennero mai.
Da quella firma a oggi sono state annunciate una decina di nomine e consacrazioni vescovili congiunte, oltre all’ufficializzazione del ruolo pubblico di alcuni presuli prima non riconosciuti da Pechino.
La crescente collaborazione è testimoniata anche dalla presenza di vescovi cinesi ai Sinodi in Vaticano e ad altri appuntamenti in Europa e America. Nonché dall’interesse della Santa Sede a cooperare con Pechino per riportare la pace in Ucraina. Nonostante i progressi, tuttavia, «rimangono tanti problemi, piccoli e grandi».
Quali siano ce lo spiega Francesco Sisci, sinologo, autore e ricercatore senior presso la Renmin University di Pechino.
Nel 1988, Sisci è stato il primo straniero a essere ammesso alla facoltà di specializzazione dell’Accademia cinese delle scienze sociali (Chinese academy of social sciences, Cass), il principale think tank cinese.
Collaboratore di diverse riviste e istituti di ricerca, nel 2016 ha realizzato la prima intervista al Papa sui rapporti con la Cina, ripresa ampiamente anche sulla stampa cinese. Storico editorialista del Sole24ore, scrive per Asia Times ed è ospite abituale della Cctv (China central television), la televisione di Stato cinese, nonché dell’emittente di Hong Kong, Phoenix tv. Il suo ultimo libro è «Tramonto italiano» (Neri Pozza, 2024).

Tra Pechino e Taiwan
Professor Sisci, l’accordo sulle nomine vescovili, già prolungato nel 2020 e nel 2022, è stato rinnovato lo scorso 22 ottobre non per i soliti due anni ma per altri quattro. Come interpreta questa scelta?
«Il prolungamento a quattro anni vuol dire, palesemente, che il rapporto è migliorato. La situazione è migliore, però non è ottimale. C’è una fiducia crescente che ha dato dei frutti: ovvero la nomina congiunta di alcuni vescovi. Non c’è stato un accordo risolutivo, conclusivo, né sono stati appianati tutti i problemi. Diversi vescovi nominati e riconosciuti a suo tempo dal Papa, non sono stati riconosciuti dal governo cinese. Rimangono poi tante altre questioni, piccole e grandi.
Ad esempio, resta insoluto il tema delle diocesi, così come il problema della conferenza episcopale. Soprattutto il Vaticano continua a chiedere di poter aprire una rappresentanza permanente a Pechino. Non un’ambasciata, bensì una rappresentanza, un ufficio culturale. Così come c’è una rappresentanza a Hong Kong che dipende dalla Nunziatura di Manila. Quindi, questo è uno dei punti in sospeso. Credo ci voglia tempo anche perché ci sono tante preoccupazioni da parte di Pechino per migliorare di più i rapporti».
Tra queste preoccupazioni figura anche Taiwan? A oggi, il Vaticano è uno dei soli dodici Stati a riconoscere ufficialmente il governo di Taipei, che Pechino definisce «separatista».
«No, perché se il problema fosse Taiwan, allora per il Vaticano il problema non esisterebbe. La Santa Sede sarebbe pronta ad aprire un ufficio a Pechino domani. È Pechino che non vuole».

La lettera di Benedetto XVI
Oltre ai rapporti istituzionali tra Pechino e il Vaticano, l’accordo sulle nomine vescovili ha portato benefici anche per la comunità cattolica cinese? C’è stato un periodo, intorno al 2014, in cui chi si dimostrava fedele al Papa – la cosiddetta «Chiesa sotterranea» – incorreva in non pochi problemi. Inoltre, nel Sud della Cina diverse chiese sono state demolite o private delle croci. Di tutto questo non si parla più da tempo.

«Stiamo parlando di due cose diverse: una sono le chiese come edifici, l’altra è la Chiesa come comunità di cattolici. Quella della “Chiesa sotterranea” era una denominazione che è durata – grossomodo – fino al 2007, cioè fino alla lettera di Benedetto XVI ai cinesi. Con la lettera il problema viene risolto de iure, perché il Papa incoraggia i cattolici cinesi a essere buoni cattolici, ma anche buoni cittadini. Quindi, per la prima volta, riconosce l’esistenza del governo di Pechino, mettendo fine a una questione molto antica che risaliva al 1951. Ovvero a quando l’ultimo nunzio del Vaticano, Antonio Riberi – che riconosceva il governo nazionalista del Kuomintang – venne espulso da Nanchino perché si era rifiutato di trasferirsi a Pechino (sede del governo comunista istituito da Mao alla fine della guerra civile, ndr).
Con il riconoscimento del governo della Repubblica popolare da parte di Benedetto XVI la “Chiesa clandestina” non aveva più ragione d’essere, perché veniva chiesto a tutti di seguire le leggi cinesi. Poi, con l’accordo sulle nomine episcopali del 2018, si è cominciato più seriamente a lavorare per riunificare la Chiesa.
Certo, come dicevamo, ci sono ancora dei vescovi nominati da Roma che non sono stati riconosciuti da Pechino. Però, non sono “clandestini”(*). Sono semplicemente riconosciuti come preti e non come vescovi. Anche perché, per la legge cinese, il riconoscimento di un vescovo significa che le proprietà della diocesi del luogo vengono intestate al vescovo che è il rappresentante legale della diocesi. Quindi, ci sono una serie di problemi di diritto e amministrazione un po’ come succede anche da noi per certi versi.
Per quanto riguarda invece le chiese intese come edifici, c’è stata una campagna che ha visto abbattere alcune croci e alcuni edifici. Però, che io sappia, questa fase è finita, non c’è più».
Anche grazie all’accordo sulle nomine episcopali?
«Credo che la campagna delle demolizioni si sia conclusa molto prima dell’accordo, che è stato raggiunto solo nel 2018».
Quindi, non le risulta che attualmente ci sia ancora una stretta sulla comunità cattolica?
«In generale c’è una stretta sulla Cina, c’è una stretta sui cinesi. I cattolici sono sottoposti a un trattamento particolarmente sfavorevole? Non credo. La Cina sta attraversando un momento particolare e i cattolici cinesi si trovano ad affrontare questo momento particolare come tutti gli altri cinesi. Non sono vessati né come i tibetani né come gli uiguri, per intenderci».
L’uso del mandarino: ma per chi?
Dal 4 dicembre 2024 l’udienza generale del Papa viene tradotta anche in cinese. Come interpreta questa decisione? A chi si rivolge il pontefice, ai cinesi all’estero o a quelli in Cina?
«Che l’udienza non fosse tradotta in cinese era una cosa strana. Il mandarino è una delle sei lingue principali dell’Onu. I tweet del Papa da sempre sono tradotti in 22 lingue, tra cui il cinese che è anche tra le 53 lingue in cui viene trasmessa Radio Vaticana. Come nel caso dell’Onu, tutto quello che viene tradotto in cinese di solito non arriva in Cina, se non attraverso Vpn (collegamento internet che permette di aggirare la censura, ndr)».
La distensione tra Cina e Santa Sede è riscontrabile anche nel crescente allineamento diplomatico su questioni di interesse internazionale.
Nel settembre 2023 il cardinale Matteo Zuppi è stato in Cina, quarta tappa della missione per la pace in Ucraina che Bergoglio gli aveva affidato. Il porporato ha incontrato il responsabile cinese per l’Eurasia, Li Hui, in «un clima aperto e cordiale». I due hanno discusso della guerra e delle sue drammatiche conseguenze, sottolineando «la necessità di unire gli sforzi per favorire il dialogo e trovare percorsi che portino alla pace». Quell’incontro ha avuto degli sviluppi?
«La comunicazione con la segreteria di Stato continua. Zuppi però era andato in Cina con un tema specifico, non per parlare di questioni bilaterali. Era andato per parlare di donne e bambini ucraini. Quindi della situazione umanitaria collegata alla guerra. Questo era lo scopo del viaggio, né più né meno. Non ho informazioni più recenti sulle interlocuzioni con la Cina, ma il Vaticano è ancora molto impegnato a livello diplomatico».

Il Vaticano è anche sempre più impegnato in Asia. Tempo fa lei scriveva che questo protagonismo della Santa Sede coincide con il declino delle istituzioni del secondo dopoguerra, come le Nazioni Unite presso cui i paesi asiatici sono sottorappresentati. Secondo lei, è un’evoluzione dovuta semplicemente al contesto internazionale attuale, qelle dinamiche mondiali? Oppure questo interesse per l’Asia nasce da un impulso personale di papa Francesco?
«Entrambe le cose. Mi sembra di sì, mi sembra ci sia stato un impulso personale. Probabilmente incoraggiato anche dal segretario di Stato Pietro Parolin. D’altro canto, Francesco voleva fare il missionario in Giappone. E poi si deve essere reso conto che la Chiesa deve essere in Asia, se non vuole rischiare di diventare marginale. È una questione di numeri, di demografia».
In un suo articolo pubblicato su SettimanaNews ha fatto anche riferimento al fatto che, in Asia, la Chiesa cattolica può fare leva su due elementi: uno è l’Eucaristia, ovvero un rito nel quale Dio si offre per essere consumato e sacrificato, interrompendo così il ciclo della vita e della morte, che rappresenta un tema centrale nelle filosofie orientali come nell’induismo, nel buddhismo e nel taoismo.
L’altro è la confessione, che potrebbe compensare la circolazione di pratiche psicoterapeutiche che lasciano le persone con un senso di solitudine, senza un perdono specifico.
«Sì, ci possono essere degli elementi di contatto nelle varie culture asiatiche. I cinesi, ad esempio, si stanno avvicinando solo ora alla psicoterapia, che può essere considerata un’evoluzione della confessione. Quest’ultima però ha il vantaggio che prevede anche un’assoluzione esterna, mentre la psicanalisi potrebbe risultare non risolutiva per il paziente, che deve trovare una sua strada. Insomma, elementi interessanti. Però, bisogna lavorarci, non è una cosa così ovvia».
Il ruolo dei cardinali asiatici
Professore, pensa che, al di là di papa Francesco, ci sia una disposizione del Vaticano a proiettarsi verso l’Asia? Il lavoro di Bergoglio ha messo basi sufficientemente solide perché quest’opera di evangelizzazione sopravviva all’arrivo di un altro pontefice?
«Francesco sta facendo molti cardinali in Asia: ha nominato un cardinale in Mongolia (monsignor Giorgio Marengo, missionario della Consolata, ndr), uno in Laos. Ha fatto un cardinale in Bangladesh, e un altro a Teheran.
Per la prima volta abbiamo una folla di cardinali asiatici. Questi devono diventare delle teste di ponte della Santa Sede e del cattolicesimo in Asia. Lo saranno? Vedremo. Naturalmente non è una cosa di due giorni: è una cosa di venti anni o anche duecento».
Alessandra Colarizi
(seconda parte – fine)
(*) A inizio marzo, è stato arrestato monsignor Pietro Shao Zhumin, vescovo di Wenzhou.