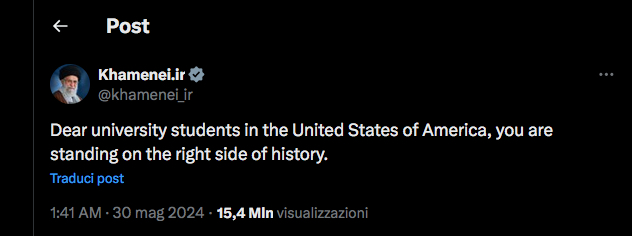Dall’occupazione cinese del 1950, il Tibet sta subendo un modello di sviluppo degradante e impoverente. L’industria estrattiva, energetica, delle comunicazioni e, ultimamente, quella turistica, procurano danni gravi. Non solo ambientali, ma anche culturali, religiosi, sociali ed etnici. Al punto che gli abitanti della regione a volte non si sentono né cinesi, né tibetani.
«Martedì 20 novembre 2012 un ragazzo tibetano […] ha preso un sentirnero su per la collina fino all’ingresso della miniera d’oro a Gyagar Thang, si è versato kerosene su tutto il corpo e si è dato fuoco». Secondo il Tibetan Centre for Human Rights, il venticinquenne ha voluto denunciare il disagio delle comunità locali colpite dalle operazioni minerarie delle aziende cinesi nella zona.
«Il numero di tibetani che si sono autornimmolati negli ultimi anni sta aumentando a un ritmo allarmante», afferma un articolo firmato nel 2013 dal Tavolo ambiente e sviluppo del Goveo tibetano in esilio a Dharamsala, in India, e prosegue: «Oltre ai fattori politici, sociali, religiosi ed economici, una delle cause principali di tale disperazione sono le attività di estrazione e di inquinamento in Tibet». Il dolore causato dal deterioramento degli equilibri ecologici locali e dei modi di vita tradizionali porta alcuni ad atti estremi di dissenso. L’occupazione cinese del Tibet nel 1950 ha aperto la porta allo sfruttamento sistematico dei minerali di cui è ricco (rame, oro, cromite, alluminio, ferro, boro, piombo, zinco, litio), ma anche del petrolio greggio, del potassio, amianto, gas naturale e carbone. L’inquinamento dell’acqua e l’impatto delle centrali idroelettriche per fornire energia alle miniere e, non ultimo, l’aumento del turismo cinese, facilitato dall’apertura di ferrovie e strade, aggravano le condizioni di vita delle popolazioni locali. In più, per facilitare l’estrazione delle risorse naturali, le autorità costringono i nomadi a stabilirsi in villaggi costruiti ad hoc dove perdono le loro pratiche tradizionali e quindi i loro riferimenti culturali.
A Dharamsala abbiamo parlato di questi problemi con Tempa Gyaltsen Zamlha, ricercatore del Tavolo dell’Ambiente del Tibet Policy Institute (presso il governo tibetano in esilio).
Ci può spiegare il suo lavoro al Tavolo ambiente e sviluppo e i suoi principali obiettivi?
«Il Tavolo è stato istituito nell’ambito del Policy Institute tibetano a Dharamsala: da qui monitoriamo la situazione ambientale in Tibet. Cerchiamo anche di informare la comunità internazionale sull’importanza ecologica dell’altipiano del Tibet a livello mondiale. Ci rivolgiamo particolarmente al governo e alla popolazione cinese. Il nostro obiettivo è quello di proteggere l’altipiano più alto e più esteso del mondo, che ospita la più grande concentrazione di ghiacciai dopo i due poli, e anche la sorgente dei fiumi più importanti dell’Asia. Lavoriamo anche perché la civiltà tibetana, che ha prosperato per migliaia di anni, possa continuare a vivere una vita sana e felice, e anche perché le nazioni a valle continuino a godere dei fiumi da cui le loro civiltà dipendono.
Per i tibetani, la missione ambientale è uno dei compiti più urgenti. Sua Santità (il Dalai Lama) ha detto una volta che la questione politica può attendere, ma non l’ambiente».
Quali sono le principali sfide ambientali di oggi per il Tibet?
«Le principali minacce sono i cambiamenti climatici, ma anche l’impatto umano, in particolare l’eccessiva attività mineraria.
Come tibetani, abbiamo un rapporto molto intimo con la natura, perché crediamo che Dio sia presente in tutto, nelle montagne come nei fiumi.
Le cose sono radicalmente cambiate dall’occupazione cinese del Tibet nel 1950. Ad esempio sono state costruite strade e linee ferroviarie che rendono l’estrazione molto più facile, economica e redditizia. Inoltre, la Cina ha costruito molte centrali idroelettriche, indispensabili per l’industria».
«I tibetani non sono contro l’estrazione di per sé, ma contro l’estrazione nei pressi di villaggi, di corpi idrici, di montagne sacre o di praterie usate dai nomadi. Per le attività minerarie nella vasta pianura del Nord dove c’è meno popolazione, non c’è quasi nessuna protesta.
Le montagne sacre hanno un forte legame storico, culturale, politico e spirituale con la vita del popolo tibetano. Non lontano da Lhasa (capitale del Tibet cinese), ad esempio, si trova il Monte Yarlha Shampo. Esso era la residenza di un dio della religione tradizionale Bon. Il primo dei sette ministri nobili nella storia del Tibet che nel 7° secolo d.C. hanno contribuito alla ricostituzione del regno, era considerato figlio di Yarlha Shampo. Ci sono molte montagne sacre simili in Tibet, che sono rispettate e protette dalla gente».
Che legame c’è fra la sacralità di un monte e la resistenza ambientale delle comunità?
«La credenza nella sacralità di un luogo svolge un ruolo importante nella sua conservazione e protezione. La biodiversità in queste aree è infatti più elevata: la gente cerca di non tagliare alberi o cacciare animali. Non tutte le montagne sono considerate sacre, ma se studiamo la posizione dei siti sacri saremo sorpresi di notare che corrispondono alle zone più importanti dell’ecosistema locale, alla montagna con più ghiacciai, al lago che è fonte di molti fiumi, a una zona umida che sostiene la vegetazione nella regione. La credenza nella sacralità di una montagna è un fenomeno antico e anche molto intelligente: è grazie a questo che i tibetani hanno preservato gli ecosistemi per migliaia di anni, nonostante le dure condizioni climatiche, a una quota tanto estrema».
Ma ora le cose stanno cambiando. E rapidamente.
«Le compagnie minerarie cinesi stanno entrando in questi territori. I nomadi tibetani sono stati sfollati e reinsediati altrove dal governo cinese. Ogni volta che le comunità locali resistono, vengono prima di tutto invitate ad andarsene, poi le aziende cercano di convincerle dell’importanza del progetto per il loro sviluppo. Se l’opposizione persiste, cercano di dividere i membri della comunità offrendo denaro o altro, infine passano al dispiego delle forze di polizia.
È molto importante per noi rendere note queste informazioni al mondo esterno e al governo cinese. Il mondo ha la responsabilità di reagire.
Negli ultimi anni ci sono stati molti progetti di estrazione su larga scala, ma solo pochi tibetani vi lavorano. La maggior parte dei lavoratori vengono dalle province cinesi. Sono i governi locali, oltre alle società, che beneficiano dell’estrazione mineraria in aree tibetane, non la comunità».
Miniere e costruzione di grandi infrastrutture sono la causa di un gran disagio sociale in tutto il mondo, anche a causa degli sfollamenti su larga scala. È questo il caso anche del Tibet?
«Sì, lo spostamento di intere comunità avviene regolarmente in Tibet. I nomadi, che normalmente si trasferiscono in un sito di pascolo diverso ogni tre mesi, al fine di non esaurire le risorse, si ritrovano costantemente a confrontarsi con le compagnie che invadono la loro terra con l’appoggio del governo. Per accelerare questo processo, la Cina ha introdotto politiche di reinsediamento in villaggi construiti appositamente, con case addossate le une alle altre e servizi mal funzionanti, e con specifiche restrizioni sull’uso della terra. Si tratta di uno sfollamento non solo da un luogo, ma da uno stile di vita.
Il governo cinese sostiene poi che i nomadi devono essere modeizzati, i bambini educati, e che ciò è più facile quando la popolazione vive concentrata in un villaggio. Ma abbiamo le prove che la vita in questi villaggi si è deteriorata. Le persone diventano dipendenti dai sussidi del governo e perdono le loro fonti di indipendenza economica (bestiame, praterie, ecc.), cosa che fa aumentare l’alcolismo e la prostituzione.
Quello che il governo cinese ha fatto è spingere i nomadi nella povertà assoluta».
Ha citato anche il turismo come problema ambientale urgente. Da dove vengono questi turisti e cosa cercano?
«Il problema del turismo in Tibet sta nella sua concentrazione in alcune zone e nella brevissima stagione estiva, con dei numeri enormi di visitatori. Recentemente la Cina ha attivato percorsi per visitare laghi sacri e altri importanti siti ambientali, cosa che ha avuto un impatto grave per le persone e la terra.
Il turismo crea poca ricchezza e lavoro per i tibetani locali. La maggior parte dei turisti in Tibet sono cinesi che viaggiano con pacchetti giornalieri prenotati attraverso agenzie di viaggio cinesi che prenotano alberghi cinesi, autisti cinesi e guide cinesi e mangiano in ristoranti cinesi. Così la maggior parte del denaro speso dai turisti cinesi che viaggiano in Tibet torna in Cina».
Il suo lavoro nel documentare resistenze socio ambientali in Tibet è abbastanza unico. Ci racconta un caso?
«Il più noto è probabilmente quello della miniera Gyama Copper Gold Polymetallic Mine in una zona ricca di rame, zinco, piombo, litio, vicino a Lhasa, la capitale. Il governo l’ha dichiarata miniera modello nonostante le vicine comunità abbiano protestato per più di cinque anni denunciando i disagi creati alla vita nomade e l’inquinamento delle acque del vicino fiume. Nel 2013 un’enorme frana ha ucciso più di 80 lavoratori nei pressi della miniera. Anche se il governo sostiene che la frana sia stata causata da fattori naturali, noi abbiamo le prove che la causa primaria è stata una cattiva gestione della miniera».
Esiste una rete di persone che si batte per l’ambiente in Tibet? Le Ong ambientaliste in Cina e in Tibet possono allearsi per la giustizia ambientale e sociale?
«Ci sono buone Ong ambientali in Tibet, ma la maggior parte di esse sono state costrette a chiudere dopo le proteste del 2008. Ci sono anche alcune buone Ong ambientali cinesi che lavorano in Tibet. Il problema è che quando una Ong sta facendo un grande lavoro sociale e ambientale, il governo locale cerca in diversi modi di farla chiudere etichettandola come separatista. Qualsiasi collaborazione sarà quindi abbastanza problematica».
In Europa e altrove si dibatte su decrescita o visioni alternative di sviluppo. Qual è il tuo pensiero in merito?
«Questo è qualcosa su cui qui discutiamo molto. Ci chiediamo “qual è lo sviluppo per tutti? Non è semplicemente essere felici? Cosa succede quando a qualcuno non va bene il tuo modo di intendere lo sviluppo, come ad esempio ai nomadi?”. Sviluppo, per me, dovrebbe essere il livello di soddisfazione di te come persona. Per i tibetani, i nomadi sono persone felici perché hanno le loro risorse e la libertà. Diciamo anche che non dovremmo cercare di imporre un’unica definizione di felicità su tutti. Lasciate che ognuno trovi la sua strada, e rispettate la vita. Naturalmente, non tutto ciò che è antico è buono di per sé, ma cerchiamo la parte buona di questo passato e preserviamola. A volte i tibetani non si sentono abbastanza cinesi per fare le cose cinesi, e non abbastanza tibetani per vivere come vivevano i loro antenati. Tra i due, il rischio è di non sentirsi più nessuno.
Daniela Del Bene
Co-editrice di Ejatlas
Per approfondire
Environmental and Development Desk, http://tibet-edd.blogspot.com.es/.
Documentario Shielding the Mountains, regia di Kunga Lama. Prodotto da Emily Yeh.
Tibet Centre for Human Rights and Democracy, Imposing Modeity with Chinese Characteristics, Dharamsala 2011.
Jampel Dell’Angelo, The sedentarization of Tibetan nomads: conservation or coercion?, p. 309-332 in H. Healy et al, Ecological Economics from the Ground Up, Routledge, London, 2012.
We are here to stay, documentario prodotto dal progetto Lamca-Ejolt.
Archivio MC:
Interviste con il Dalai Lama, ott.-nov. 2001 e giu. 2013;
Lhasa, nella morsa di Pechino, mar. 2010;
Contro Pechino a costo della vita, dic. 2012.
Atlante della Giustizia Ambientale
Questo è il quarto articolo di una collaborazione fra la rivista Missioni Consolata e l’Ejatlas (Environmental Justice Atlas). Nei prossimi numeri verranno pubblicate altre storie e analisi regionali di alcuni dei conflitti ambientali che compaiono nell’Atlante. Per tutti i casi menzionati nell’articolo sono disponibili nell’Atlas le relative schede informative.
Sotto il giogo cinese
Il Tibet è una regione dell’Asia centrale, grande quattro volte e mezzo l’Italia, con un’elevazione media di 4.500 metri sul livello del mare, appartenente per la gran parte alla Cina, in piccola parte all’India. La parte cinese, che nel 2005 contava 2.740.000 abitanti, chiamata ufficialmente Xizang, fu occupata dalla Repubblica Popolare Cinese nell’ottobre 1950 e dichiarata regione autonoma nel 1965. La sua capitale Lhasa (3.650 metri sul livello del mare) conta circa 200mila abitanti.
Dal 1951 è iniziata l’immigrazione dalle altre regioni cinesi. Tanto che oggi i non autoctoni, prevalentemente militari e coloni agricoli e tecnici delle attività industriali, costituiscono circa il 20% della popolazione. All’aumento dell’immigrazione corrisponde una notevole emigrazione di tibetani verso altri paesi: sono circa 2 milioni i tibetani che vivono fuori dal Tibet.
Tra la popolazione autoctona sono ancora presenti gruppi di nomadi che vivono di pastorizia. Prima dell’annessione alla Cina nel 1951, la classe monacale buddista, che contava circa un ottavo della popolazione complessiva, era molto potente, tanto da conferire allo stato tibetano un carattere teocratico, con a capo il massimo esponente spirituale, il Dalai Lama. Dall’anno dell’annessione, la Cina, ignorando le istanze indipendentiste dei tibetani, iniziò un programma di sviluppo che venne osteggiato dalla popolazione locale fino alla rivolta di Lhasa del 1959 che venne repressa dal regime cinese costringendo alla fuga il 14° Dalai Lama, Tenzin Gyatso, in India, a Dharamsala, dove costituì il governo tibetano in esilio.
Nei decenni successivi la Cina ha continuato a intensificare l’attività di sviluppo e integrazione del Tibet allo scopo di omologare sempre più (anche sul piano culturale ed etnico) la regione al resto della Repubblica popolare. Un ultimo tentativo di rivolta nella regione è stato quello del 2008, represso con la violenza dal governo comunista.
L’attuale posizione del Dalai Lama, che nel 2011 ha rinunciato al potere politico, affidando la guida del governo in esilio a Lobsang Sangay, riguardo alla questione tibetana è quella da lui stesso denominata «la via di mezzo», per un Tibet con un alto grado di autonomia all’interno della Repubblica popolare cinese: «Sono finiti i giorni in cui si assisteva alla vittoria di una parte e alla totale sconfitta dell’altra – ha ribadito il 13 settembre scorso in una conferenza a Parigi -. È necessaria una riconciliazione, altrimenti la nostra lotta non avrà successo».
La religione prevalente del Tibet è il buddismo tibetano, introdotto nella regione nell’8° secolo d.C. Accanto al lamaismo sono presenti la religione autoctona, il Bon, ed elementi di sciamanismo.
Luca Lorusso