Taiwan. In gioco la stabilità mondiale?
Il dibattito è stato dominato dal tema delle relazioni intrastretto, su cui sono emerse le grandi differenze tra i candidati. Tutti e tre dicono di voler mantenere lo status quo, ma ognuno propone una ricetta diversa per farlo, svelando non solo diverse strategie politiche, ma anche un diverso sentimento identitario sul sottile filo che corre tra il definirsi «cinese» oppure «taiwanese».
Il favorito, Lai Ching-te del Partito progressista democratico (Dpp, sigla in inglese), ha giocato in difesa. Noto per le sue posizioni a favore dell’indipendenza formale di Taiwan, l’attuale vicepresidente ha provato a porsi in perfetta continuità con la presidente uscente, la moderata Tsai Ing-wen. Durante il dibattito, Lai ha ribadito l’impegno a mantenere la pace e si è detto disposto al dialogo con Pechino, ma senza fare concessioni sulla sovranità e soprattutto sottolineando la necessità del rafforzamento dell’esercito e di nuovi acquisti di armi dagli Stati Uniti. Ha poi attaccato i rivali definendoli «filocinesi», presentando il voto come una «scelta tra democrazia e autoritarismo», e alludendo dunque a un possibile rischio di «inglobamento» in caso di vittoria del Kuomintang (Kmt), il partito nazionalista tradizionalmente più dialogante con Pechino.
Hou Yu-ih, il candidato del Kmt, ha invece descritto le elezioni come una «proposta» di Xi Jinping: ha infatti reiterato il rifiuto a «un paese, due sistemi», il modello di fatto fallito a Hong Kong che Pechino vorrebbe applicare anche a Taiwan.
Il terzo incomodo, Ko Wen-je, è in realtà apparso a molti come il più convincente dei tre durante il dibattito. Soprattutto dai più giovani che hanno commentato sui social. Ko, ex sindaco di Taipei e leader del Taiwan People’s Party (Tpp), si racconta come l’unica possibile novità nel tradizionale bipolarismo taiwanese. Durante il dibattito ha più volte esaltato il suo Sui rapporti intrastretto descrive il Dpp come «troppo anticinese» e il Kmt «troppo filocinese», proponendosi come depositario della linea di «riduzione del rischio», coniata da Unione europea e Stati Uniti: «Taiwan può diventare un ponte tra Washington e Pechino invece che un punto di tensione», sostiene, anche se non ha elaborato una proposta concreta per riavviare il dialogo.
Il favorito è senza dubbio Lai, che negli ultimi sondaggi disponibili era dato in vantaggio con una forbice che a seconda dei casi variava tra i 3 e i 10 punti. Al secondo posto Hou, con Ko non lontano. L’alleanza tra i due, naufragata a fine novembre, avrebbe con ogni probabilità messo fine al dominio del Dpp che dura dal 2016. Portando a un abbassamento delle tensioni militari con Pechino, ma a un prevedibile aumento del pressing politico per arrivare a un accordo che lo stesso Kmt non può garantire. Nel discorso di fine anno, Xi Jinping ha ribadito che la «riunificazione è una necessità storica». Un avvertimento che non cambierà i calcoli dei taiwanesi alle urne.
Molto importante poi il risultato delle elezioni legislative. Secondo tutte le proiezioni, nessun partito dovrebbe avere la maggioranza allo yuan legislativo (il parlamento unicamerale). Ciò significa che un’ipotetica presidenza Lai partirebbe azzoppata, con potenziali problemi nel far passare una serie di riforme e provvedimenti, a partire da quelli in materia di difesa. Uno scenario instabile che potrebbe non dispiacere a Pechino, che potrebbe provare a far leva sulle divisioni interne per guadagnare posizioni anche a livello politico.
Lorenzo Lamperti, da Taipei
«Se voterò? Ma certo, anche se penso che non cambierà molto». E invece potrebbe cambiare tanto, forse tutto. Stacy, 27 anni, parla sotto il cocente sole estivo di Taipei mentre cammina su Ketagalan Boulevard insieme ad altre migliaia di persone. Sono tutti lì per protestare contro il governo taiwanese. Le motivazioni sono diverse. Lei in particolare chiede la riforma del sistema di edilizia pubblica. «Per i giovani è impossibile comprare una casa», dice.
Di fronte, il palazzo presidenziale costruito dall’architetto Uheji Nagano per ospitare il governatore dell’era coloniale giapponese (1895-1945). Alle spalle, non troppo lontani, Liberty Square e il memoriale di Chiang Kai-shek, capo del partito nazionalista cinese (Kuomintang, Kmt) che si rifugiò a Taiwan dopo aver perso la guerra civile con il Partito comunista di Mao Zedong (1949). Restò al potere fino alla morte, nel 1975, e guidò il regime autoritario nella Repubblica di Cina, nome con cui Taiwan è indipendente de facto. La legge marziale era stata imposta nel 1947 e restò in vigore fino al 1987. Non si poteva votare.

Il 13 gennaio prossimo, i cittadini dell’isola principale di Taiwan e delle isole minori (da Kinmen alle Matsu, dalle Penghu a Green Island) andranno alle urne per le elezioni presidenziali. Nella prospettiva molto concreta e disillusa di Stacy, chiunque vincerà non risolverà i suoi problemi. Ma in una prospettiva più ampia, il voto taiwanese potrebbe essere il più importante del 2024 a livello mondiale. Può sembrare un azzardo dirlo, soprattutto considerando che a novembre del prossimo anno sono in programma le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Ma la Repubblica popolare cinese, la Cina continentale guidata da Xi Jinping, sa che la postura statunitense le resterà piuttosto ostile, a prescindere da chi sarà l’inquilino della Casa Bianca. L’esito del voto taiwanese può invece cambiare, e di molto, le relazioni sullo stretto (lo stretto di Taiwan, tra l’isola principale e il continente, ndr) viste le nette differenze tra i vari candidati e gli equilibri mondiali potrebbero modificarsi verso un maggior peso della Cina popolare.
«Ho sempre votato per il Dpp (Partito progressista democratico, indipendentista, ndr), ma stavolta ho paura che se vince ancora potrebbe davvero esserci la guerra», dice Tzu-sheng, architetto di 42 anni. «Ho paura che se vince un candidato dell’opposizione ci svendano a Pechino», dice invece Jiaqi, lavoratrice dell’industria dell’intrattenimento locale. Due visioni antitetiche che rimandano al modo in cui i due partiti principali presentano il voto (Dpp, al potere, più lontano da Pechino, e Kmt, opposizione, più vicino, ndr).
Si ricorda che Taiwan, pure essendo indipendente de facto, è riconosciuta da soli 13 paesi al mondo, mentre la Cina popolare la considera proprio territorio. Da tempo, il Kmt parla di una «scelta tra guerra e pace». Una definizione lanciata da Ma Ying-jeou, ex presidente e unico leader di Taipei ad aver incontrato un omologo di Pechino (Xi Jinping, nel 2015 a Singapore). Ma anche unico ex presidente a essere andato in Cina continentale, in un significativo viaggio effettuato lo scorso marzo. Proprio mentre l’attuale presidente Tsai Ing-wen (Dpp) effettuava un contestato doppio transito negli Stati Uniti, durante il quale ha incontrato lo speaker del Congresso americano Kevin McCarthy (esautorato lo scorso ottobre, ndr).
Lai Ching-te, attuale vicepresidente e candidato della maggioranza Dpp, parla invece di «scelta tra democrazia e autoritarismo». Il Kmt dice dunque che in caso di nuova vittoria del Dpp si rischia un conflitto sullo stretto. E che sarebbe sostanzialmente provocato da un governo taiwanese incapace di mantenere il dialogo con Pechino. Il Dpp suggerisce invece che in caso di ritorno al potere del Kmt (che non governa dalle elezioni del 2016), Taiwan potrebbe avvicinarsi in qualche modo al modello di Hong Kong, venendo assorbito nella Cina continentale.
Due visioni estreme, che seguono la tradizionale contrapposizione del bipolarismo taiwanese. Un bipolarismo nel quale è impossibile trovare una sintesi, perché la visione è opposta non solo su temi concreti, come le relazioni intrastretto, ma anche sul senso di sé e della propria identità. Sostenere uno o l’altro partito non è solo una scelta politica, ma tocca un livello più intimo che lambisce quello storico culturale.

Il Kmt è erede del partito fondato da Sun Yat-sen che governò la Cina continentale fino alla vittoria dei comunisti nella guerra civile (1949). Non solo propone un dialogo più fruttuoso con Pechino, ma continua a vedere Taiwan come parte della Cina. Non la Repubblica popolare cinese, ma la Repubblica di Cina, di cui ormai non restano che frammenti, ma la cui architettura formale e lessicale tutela secondo il Kmt il mantenimento dello status quo. In che modo? Sulla base del cosiddetto «Consenso del 1992», un accordo tra funzionari di Kmt e Partito comunista che riconosce l’esistenza di un’unica Cina ma «con diverse interpretazioni». In sostanza, i due ex rivali della guerra civile nel 1992 riconobbero di far parte tutti di una stessa entità ma senza mettersi d’accordo su quale fosse la sua espressione politica e istituzionale legittima. Un’ambiguità voluta per mantenere in piedi lo status quo, ma che Pechino è sempre stata convinta giocasse a suo favore. Il ragionamento è il seguente: se a Taipei riconoscono che esiste una sola Cina e nel mondo quasi tutti i paesi (tranne 13) riconoscono Pechino come governo legittimo della Cina, prima o poi la riunificazione (o unificazione, come la chiamano a Taiwan) sarà una conseguenza naturale. Questo principio non è però riconosciuto dal Dpp di Tsai. L’attuale presidente è espressione della parte più moderata del partito, quella che non persegue l’indipendenza formale come Repubblica di Taiwan (che segnerebbe una cesura definitiva e inaccettabile per Pechino) ma che sostiene la cosiddetta «teoria dei due stati». In sostanza, Tsai non riconosce che le due sponde dello stretto facciano parte di una «unica Cina» ma si dice aperta al dialogo qualora Pechino non ponga precondizioni e riconosca l’esistenza di due entità non interdipendenti. Da qui l’assenza totale di dialogo politico tra i due governi dal 2016, da quando cioè Tsai è stata eletta per la prima volta. In questi anni, l’ecosistema sullo stretto è molto mutato. Da una parte, Pechino ha operato un’escalation coercitiva su diversi piani. A livello diplomatico, ha portato nove paesi a rompere i rapporti diplomatici ufficiali con Taipei e a stabilirne con la Repubblica popolare. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’Honduras, che proprio alla vigilia della partenza di Tsai per l’America centrale, lo scorso aprile, ha annunciato l’avvio delle relazioni con Pechino. Ma nel mirino ci sarebbe anche il Guatemala.
Lai, membro del Dpp come Tsai e suo potenziale successore, è invece particolarmente inviso a Pechino perché è considerato più radicale. Questo soprattutto per alcune sue dichiarazioni passate, in cui si era raffigurato come un «lavoratore per l’indipendenza di Taiwan». Cosa ben diversa dal riconoscere e dire di voler tutelare la sovranità de facto di Taiwan come Repubblica di Cina, la posizione ufficiale di Tsai e oggi dello stesso Lai che ha molto smussato la sua retorica e le sue esternazioni sulle relazioni intrastretto da quando è vicepresidente.
Ma a Pechino ricordano che nel 2019, il detestato partito di maggioranza fu sull’orlo della scissione per i contrasti tra l’ala radicale di Lai e quella più moderata di Tsai. Ad agosto, anche Lai ha effettuato un doppio transito negli Usa (dal profilo molto più basso rispetto a quello di Tsai) nell’ambito di un viaggio in Paraguay. Si è impegnato a presentarsi in continuità con Tsai, ma poco prima di partire si è lasciato sfuggire il desiderio che il futuro presidente taiwanese potesse entrare alla Casa Bianca. Eventualità che significherebbe un riconoscimento ufficiale incompatibile con lo status quo.
A Pechino queste uscite fanno comodo per descriverlo come «secessionista» nel messaggio rivolto all’esterno per giustificare le proprie reazioni coercitive, anche se sui media di stato c’è chi sostiene che di Lai non si fiderebbero nemmeno gli Usa, in un messaggio stavolta rivolto al pubblico interno e taiwanese.
Hou è invece il sindaco di Nuova Taipei, limitrofa alla capitale. Direttore generale dell’Agenzia nazionale di polizia tra il 2006 e il 2008, si riteneva potesse avere simpatie per il Dpp, ma è entrato invece nella fila del Kmt. Il suo passato di uomo di legge e di ordine sembrava piacere a molti, anche se per gli elettori Dpp il fatto che Hou sia stato poliziotto durante e dopo il periodo della legge marziale (1947-1987, vedi cronologia, ndr) è problematico. Molti lo ricordano come l’ufficiale che nel 1989 guidò la carica nell’ufficio di Cheng Nan-jung, un editore indipendentista che si auto immolò nel suo ufficio piuttosto che lasciarsi arrestare.
A complicare le ambizioni di Hou c’è anche un terzo incomodo, molto ingombrante. Si tratta di Ko Wen-je, popolare medico ed ex sindaco di Taipei che da qualche anno ha lanciato il suo Taiwan people’s party (Tpp). Ko propone una terza via rispetto a Dpp e Kmt. Il primo troppo ostile a Pechino, il secondo troppo asservito, dice lui. E quando propone un maggiore dialogo con il Partito comunista, a molti elettori suona più credibile rispetto al Kmt. Questo perché, a differenza di quest’ultimo, non ha il retaggio storico della legge marziale e il senso di appartenenza esplicito alla sfera storico culturale cinese.
Il Tpp sta attuando una campagna molto aggressiva e sembra piacere ai giovani oltre che alla classe imprenditoriale. Aver guidato Taipei è un biglietto da visita importante, nella zona dove gli affari intrastretto sono più intensi. Messo alle strette sul «consenso del 1992», nodo della discordia, se l’è cavata fin qui dicendo che, prima di esprimersi, a riguardo dovrebbe parlare con Xi per capire come lo intende Pechino.
Basterà a vincere? Difficile, se i candidati dell’opposizione resteranno tre, contro il solo Lai, a occupare tutto lo spazio dello spettro «verde», quello più incline al riconoscimento di Taiwan.
Già, perché il Kmt (come già altre volte in passato) si è diviso. Il candidato sconfitto al processo di selezione interno del partito, Terry Gou, è sceso in campo come indipendente. Con l’obiettivo, dice, di unire tutto il campo anti Dpp. Gou è il fondatore e patron della Foxconn, gigante dell’elettronica e primo fornitore di iPhone per Apple. Ma ha anche enormi interessi in Cina continentale, dove si trovano ancora la maggior parte dei suoi impianti. Tra cui quello immenso di Zhengzhou, ribattezzato «iPhone City».
«Non lascerò che Taiwan diventi la prossima Ucraina. Anzi, farò sì che Taiwan superi Singapore nel giro di 20 anni e abbia il più alto Pil pro capite in Asia», sono le due impegnative promesse elargite nella conferenza stampa di agosto in cui ha sciolto la riserva sulla sua candidatura. Il rischio, dunque, è che la discesa in campo di Gou possa ulteriormente frammentare la scelta anti Dpp e favorire lo stesso Lai.
Secondo diversi sondaggi, in uno scenario a quattro candidati (inedito per Taiwan) il vantaggio dell’attuale vicepresidente sembra destinato infatti ad allargarsi. Per avere speranze, Gou dovrebbe raggiungere un accordo con Hou o Ko, oppure con entrambi. Una sua eventuale ascesa alla presidenza non dispiacerebbe a Xi. E, probabilmente, neppure a Donald Trump, che nel 2019 accolse il «vecchio amico» Gou alla Casa bianca, dove il tycoon potrebbe rientrare nel gennaio 2025.

L’esito delle elezioni potrebbe cambiare di molto le dinamiche intrastretto.
È probabile che, dopo il voto, Xi aumenterà il pressing. Militare e strategico in caso di vittoria del Dpp, che per la prima volta da quando si svolgono le elezioni libere (dal 1996) potrebbe vincere per la terza volta consecutiva le presidenziali.
In caso di vittoria del Kmt, invece, il pressing sarebbe politico, per sottoscrivere accordi o ottenere garanzie di rilievo sul riavvicinamento.
«La Cina non rinuncerà al suo obiettivo di unificazione a prescindere che ciò avventa con i negoziati o con la forza. Nei prossimi anni, le relazioni tra le due sponde dello stretto saranno influenzate dalla competizione strategica tra Washington e Pechino, ma anche dalla saggezza e dalla capacità di Taiwan di gestire questa difficile relazione», sostiene Alexander Huang, direttore del dipartimento internazionale del Kmt e suo rappresentante negli Stati Uniti. «Una vittoria del Kmt ridurrebbe in larga misura la tensione attraverso lo stretto, quantomeno nel breve termine», aggiunge. «Sì, ma a patto di cedere pezzi della nostra sovranità de facto», dicono i sostenitori del Dpp. Prospettive e scenari diversi, che possono avere un impatto anche a livello globale.
Lo stretto di Taiwan non è solo una fondamentale via di passaggio delle merci, ma anche uno degli snodi principali del commercio globale. Per non parlare dell’industria strategica dei semiconduttori, di cui Taiwan è la capitale mondiale del comparto di fabbricazione e assemblaggio.
Secondo alcuni studi, se il G7 sanzionasse la Cina continentale in caso di crisi su Taiwan, l’economia globale perderebbe almeno tremila miliardi di dollari, equivalenti al Pil del Regno Unito nel 2022. Peggio della guerra in Ucraina. Senza contare il rischio di espansione di un ipotetico conflitto con coinvolgimento di paesi limitrofi come il Giappone, o persino degli Stati Uniti in quello che potrebbe diventare un confronto diretto tra le due potenze.
La speranza è che Taiwan diventi, come sostengono tutti i candidati alle presidenziali pur con ricette diverse, un elemento di stabilità nello scenario regionale e globale.
Sì, il 13 gennaio prossimo può cambiare tanto.
Lorenzo Lamperti
L.L.

Scudo di silicio. Oppure montagna sacra che protegge Taiwan. O, ancora, petrolio elettronico. Sono alcuni dei modi con i quali viene indicata la produzione taiwanese di semiconduttori, capitolo sempre più strategico della contesa tecnologica globale.
Le aziende taiwanesi controllano oltre il 65% dello share globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio dei microchip. Il dominio è ancora più esteso dal punto di vista qualitativo: i produttori taiwanesi detengono il 92% della manifattura di chip sotto i dieci nanometri. Praticamente la totalità, assieme a quelli sudcoreani. Se ci fosse una capitale mondiale dei semiconduttori, sarebbe il Science park di Hsinchu. In un’area di 1.400 ettari operano circa 400 compagnie high-tech che generano oltre il 10% del pil e più del 30% dell’export di Taipei. Quando è stato fondato nel 1980, il parco era una landa desolata. Oggi è considerata la Silicon Valley taiwanese. Nessuno può prescindere dal «petrolio elettronico» prodotto a fiumi in questi impianti.
Soprattutto dalla Taiwan semiconductor manufacturing company, Tsmc, che da sola fabbrica oltre il 50% dei chip al mondo. Il suo fondatore è Morris Chang, ultranovantenne che ancora oggi svolge un ruolo di «ambasciatore» di Taiwan in consessi internazionali come i summit dell’Apec (Asia Pacific economic cooperation). Qui, a Bangkok, ha avuto nel 2022 un colloquio con Xi Jinping. In assenza di dialogo politico tra i governi, i colossi dei chip svolgono un ruolo diplomatico tra le due sponde dello stretto.
La stessa Tsmc ha stabilimenti in Cina e i semiconduttori taiwanesi continuano a fluire verso il «continente». Ma da alcuni anni gli Usa stanno provando a recidere quel cordone tecnologico. Tra 2024 e 2025 dovrebbe aprire la prima fabbrica di Tsmc in Arizona, mentre la Casa bianca impone nuove restrizioni per provare a tagliare fuori la Cina dalle catene di approvvigionamento.
Taiwan vorrebbe continuare a esportare verso Pechino. Non c’è solo una motivazione economica, ma anche politica e strategica. Finché i chip taiwanesi sono indispensabili a Xi, questo serve come deterrente a possibili azioni militari. Non è in realtà l’elemento decisivo, e la contesa va ben oltre i chip. Ma intanto, il resto mondo, accortosi della enorme dipendenza sviluppata nei confronti di Taiwan, prova ad accaparrarsi i suoi chip. Rischiando di ammaccare quello scudo di silicio.
L.L.

Il pezzo più fotografato è un cavolo di giada. Appena più grande di una mano, era un tempo parte della dote della consorte dell’imperatore della dinastia Qing. Si trovava alla Città Proibita di Pechino. Oggi invece è una delle principali attrazioni del museo nazionale di Taipei, che ospita una collezione permanente di quasi 700mila pezzi. Una delle più grandi al mondo, copre ottomila anni di storia cinese dall’età neolitica fino alla fine dell’impero e alla rivoluzione che portò alla fondazione della Repubblica di Cina. Già, perché il museo nazionale di Taipei è il museo della Repubblica di Cina. Al suo interno, artefatti che a Pechino considerano trafugati perché testimonianze fondamentali della storia cinese di cui la Repubblica popolare si considera unica legittima erede. Tanto che, nell’ottobre 2022, è esplosa una polemica per alcuni incidenti museali a causa dei quali si sarebbero rotte la «tazza da tè gialla con il disegno del drago verde» della dinastia Qing (1636-1911) e una porcellana bianca e blu della dinastia Ming (1368-1644).
Esattamente 305 chilometri a sud del palazzo del museo nazionale di Taipei, nei sobborghi dell’antica capitale di Tainan, sorge invece il museo nazionale della storia di Taiwan. La sua apertura, inizialmente prevista per il 2008, è avvenuta nel 2011 dopo 12 anni di preparativi. Il museo contiene circa 60mila manufatti che ripercorrono le influenze aborigene, olandesi, spagnole, britanniche e giapponesi sull’isola. Qui il centro della storia è appunto Taiwan, non la Cina o la civiltà cinese.
Con buona dose di equilibrismo semantico sugli avvenimenti degli ultimi sette decenni, il percorso espositivo assume un punto di vista diverso sulla storia dell’isola. L’apertura del museo nazionale è un passaggio chiave per capire come si percepiscono le nuove generazioni di taiwanesi.
«Quando andavo a scuola io, studiavamo la storia e la geografia della Cina. Non sapevamo nulla di Taiwan», racconta Pei-yu, 40 anni. «Sui libri dei miei figli invece si parla di Taiwan e la Cina è per lo più percepita come qualcosa di esterno», spiega. L’educazione è un elemento fondamentale. A questo proposito viene in mente quanto dichiarato nell’agosto 2022, in un’intervista, da Lu Shaye, ex ambasciatore cinese a Parigi, che menzionò la necessità di «rieducare» i taiwanesi a «riunificazione» avvenuta.

Se per Chiang Kai-shek i taiwanesi erano «giapponesizzati» dopo i 50 anni di dominio coloniale nipponico, l’attuale Partito comunista cinese è spaventato da quella che definisce «desinizzazione» di oggi.
Se per i taiwanesi di una certa età la distanza con la Cina continentale è soprattutto politica, per quelli più giovani invece la distanza è anche socioculturale. Persino storica e identitaria.
Ogni anno, la National Chengchi University di Taipei svolge due sondaggi sulla questione identitaria. Le scelte messe a disposizione degli intervistati sono tre alla richiesta di autodefinizione: taiwanese, cinese, sia taiwanese sia cinese. Nel 1992, quando cominciarono le rilevazioni, il 25,5% si definiva solo cinese e il 17,6% solo taiwanese, col restante 46,4% taiwanese e cinese. A giugno 2023, il 62,8% si definiva solo taiwanese, il 30,5% taiwanese e cinese, il 2,5% solo cinese.
La forbice si amplia ulteriormente a favore del solo taiwanese nel segmento degli under 25. Ecco il principale timore di Pechino, in passato convinta che il tempo giocasse dalla sua parte: i taiwanesi si stanno allontanando sempre di più dalla Cina continentale. Un processo accelerato dalla democratizzazione avviata negli anni Ottanta.
L’apertura democratica è stata avviata da una negoziazione tra potere e società civile, con i movimenti civili sempre attivi nonostante la dura repressione di Chiang. L’isola principale di Taiwan doveva essere inizialmente una base temporanea nell’attesa di riprendersi la Cina continentale. È qui che si è creata la rottura tra waishengren, i cinesi continentali arrivati a Taiwan dopo il 1945, e i benshengren, nativi taiwanesi di etnia han. Una divisione e una tensione intraetnica che ha alimentato la nascita del nazionalismo taiwanese e lo sviluppo di un’identità «altra» rispetto a quella cinese continentale.
La transizione democratica è stata avviata dal figlio di Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, in una sorta di ascolto delle istanze sempre vive di attivisti e oppositori. Ma quella vissuta da Taiwan non è stata una semplice democratizzazione del sistema politico, è stato anche l’avvio di una ridefinizione della sua identità. La scelta di Lee Teng-hui, nativo taiwanese, come successore di Chiang Ching-kuo ha rappresentato il punto di congiunzione che ha attenuato la divisione tra waishengren e benshengren.
Dal 2000 il primo presidente del Dpp, Chen Shui-bian, poi condannato per corruzione, ha contribuito a rafforzare l’identità taiwanese, cambiando la denominazione di aziende e luoghi pubblici. Per la prima volta sono stati affrontati pubblicamente gli orrori del «terrore bianco» (come viene chiamato il regime instaurato durante legge marziale, dal febbraio 1947 al 1987, ndr), con conseguente rivalutazione in negativo della figura di Chiang. Oggi, il suo memoriale ospita insieme un’esposizione dei suoi cimeli, una statua in suo onore con due guardie armate e un museo dei diritti umani che racconta la brutale repressione da lui attuata nei confronti degli oppositori.

A contribuire al rafforzamento del senso di alterità taiwanese rispetto alla Cina continentale c’è anche l’avanzamento sul fronte dei diritti civili. Una spinta molto forte in tal senso, che ha funzionato anche sul fronte esterno, è stata la legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso nel 2019. Proprio mentre partiva la repressione delle proteste di Hong Kong, altro elemento spartiacque che ha allontanato Taiwan dalla Repubblica popolare, convincendo tanti, anche tra i più possibilisti, che il modello «un Paese, due sistemi» in vigore nell’ex colonia britannica non potesse essere accettato.
Il cambiamento lo si vede anche nella produzione cinematografica e televisiva, sul quale il governo taiwanese sta insistendo molto per rafforzare una narrativa identitaria che evidenzi le diversità con la Cina continentale sotto il punto di vista non solo politico, ma anche storico ed etnico-linguistico. Se in passato le produzioni televisive e cinematografiche ad alto budget erano per lo più rivolte a raccontare le vicende delle dinastie dell’impero cinese, o al limite della storia repubblicana (non popolare) cinese, ora si finanziano più volentieri altri tipi di opere. Tra gli esempi più noti c’è Seqalu – Formosa 1867, prodotto dal Taiwan public television service e destinatario di un’imponente campagna pubblicitaria. La serie televisiva, approdata anche su Netflix, è un adattamento del romanzo Lady Butterfly of Formosa di Chen Yao-chang, un ex politico del Dpp.
La sua storia è basata sul naufragio del mercantile statunitense Rover al largo delle coste taiwanesi, avvenuto per aver colpito una barriera corallina nel marzo 1867. Quattordici marinai americani furono uccisi dagli aborigeni taiwanesi per vendetta dopo l’uccisione di decine di membri della tribù Kaolut da parte dei tanti stranieri che erano circolati per secoli intorno all’isola. Incidente dal quale nacque una spedizione militare di Washington appoggiata dalle forze cinesi della dinastia Qing.
Sia il romanzo sia la serie puntano a sottolineare la varietà etnica e culturale di Taiwan. D’altronde lo scrittore Chen dice di essere discendente dei Siraya, una delle popolazioni aborigene dell’isola. Ma sono tanti gli esempi che fanno capire come ci si trovi di fronte a una tendenza ben precisa.
Diversi film degli ultimi anni raccontano storie legate alla comunità Lgbtq+.
Island Nation racconta la transizione democratica di Taiwan dopo la legge marziale. Days we stared at the sun è, invece, incentrato sul movimento dei girasoli che di fatto contribuì alla vittoria di Tsai Ing-wen alle elezioni del 2016 dopo aver occupato nel 2014 per 23 giorni lo yuan legislativo (il parlamento unicamerale taiwanese) per protestare contro un accordo sul settore terziario con Pechino proposto dall’amministrazione Kmt del presidente Ma Ying-jeou. Un’esperienza, quella del movimento dei girasoli, poi parzialmente assorbita dall’amministrazione Tsai e così normalizzata. E in parte disillusa. La recente serie Wave makers descrive invece una campagna elettorale taiwanese senza fare riferimenti alla Cina, e la cattiva gestione di abusi sessuali all’interno di un partito. Da essa è scaturita un’ondata di #MeToo con denunce all’interno di partiti reali (Dpp compreso), istituzioni e mondo dell’intrattenimento.
Taiwan ha, inoltre, annunciato l’obiettivo di diventare un paese bilingue (quantomeno a livello ufficiale) con l’elevazione dell’inglese a lingua ufficiale entro il 2030. Tsai vorrebbe che il mondo vedesse Taiwan come «occidentale, pur se influenzata dalla civilizzazione cinese e formata dalla tradizione asiatica», come ha scritto in un articolo di due anni fa su Foreign affairs.
Raccontare la storia di Taiwan al mondo è diventato un obiettivo primario, come si può notare dalla creazione della piattaforma in lingua inglese TaiwanPlus, lanciata nella seconda parte del 2021.

Il Dpp non persegue, almeno per ora, una dichiarazione di indipendenza formale come Repubblica di Taiwan. Consapevole che la mossa porterebbe a una scontata reazione militare di Pechino, ma anche del 40% circa della popolazione che si sente appartenente alla sfera culturale cinese. Intanto, però, prosegue la taiwanizzazione del suo messaggio, a più livelli. Basti pensare al nuovo passaporto che, rispetto al passato, mantiene il nome Repubblica di Cina solo in caratteri cinesi, con il nome Taiwan leggibile in caratteri latini.
Oppure al logo per la festa nazionale del 10 ottobre, che ancora una volta omette il nome Repubblica di Cina, nonostante si tratti della celebrazione di quanto successo nel 1911 con la rivolta di Wuchang che diede vita alla rivoluzione Xinhai: l’inizio della fine per l’impero Qing. Una giornata commemorata anche dalla Repubblica popolare.
Taiwan è un luogo con più livelli di lettura, che ancora si interroga su se stesso. Come la domanda che si pone Momo, la protagonista del romanzo simbolo della letteratura sci-fi queer taiwanese, Membrane di Chi Ta-wei: «Ma il passato che conosco è reale o fittizio?». Un racconto scritto non a caso negli anni Novanta, nel vortice di autoanalisi che ha portato i taiwanesi a osservare le ferite del passato e li ha condotti sulla strada di un complesso processo di ricostruzione identitaria in corso ancora oggi. E a porsi domande le cui risposte non sono mai univoche. Non ancora.
Lorenzo Lamperti
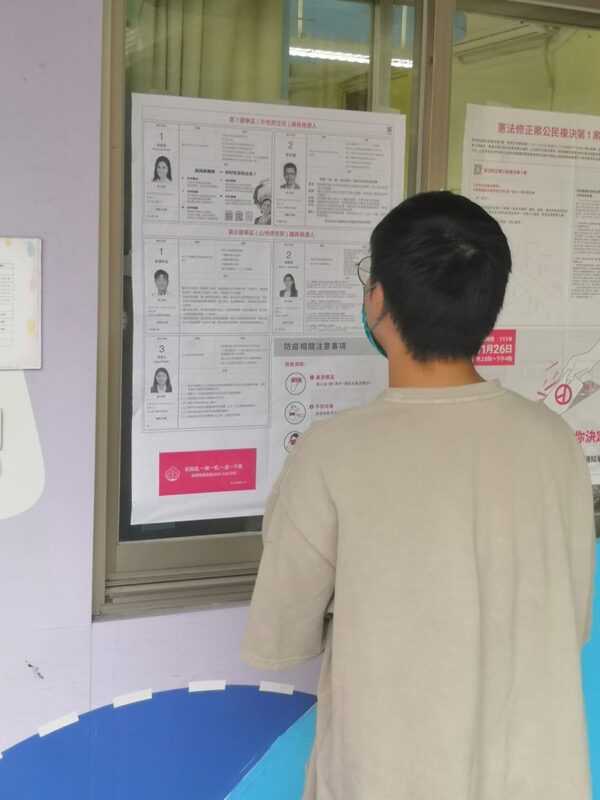
Sono apparsi un poʼ in sordina, ma ci sono. Evacuation shelter (rifugio per lʼevacuazione): 600 metri in quella direzione. Con tanto di mappa, percorso più rapido e numeri di emergenza. In diversi angoli di Taipei sono apparsi questi cartelli di colore verde. Sono entrati in silenzio a far parte del caotico e vibrante arredo urbano. Eppure, pochi vi si soffermano. Quasi nessuno sembra prestare loro attenzione. Lʼipotesi di una guerra a tanti sembra ancora inconcepibile. Anche se qualcuno ha cominciato a prepararsi qualche via di fuga. Un passaporto di Singapore, magari, per facoltosi uomini dʼaffari. Un semplice zaino pronto per le emergenze per chi ha il portafoglio meno fornito.
Da oltre 70 anni i taiwanesi sono abituati a convivere con lʼipotesi di un conflitto. Negli anni Cinquanta, durante le prime due crisi dello stretto, Mao Zedong fece bombardare le isole Kinmen e Matsu, avamposti ancora oggi controllati da Taipei, ma a pochi chilometri di mare dal Fujian (provincia cinese che si affaccia sullo stretto, ndr). Da quelle isole partivano spesso attacchi contro la costa continentale, peraltro con il placet dellʼamministrazione Usa di Dwight Eisenhower.
Fu allora che si svolse lʼunico cambiamento di territorio tra Repubblica popolare cinese e Repubblica di Cina dalla fine della guerra civile, con lʼEsercito popolare di liberazione che si impossessò di Yijiangshan, nelle isole Dachen. Evento rievocato in una celebrazione speciale del Comando del teatro orientale delle forze armate cinesi lo scorso 9 settembre.
Ad agosto 2022, invece, Xi Jinping era riemerso dal conclave estivo annuale del Partito comunista apparendo a Jinzhou, città oggi parte della provincia nord orientale del Liaoning da cui nel 1948 partì la campagna di Liaoshen, decisiva per orientare la guerra civile a sfavore del Kmt di Chiang Kai-shek. Due episodi che sembrano avere un valore simbolico, soprattutto visto che il passaggio di Xi da Jinzhoun è avvenuto nel momento di nazionalismo più aggressivo contro i cosiddetti «secessionisti» taiwanesi dopo la visita di Nancy Pelosi a Taipei. Come a dire: abbiate pazienza, alla fine lʼobiettivo sarà raggiunto ma ci vuole tempo.

Quei cartelli apparsi in diversi angoli di Taipei si sono materializzati anche in risposta alle imponenti esercitazioni militari di agosto 2022. Non tanto perché i taiwanesi le abbiano vissute con panico o particolare tensione. Ma più che altro per la polemica che ne è nata sul lancio di missili da parte dellʼesercito cinese. Alcuni di questi hanno sorvolato lo spazio di Taiwan, senza che il governo desse alcun tipo di allarme o comunicazione, arrivata per prima dalle autorità giapponesi. Circostanza che ha fatto riflettere parecchi, i quali sui social, e non solo, hanno iniziato a lamentarsi di non sapere cosa fare o dove andare in caso di un futuro reale pericolo. Da qui le maggiori condivisioni delle mappe di rifugi, i quali, più che a bunker antiaerei somigliano spesso a scantinati. E da qui lʼampliamento del manuale di difesa civile pubblicato dal governo.
Con la guerra in Ucraina e, ancora prima, il ritiro degli Usa dallʼAfghanistan, lʼesecutivo taiwanese sta provando a cambiare la comunicazione. Fino a qualche anno fa si minimizzavano i rischi nella narrazione interna, ampliandoli invece nella comunicazione verso la comunità internazionale. Ora però in molti a Taipei temono una sottovalutazione da parte dellʼopinione pubblica. Negli ultimi due anni sono nate diverse iniziative di addestramento alla resistenza dei civili, mentre, a livello governativo, è stata approvata lʼestensione della leva militare obbligatoria da 4 a 10 mesi.
Eppure, resta ancora tutta da verificare non solo la capacità, ma anche la volontà dei taiwanesi di combattere. Secondo un sondaggio della Taiwan foundation for democracy del dicembre 2022, oltre il 70% degli intervistati sarebbe disposto a difendere Taiwan. Stime ottimistiche secondo altre rilevazioni.
Altri osservatori come Paul Huang della Taiwanese public opinion foundation mettono in evidenza i problemi di morale allʼinterno dellʼesercito, dove più volte negli ultimi anni sono emerse presunte reti di spionaggio a favore di Pechino, spesso intessute da ufficiali, anche di alto grado, in pensione. Altri ancora in servizio attivo.
Ma cʼè anche qualche vantaggio nella strategia di difesa taiwanese. Intanto, la geografia. «Lʼisola è circondata dallʼoceano, è difficile da raggiungere ed è complicato sbarcare. Ci sono montagne alte. Insomma, lʼeventuale campo di battaglia potrebbe diventare un incubo per chi attacca», sostiene Kuo Yu-jen del National policy research.

«LʼUcraina è più facile da attaccare, ma Taiwan è più difficile da aiutare», dice Lin Ying-yu dellʼIstituto di studi strategici della Tamkang University. «Un blocco navale potrebbe essere la futura strategia di Pechino». Una sorta di stritolamento che tagli i rifornimenti, porti allʼesaurimento le riserve energetiche e induca allʼapertura di un negoziato politico del grado di autonomia concesso allʼinterno del modello «un paese, due sistemi». Secondo Lin, lʼesercito cinese non ha ancora le capacità per farlo. «Le esercitazioni degli ultimi mesi dimostrano che la modernizzazione militare cinese procede spedita, manca però ancora qualche anno prima di poter sostenere un blocco totale o condurre unʼinvasione su larga scala, che sarebbe comunque solo lʼextrema ratio».
Prima di allora, si continuerà con lʼallargamento della cosiddetta «zona grigia», area non di combattimento, ma nella quale vengono condotte operazioni militari, incursioni, sconfinamenti. In questo caso lungo lo stretto. A preoccupare Taipei non sono solo i mezzi dellʼesercito, ma anche quelli di guardia costiera e marina militare. «Ne arriveranno progressivamente sempre di più», prevede Chieh Chung della National policy foundation. In tal senso, spesso i funzionari taiwanesi sono più preoccupati da manovre meno visibili allʼesterno, ma potenzialmente di maggiore impatto. Un esempio? Le ispezioni a bordo delle navi sullo stretto annunciate durante le esercitazioni dello scorso aprile. Il tutto contestualmente al primo impiego della portaerei (cinese) Shandong al largo della costa orientale, lʼunico lato da cui potrebbero arrivare aiuti esterni. Ecco, se Pechino riuscisse a sostenere un blocco navale prolungato di quella zona potrebbe puntare a trasformare lo stretto in una sorta di mare interno. Prodromi di questo approccio se ne sono avuti più volte negli scorsi mesi, quando le navi cinesi hanno fronteggiato quelle statunitensi o canadesi in transito.
È quella che lʼammiraglio Chen Yeong-kang, ex comandante della marina di Taipei, ha definito «strategia dellʼanaconda», mirata a «stritolare piano piano il nostro centro di gravità per arrivare a un negoziato». Magari prendendo di mira i cavi sottomarini, che portano la connessione internet sullʼisola. Lo scorso febbraio, due cavi sono stati recisi al largo delle isole Matsu. Semplice incidente o test? Non è dato saperlo, ma i lavori di riparazione sono terminati 50 giorni dopo. Ci si immagini la recisione dei cavi che collegano Taiwan al resto del mondo in uno scenario di blocco navale con mancanza di riserve energetiche: difendersi sarebbe tuttʼaltro che semplice.
Taiwan sta provando a capire come sviluppare un sistema satellitare autonomo, visto che la fiducia in Starlink è quasi inesistente per gli stretti rapporti di Elon Musk con la Cina e per le sue esternazioni su Taiwan.

Alessio Patalano del Kingʼs College ha spiegato, durante un recente intervento pubblico a Taipei, di ritenere più probabile un ipotetico «decapitation strike» che unʼinvasione su larga scala o un blocco navale. Vale a dire unʼoperazione di commando speciale volta a eliminare i leader politici e le autorità istituzionali taiwanesi.
Pechino potrebbe usare anche altre tipologie di armi. A partire da quelle normative. Lo scorso aprile, ad esempio, si è saputo che per la prima volta un cittadino taiwanese sarà processato per secessionismo. Si tratta di Yang Chih-yuan, attivista di 33 anni arrestato lo scorso agosto a Wenzhou, nella Cina continentale, subito dopo la visita di Nancy Pelosi a Taipei. Allora era apparsa una chiara ritorsione per lʼincontro fra Pelosi e Lee Ming-che, altro attivista taiwanese che aveva passato qualche anno nelle carceri continentali. Dopo quasi nove mesi, la Procura suprema del popolo di Pechino ha comunicato lʼincriminazione di Yang. La sua colpa sarebbe quella di aver sostenuto un referendum sullʼindipendenza e aver partecipato alla fondazione del Partito nazionalista di Taiwan, che persegue una dichiarazione di indipendenza formale e lʼadesione di Taipei alle Nazioni Unite. Attività svolte oltre un decennio fa a Taiwan, ma che ora possono costare a Yang da 10 anni allʼergastolo. Le accuse a Yang mostrano la volontà di Pechino di dare una base legale alla sua pretesa di sovranità su Taiwan.

Nonostante una netta diminuzione dallʼinizio del Covid, i taiwanesi che vivono e lavorano sullʼaltra sponda dello stretto sono ancora più di un milione. Vicende come quella di Yang possono avere un impatto anche più profondo delle manovre militari sullʼopinione pubblica taiwanese.
Ci sono poi le liste nere dei «secessionisti», che puntano non tanto a colpire il singolo individuo o politico, quanto lʼintreccio tra figure sgradite a Pechino e il mondo imprenditoriale dell’isola. Emblematica la vicenda del conglomerato taiwanese Far eastern group, operativo da diversi anni in Cina continentale e destinatario di una maxi multa e minaccia di esproprio per aver cofinanziato un evento a cui era intervenuto uno dei politici nella blacklist. Il patron dellʼazienda si è sentito in dovere di mandare una lettera aperta ai media in cui spiegava di essere contrario allʼindipendenza. Stesso concetto applicato nella vicenda di Wu Rwei-ren, il primo taiwanese accusato con la legge di sicurezza nazionale entrata in vigore a Hong Kong nel 2020. Nessun istituto universitario o accademico taiwanese ha firmato lʼappello dellʼAcademia Sinica a sua difesa. Lʼaccusa non avrà conseguenze dirette su Wu finché resterà a Taiwan, ma può impattare sul lavoro di altri accademici che potrebbero pensarci due volte prima di occuparsi di temi delicati.
Cʼè poi il fronte economico. Lʼeconomia taiwanese è entrata in recessione, quantomeno nella prima parte del 2023. Pesa soprattutto il rallentamento dellʼexport a causa di una domanda indebolita, compresa quella della Cina continentale che rappresenta sempre il primo mercato di destinazione delle esportazioni taiwanesi. Negli scorsi mesi, Pechino ha preso di mira lʼesportazione di mango dall’isola. Prima era toccato alle cernie, agli ananas e persino al kaoliang, il celebre liquore di sorgo bevuto da Xi e Ma Ying-jeou nello storico incontro di Singapore del 2015. E alimentare la paura di un conflitto, come dimostra il ritiro degli investimenti su Taiwan di Warren Buffett, potrebbe persino legare lʼeconomia taiwanese ancora di più a quella di Pechino.
Una donna di mezza età si ferma a osservare uno di quei cartelli verdi apparsi in diversi angoli di Taipei. Spinge un passeggino. Poi parla con il compagno di dove andare a cena nel fine settimana. Ma nella mente, forse, una traccia di quel cartello verde resta.
Lorenzo Lamperti

C’è una sola entità statuale europea a intrattenere relazioni diplomatiche ufficiali con la Repubblica di Cina, Taiwan. Si tratta della Santa Sede. La presenza del cattolicesimo a Taiwan affonda le radici nella piccola colonizzazione spagnola. Oggi, i cristiani rappresentano una fetta non trascurabile del 3,9% circa della popolazione taiwanese. I protestanti sono quasi il doppio dei cattolici. Solo buddhismo e taoismo contano più fedeli, in un panorama religioso frastagliato e originale, anche grazie allo storico incontro tra le credenze delle popolazioni aborigene, di origine austronesiana, e la prima grande immigrazione dei cinesi di etnia Han. Sul territorio taiwanese ci sono poco meno di tremila chiese. Chiang Kai-shek e Chiang Ching-kuo erano metodisti, Lee Teng-hui è stato membro della Chiesa presbiteriana, che ha forti legami con il Dpp fin dagli anni Ottanta. I rapporti tra Taipei e la Santa Sede non sono mai stati in discussione, con la presenza di un’ambasciata e di una nunziatura nei rispettivi territori. Negli ultimi anni, i tentativi di dialogo tra papa Francesco e il Partito comunista cinese hanno messo in dubbio il futuro di queste relazioni. Ma la chiesa mantiene una presenza importante anche dal punto di vista sociale, giocando pure un ruolo nella raccolta e nell’invio di aiuti sanitari in Italia durante la pandemia di Covid-19. Sono numerosi i progetti condotti a Taiwan dai preti e suore camilliani.
I missionari della Consolata, sono presenti dal 2014 nella diocesi di Hsinchu, oggi in due comunità*.
L.L.
* Prossimamente racconteremo in modo approfondito il lavoro di Imc a Taiwan.

A ottobre si è celebrato il ventesimo Congresso del Pcc che ha consacrato Xi Jinping alla guida del partito e del paese per un terzo mandato. È la prima volta dai tempi di Mao. Sicurezza e sviluppo sul lungo termine sono le priorità. E Xi fa modificare lo statuto del partito inserendo i «suoi» principi.
Ciascuna delle città scelte da Xi Jinping per la prima visita dopo aver ricevuto ognuno dei suoi tre mandati, ha un significato simbolico. Shenzen nel 2012, emblema del miracolo economico cinese. Shanghai nel 2017, luogo di fondazione del Partito comunista cinese ma anche principale porta d’accesso della Cina continentale al mondo. Yan’an nel 2022, destinazione finale della «lunga marcia» di Mao Zedong e base del partito comunista cinese dal 1935 al 1948, prima che la guerra civile contro i nazionalisti di Chiang Kai-shek volgesse a favore dei comunisti. Per avere un indizio sulla direzione del terzo mandato di Xi Jinping bisogna partire da quello che è successo subito dopo il XX Congresso del partito, cioè dalla città scelta per la sua prima visita ufficiale. Un netto cambio rispetto alle scelte operate dopo il XVIII e il XIX Congresso. Il trionfo di Xi va ben al di là della sua scontata conferma: il presidente ha ottenuto una squadra a sua immagine e somiglianza, nonché emendamenti allo statuto del partito che elevano ulteriormente il suo status. Questo ha peraltro messo fine a una serie di prassi e regole non scritte che avevano sempre sorretto il funzionamento delle nomine e della selezione delle cariche apicali. Rendendo manifesto che Xi non solo controlla il partito: Xi ormai è il partito.
L’immagine che resterà nella mente di tutti come avvio del terzo mandato di Xi è quella di Hu Jintao, il predecessore, che viene scortato fuori dall’aula durante l’ultima sessione del Congresso. Un episodio controverso sul quale non sapremo mai tutta la verità. Forse esagerato parlare di purga per la dinamica e le circostanze, certamente, però, è riduttivo ascrivere tutto a un semplice «problema di salute», visto che l’anziano leader (il quale pare soffra di una forma di demenza senile) non sembrava d’accordo a lasciare il suo posto. Ma la vera «epurazione» è arrivata lontano dalle telecamere, ed è stata quella di Hu Chunhua. Per lungo tempo considerato un astro nascente della politica cinese, membro della Lega della gioventù comunista, feudo proprio di Hu Jintao, è stato escluso non solo dal Comitato permanente di sette membri, ma persino dal Politburo (tradizionalmente 25 membri, ora inusualmente 24, si dice, per un’esclusione dell’ultimo momento).
Attenzione però a pensare che il cambio di passo sia stato qualcosa di improvviso. Il processo di consolidamento del potere di Xi è avvenuto passo dopo passo, non è frutto di una rivoluzione inattesa. Prima le promesse di riforme economiche e il lancio della Belt and road initiative nel 2013 (la nuova via della seta, ndr), poi la rimozione del vincolo dei due mandati nel 2018. Infine, l’ingresso ufficiale nel terzo atto della «nuova era» di Xi senza che nemmeno si intraveda all’orizzonte un possibile erede.
Il 23 ottobre, quando ha calcato di nuovo il tappeto rosso della Grande sala del popolo in testa alla fila dei sette membri del Comitato permanente, il segretario generale non ha solo ufficializzato il suo terzo mandato, ma ha anche allungato le mani (incognite e imprevisti permettendo) sul quarto.
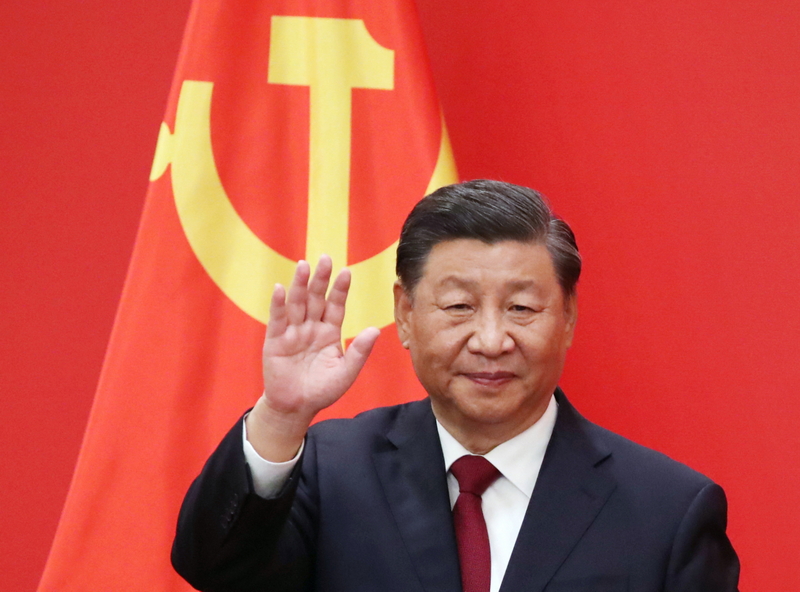
Ma come sarà il terzo mandato di Xi? Partiamo dall’economia. «Mi aspettavo qualche messaggio un po’ più favorevole alla crescita, ma credo che la preoccupazione di Xi sia soprattutto a lungo termine. Egli punta a una crescita di qualità superiore per la Cina, senza preoccuparsi troppo della traiettoria di crescita a breve termine. Questo è un po’ deludente, perché ci sono molte sfide legate alla crescita nell’immediato», dice Victor Shih Ho Miu Lam, moderatore della San Diego University e autore di diversi libri sul sistema economico e politico cinesi. Una di queste è certamente la strategia «zero Covid». In molti speravano che dopo il congresso le restrizioni si rilassassero. In un’inusuale protesta pochi giorni prima dell’appuntamento politico, a Pechino sono apparsi anche degli striscioni che criticavano direttamente il leader. Altre scritte sono apparse in diverse città cinesi. Ma Xi si è intestato il successo della gestione sanitaria che, nella narrativa di Pechino, rappresenta un segnale della superiorità del suo modello rispetto a quello occidentale, nonché la prova del rispetto dei «diritti umani». Con caratteristiche cinesi, ovviamente. Il mancato ripensamento delle politiche sul Covid è reso evidente anche dalla scelta di Li Qiang come prossimo premier. Capo del partito a Shanghai, è colui che ha gestito il disastroso lockdown dei mesi scorsi. Evento che sembrava averlo tagliato fuori dalla corsa per un ruolo di primo piano, nonostante la dimestichezza in campo amministrativo e la familiarità con i tanti investitori internazionali che popolano Shanghai, e che hanno vissuto, però, con sgomento la recente fase dei restringimenti. «All’interno del partito, Li non è mai stato squalificato, perché ha solo applicato l’approccio alla pandemia voluto da Xi. Di certo, la sua promozione è basata anche e soprattutto sulla lealtà e lo stretto rapporto che ha con Xi», dice Shih.
Tutto rientra nel mantra della «sicurezza», la parola più utilizzata da Xi nella sua relazione politica dopo le classiche «partito», «popolo» e «nazione». Un’ossessione dovuta al fatto che la Cina si sente sotto attacco sul fronte economico. Le ultime mosse di Joe Biden sui semiconduttori, infatti, hanno portato Xi a chiedere un’accelerazione sul fronte dell’autosufficienza tecnologica. Ma ha anche portato a una pioggia di promozioni per una nuova classe di «tecnocrati» con esperienza e formazione tecnologica e scientifica, in particolare nel settore dell’aerospazio. Un cambio di passo rispetto al passato. Se finora la gestione delle nomine era garantita da una serie di legami e rapporti costruiti all’interno di diverse fazioni, ora l’unica fazione rimasta è quella di Xi, e i nuovi «tecnocrati» sono figure con maggiori competenze, ma minori intrecci relazionali.
Con una Cina sotto attacco, il partito sente il bisogno di avere ulteriore controllo sociale, a partire dal fronte interno. «Sviluppo e sicurezza per Xi sono la stessa cosa. C’è bisogno di sviluppo ma anche di molta sicurezza, soprattutto controllata dal partito. Per Xi, anche se la Cina diventasse incredibilmente ricca non avrebbe senso se non fosse controllata dal partito», sostiene Shih. Ed ecco allora la presenza più massiccia dello stato nell’economia, con il settore privato e, in particolare, quello tecnologico «rettificati» per seguire le necessità strategiche della politica e geopolitica cinese.

L’inserimento nello statuto del partito di altri due principi utilizzati da Xi negli ultimi anni rinforza il messaggio: con la «prosperità comune» si chiarisce che la ricchezza va redistribuita e che il partito eviterà eccessivi accentramenti di potere e ricchezze private; con la «doppia circolazione», invece, si ribadisce che il focus deve essere quello di stimolare i consumi interni e ridurre la dipendenza dalle esportazioni, e dunque dall’esterno.
È un sistema dove l’unico a mantenere il controllo è il partito, e dunque Xi. Ciò significa che, nero su bianco, Xi è il nucleo del partito. Criticarlo ora significa mettersi automaticamente fuori dal partito.
La stessa necessità di controllo esiste anche sul fronte esterno. «Xi continua a vedere complotti occidentali che cercano di minare la Cina. Per questo al congresso si è concentrato molto sui concetti di lotta e di sicurezza». Se fino a poco tempo fa i leader cinesi parlavano soprattutto di «opportunità strategiche», ora Xi parla di «pericoli» e «acque tempestose» da navigare con ambizione e mano ferma che, evidentemente, possono essere garantire solo un «timoniere» senza distrazioni interne e con una squadra compatta e pronta a combattere senza mettere in discussione la rotta intrapresa.
Dopo aver risolto la questione di Hong Kong e portato, come detto da Xi, l’ex colonia britannica dal «caos» alla «stabilità», il mirino si sposta al di là dello stretto (di Taiwan, ndr). L’inedito inserimento, nello statuto, dell’opposizione alla «indipendenza di Taiwan» svela che la questione di Taipei sarà una delle priorità del terzo mandato di Xi. Anche sullo stretto, la Cina si percepisce o si racconta come sotto attacco di «interferenze esterne», in particolare quelle americane. Il messaggio arrivato dal Congresso è chiaro: Pechino non arretra sul tema della «riunificazione», che considera legato a doppio filo con quello più vasto del «ringiovanimento nazionale» e della realizzazione di una società «socialista, forte e armoniosa» entro il centenario della Repubblica popolare nel 2049.
«Xi ha voluto segnalare che il tema di Taiwan avrà una priorità maggiore nei prossimi cinque anni e che ritiene urgente fare dei progressi sul percorso di unificazione», spiega Wen Ti-sung, analista dell’Australian national university.
In che modo Xi intende fare progressi? «Probabilmente attraverso l’integrazione economica e il lavoro del fronte unito, piuttosto che tramite l’uso della forza», sostiene Wen. «Xi sta segnalando la minaccia di una crescente internazionalizzazione della questione di Taiwan, che è una delle sempre sfuggenti linee rosse della Repubblica popolare. In termini militari, Pechino raddoppierà gli sforzi e la presenza sullo stretto per negare agli attori stranieri la capacità militare di intervenire in una eventuale contingenza sul posto. Cercherà di limitare la libertà d’azione dell’esercito taiwanese, istituzionalizzando la presenza al di là della linea mediana in modo da intaccare il suo morale, sperando di far capitolare le resistenze», aggiunge.
L’emendamento allo statuto potrebbe rappresentare la base per una nuova misura normativa che allarghi lo spettro dell’attuale legge anti secessione per provare a recidere i rapporti tra mondo imprenditoriale taiwanese e partito di governo in vista delle elezioni presidenziali del 2024, che saranno in sostanza presentate come una scelta tra pace (col più dialogante Kuomintang) o guerra (col Partito progressista democratico che dovrebbe candidare William Lai, figura ben più radicale dell’attuale presidente Tsai Ing-wen).
Nel frattempo, procede spedito l’ammodernamento dell’esercito, e a capo della Commissione militare centrale, presieduta sempre da Xi, sono stati posti generali con grande esperienza «taiwanese». A partire da He Weidong, che ha guidato le esercitazioni militari senza precedenti che hanno fatto seguito alla visita di Nancy Pelosi a Taipei nell’agosto scorso.
Forse la Cina non vuole la guerra, o non la vuole ancora. Ma di certo si sta preparando a combatterla qualora fosse necessario. O qualora sentisse che il tempo non è più dalla sua parte come ha sempre pensato. Non a caso il XX Congresso apre anche a un rafforzamento dell’arsenale nucleare. Xi ha infatti preannunciato «un forte sistema di deterrenza strategica». Secondo il Pentagono, la Cina potrebbe avere circa 700 testate nucleari trasportabili nel 2027 e almeno mille nel 2030.
La dottrina cinese impone di non utilizzare per primi le armi nucleari, ma Pechino vuole rafforzare la sua deterrenza mentre la rivalità con Washington sembra ormai su un piano inclinato. «In fin dei conti – avverte Shih -, la decisione di utilizzare un’opzione militare su Taiwan dipende da una sola persona, Xi Jinping, e la decisione di una sola persona, come stiamo vedendo nel caso della Russia, può essere altamente imprevedibile».
Ecco, al di là delle incognite sul fronte economico, è proprio questa la chiave per capire che cosa potrà succedere nel terzo mandato di Xi. In passato il partito ha sempre ritenuto che il tempo giocasse a suo favore. Se ora cambiasse definitivamente prospettiva, convinto da un’America che ha ormai chiarito definitivamente che considera la Cina il primo rivale strategico nel lungo termine, potrebbe diventare impaziente. E la già tanta confusione sotto il cielo, parafrasando Mao Zedong, potrebbe stavolta non portare a una situazione eccellente.
Lorenzo Lamperti

Poprio nelle ore in cui a Pechino si consumava l’ultimo capitolo del XX Congresso del Partito comunista cinese, nella Città del Vaticano veniva annunciato il rinnovo dell’accordo sulla nomina dei vescovi. Si tratta della seconda conferma del primo accordo biennale firmato nel settembre 2018. Sarà in vigore dunque fino al 2024. La Santa sede ha spiegato che «si impegna a continuare un dialogo rispettoso e costruttivo con la parte cinese per una produttiva attuazione dell’accordo e un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, al fine di promuovere la missione della Chiesa cattolica e il bene del popolo cinese». I termini dell’accordo non sono mai stati resi pubblici, creando qualche dubbio tra i critici. Anche perché le segnalazioni di rimozione di croci e chiusure di luoghi di culto sono proseguite negli ultimi anni. Nelle scorse settimane è iniziato il processo a carico di Joseph Zen, l’ex cardinale di Hong Kong che è entrato nel mirino delle autorità ai sensi della legge di sicurezza nazionale e che è sempre stato molto critico sulla distensione dei rapporti tra Vaticano e Pechino.
Il partito comunista cerca d’altronde di «sinizzare» le fedi religiose e farle entrare in armonia con le famose «caratteristiche cinesi», di cui l’unico possibile custode è il partito stesso.
Il cardinale Pietro Parolin ha spiegato che «Papa Francesco, con determinazione e paziente lungimiranza, ha deciso di proseguire su questa strada non nell’illusione di trovare la perfezione nelle regole umane, ma nella concreta speranza di poter assicurare alle comunità cattoliche cinesi, anche in un contesto così complesso, la guida di pastori degni e adatti al compito loro affidato».
Lo scorso luglio, anche il pontefice ha difeso l’accordo: «La diplomazia è l’arte del possibile e del fare le cose perché il possibile diventi realtà», ha detto papa Bergoglio. Ricordando il dialogo mantenuto dal Vaticano con i governi comunisti dell’Europa orientale durante la guerra fredda. D’altronde il Vaticano ha sempre sottolineato l’obiettivo pastorale di un accordo teso a tutelare i fedeli cinesi che sono pochi in proporzione a un paese da circa un miliardo e mezzo di abitanti, ma parecchi come numeri assoluti (si stimano in 16 milioni). E di fronte al rischio di una nuova guerra fredda, o di una terza guerra mondiale frammentata, come paventato già da tempo da papa Francesco, la Santa sede ritiene di dover tenere aperto un canale di dialogo con un paese così grande e così influente come la Repubblica popolare cinese, nonostante intrattenga anche rapporti diplomatici ufficiali con la Repubblica di Cina, cioè Taiwan.
Lorenzo Lamperti
• Taiwan. Vento europeo sullo stretto, Lorenzo Lamperti, luglio 2022.
• Cina, Xinjiang. Autonomia made in Pechino (dossier), Piergiorgio Pescali, gennaio 2021.
73 × 24
Due dicembre 2016.
Donald Trump scrive su Twitter: «La presidente di Taiwan mi ha chiamato oggi per congratularsi per la vittoria nelle elezioni. Grazie». Aggiungendo qualche ora dopo: «Curioso come gli Stati Uniti vendano miliardi di dollari di equipaggiamento militare a Taiwan, ma io non avrei dovuto accettare una telefonata di congratulazioni».
Da quel giorno di poco più di cinque anni e mezzo fa il piano dello «stretto» (qui s’intende lo stretto di Taiwan, braccio di mare che separa l’isola principale alla Cina popolare, con una distanza minima di 143 km, ndr) si è fatto un poco più inclinato. Tendenze e questioni aperte già da decenni hanno subito un’accelerazione, soprattutto a livello retorico, ma anche strategico. Su questo cambio di velocità si innesta anche la guerra in Ucraina, che potrebbe avere effetti indiretti anche sullo stretto.
![]() Gli Stati Uniti hanno aumentato le dichiarazioni di sostegno a Taipei, sia con l’amministrazione Trump, sia con quella di Joe Biden, dimostrando di avere raggiunto un consenso bipartisan sulla sua importanza strategica. D’altronde, il Pentagono ha cambiato proprio nell’autunno 2021 l’individuazione del rivale strategico numero uno, che è diventato la Repubblica popolare cinese (sostituendo la Russia). Ecco che allora Taiwan diventa più importante che mai, in particolare sul piano commerciale, visto che Taipei è il nono partner di Washington (l’Ucraina solo il 67esimo). Partner dal punto di vista tecnologico, soprattutto per il fondamentale settore dei semiconduttori che è letteralmente dominato a livello globale dai colossi taiwanesi come Tsmc (Taiwan semiconductor manufactoring company), che controllano oltre il 50% della quota globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio.
Gli Stati Uniti hanno aumentato le dichiarazioni di sostegno a Taipei, sia con l’amministrazione Trump, sia con quella di Joe Biden, dimostrando di avere raggiunto un consenso bipartisan sulla sua importanza strategica. D’altronde, il Pentagono ha cambiato proprio nell’autunno 2021 l’individuazione del rivale strategico numero uno, che è diventato la Repubblica popolare cinese (sostituendo la Russia). Ecco che allora Taiwan diventa più importante che mai, in particolare sul piano commerciale, visto che Taipei è il nono partner di Washington (l’Ucraina solo il 67esimo). Partner dal punto di vista tecnologico, soprattutto per il fondamentale settore dei semiconduttori che è letteralmente dominato a livello globale dai colossi taiwanesi come Tsmc (Taiwan semiconductor manufactoring company), che controllano oltre il 50% della quota globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio.
Dal punto di vista strategico, visto il posizionamento dell’isola principale di Taiwan nella prima catena di isole del Pacifico, è questo il teatro nel quale appare chiaro ormai che si siano spostati i principali interessi geopolitici mondiali. Ma anche dal punto di vista retorico, Taipei è la dimostrazione vivente che la democrazia è possibile con una popolazione di etnia han (maggioritaria nella Cina continentale) da sbandierare alla Repubblica popolare suggerendo il regime change. Ecco allora le leggi per facilitare la vendita di armamenti, l’apertura di un’ambasciata de facto Usa a Taipei, l’eliminazione delle restrizioni auto imposte nei rapporti con ufficiali taiwanesi (decisa da Mike Pompeo poco prima di lasciare il Dipartimento di stato, ma mantenuta da Biden), l’invito della rappresentante taiwanese negli Usa all’insediamento del presidente democratico. Da ultimo, l’aggiornamento dei documenti con i quali il Dipartimento di stato descrive le relazioni degli Usa con Taiwan: è scomparsa la spiegazione della «Politica di una sola Cina», così come la specifica che «gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza di Taiwan».
Oltre alle mosse ufficiali bipartisan, ci sono state anche quelle implicite. Le presunte gaffe di Biden di questi mesi, quando in tre occasioni (l’ultima delle quali il 23 maggio scorso, durante il recente tour in Asia) ha dichiarato che c’è un impegno a difendere Taiwan in caso di aggressione esterna, hanno fatto improvvisamente sembrare la classica «ambiguità strategica» statunitense nei rapporti con Taipei (impegno al sostegno alla difesa della sua indipendenza de facto ma non impegno a intervenire militarmente) un po’ meno ambigua. Così come le ripetute indiscrezioni dei media americani sulla presenza di militari a stelle e strisce su suolo taiwanese avevano generato avvertimenti più minacciosi del solito dal governo di Pechino.
Eppure, Yan, ex militare in pensione, spiega: «Gli americani ci sono sempre stati, almeno da quando sono entrato nell’esercito io. E a mio parere Pechino lo ha sempre saputo». Yan parla di un piccolo gruppo presente «in pianta stabile per addestramento e supporto tecnico» e l’arrivo di una truppa più numerosa «una volta all’anno per un aggiornamento» fatto su una delle isole minori del Pacifico. Una versione che lascia interpretare in modo diverso l’ufficializzazione della presenza di questo contingente fatta a sorpresa dalla presidente Tsai Ing-wen in un’intervista alla Cnn in cui, ammettendo la presenza di alcuni istruttori americani, ha aggiunto: «Ma non sono quanti la gente crede». Ergo, messaggio implicito rivolto a Pechino (che fino ad allora aveva detto che avrebbe interpretato l’azione come una dichiarazione di guerra, ritenendo il suolo taiwanese suolo cinese) è stato: «Sono sempre gli stessi di cui sapete già». E, infatti, da lì le minacce di sorvolo diretto del territorio taiwanese da parte dei mezzi dell’Esercito popolare di liberazione sono svanite.
![]()
È però innegabile che la Repubblica popolare abbia intensificato le pressioni diplomatiche, propagandistiche e militari nei confronti di Taipei.
Dal 2019 le incursioni dei jet cinesi nello spazio di identificazione di difesa aerea avvengono su base pressoché quotidiana. La quantità e la qualità di queste incursioni aumenta in concomitanza con le novità che si apprendono sui rapporti tra Taiwan e Usa, oppure in occasione di giornate ad alto tasso retorico. Su tutte, le due celebrazioni nazionali a inizio ottobre della Repubblica popolare e della Repubblica di Cina (nome ufficiale di Taiwan, ndr). Così come si sono fatte più frequenti le esercitazioni militari navali sullo stretto. Ma le ripetute dimostrazioni di forza di Pechino stanno provocando un ulteriore allontanamento di Taipei.
Con il discorso di inizio anno del 2019, il presidente cinese Xi Jinping ha aumentato i discorsi retorici, dicendo che la questione taiwanese non può essere tramandata di generazione in generazione e che va risolta, se necessario, «anche con l’utilizzo della forza». Negli scorsi mesi è stato inserito un orizzonte temporale per ottenere il risultato, sia nella terza risoluzione storica, approvata al sesto plenum, che alle due sessioni dello scorso marzo: «Entro la nuova era». C’è chi individua i limiti temporali entro il classico 2049 (centenario della Repubblica popolare), ma chi invece ritiene si parli dell’orizzonte politico di Xi, avvicinando dunque il momento della resa dei conti.

Un momento che la maggioranza dei taiwanesi non vorrebbe arrivasse mai, visto che oltre l’80% di loro, secondo tutti i sondaggi, vede come soluzione ideale (quantomeno per ora), il mantenimento dello status quo.
I taiwanesi guardano con rabbia e timore alle manovre di Pechino, ma osservano (in silenzio) con qualche perplessità anche i colpi di testa americani. A Taipei si dice sempre che con gli Stati Uniti si vuole una «relazione stabile, non un amore passionale». Rassicurazioni, non inviti a camminare su sentieri ignoti. Per questo, a marzo, aveva destato qualche preoccupazione la visita di Pompeo (rigorosamente lontana dai riflettori). In calendario subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina, rischiava di innestarsi sulla narrativa del Partito comunista, che, come dopo la caduta di Kabul, ha subito insistito per dire ai taiwanesi: «Smettetela di flirtare con gli americani, nel momento del bisogno vi abbandoneranno come hanno fatto con gli afghani prima e gli ucraini poi». Visto che Pompeo e i trumpiani ascrivono la mossa di Vladimir Putin alla debolezza di Biden, eventuali parole fuori registro dell’ex segretario di Stato avrebbero potuto creare un mix letale per l’opinione pubblica taiwanese. Una delegazione di alti funzionari assemblata in fretta e furia e spedita a Taipei da Biden in anticipo di 48 ore su Pompeo ha smussato gli angoli, consentendo, tra l’altro, una presa di distanze implicita da quello che avrebbe detto anche agli occhi di Pechino.
![]()
I paragoni tra Taiwan e Ucraina, peraltro, non colgono le profonde differenze che intercorrono tra i due territori. Tutti gli attori in campo hanno caratteristiche diverse. Taipei è un attore economico cruciale a livello globale, ben più di Kiev. Pechino continua a perseguire la «riunificazione» (annessione per i taiwanesi) pacifica, anche perché considera Taiwan parte del suo territorio e dichiararle guerra sarebbe, dal suo punto di vista, come dichiarare guerra a se stessa. Washington ha interessi ben diversi su Taiwan rispetto a quelli mantenuti sull’Ucraina. Se la Cina è il rivale numero uno, Taipei è meno sacrificabile rispetto a Kiev.
I paralleli però ci sono soprattutto a livello retorico, con ricadute sull’opinione pubblica.
«All’inizio dell’invasione russa c’era molta preoccupazione, ma ora il governo taiwanese è almeno in parte sollevato guardando al sostegno ricevuto da Kiev in termini di aiuti militari e sanzioni alla Russia», spiega Jay Chen, capo redattore della Central news agency, agenzia di stampa taiwanese. «Più gli ucraini resistono e più lo fanno grazie all’aiuto dei partner occidentali e più anche i taiwanesi guadagnano convinzione che in un ipotetico conflitto futuro potrebbero fare lo stesso», prosegue Chen.
Recenti sondaggi mostrano che la percentuale di cittadini disposti a combattere per difendere Taiwan è notevolmente cresciuta, anche se è scesa la fiducia in un intervento militare diretto degli Usa in caso di invasione cinese. In questo senso, l’opinione pubblica ora sembra più disposta ad accettare mosse fino a qualche tempo fa impopolari come un’estensione della leva militare e un ampliamento del programma dedicato ai riservisti. Mentre aumentano le richieste agli Usa (anche del Giappone attraverso le parole dell’ex premier Shinzo Abe) di abbandonare l’ambiguità strategica.
Non è un caso che su Taiwan non ci sia spazio per nessun tipo di negoziato. Gli Usa non trattano e fanno passi verso Taipei; Pechino ribadisce che la «riunificazione» è un obiettivo «storico» e considera quella di Taiwan una questione interna. Utilizzando, tra l’altro, la propaganda russa sulla guerra in Ucraina in funzione anti Usa e anti Nato perché le è funzionale in Asia-Pacifico. Così come l’estensione dell’Alleanza Atlantica in Europa orientale ha «gettato benzina sul fuoco» e causato il conflitto in Ucraina, dice la Cina, i tentativi di accerchiamento in corso con le varie piattaforme di sicurezza come Quad (alleanza strategica Usa, India, Giappone e Australia, siglata nel 2017) e Aukus (Australia, Regno Unito, Usa, in partenariato strategico militare dal 2021) gettano benzina sul fuoco in Asia-Pacifico. Ergo: «Se in futuro ci sarà una guerra su Taiwan non sarà colpa nostra».
![]() La guerra in Ucraina sta portando Pechino ad aumentare la sua capacità di fuoco e la sua potenza nucleare, nel tentativo di scoraggiare non solo Taiwan a difendersi, ma anche Washington a intervenire. La stessa cosa provano a fare gli Usa facendosi vedere più spesso dalle parti dello stretto e organizzando tentativi di Nato asiatiche. Contestualmente, Xi affila l’arsenale normativo per sottomettere i taiwanesi.
La guerra in Ucraina sta portando Pechino ad aumentare la sua capacità di fuoco e la sua potenza nucleare, nel tentativo di scoraggiare non solo Taiwan a difendersi, ma anche Washington a intervenire. La stessa cosa provano a fare gli Usa facendosi vedere più spesso dalle parti dello stretto e organizzando tentativi di Nato asiatiche. Contestualmente, Xi affila l’arsenale normativo per sottomettere i taiwanesi.
Liste nere (esiste in Rpc una legge antisecessione che sanziona i secessionisti usando le black list, ndr), una possibile futura legge che prenda di mira non più i secessionisti ma tutti coloro che non si prodigano alla riunificazione. Basi legali per ipotetiche azioni militari.
In un complicato gioco di specchi e di deterrenza incrociata, entrambe le potenze percepiscono il rivale voglioso di cambiare lo status quo e dunque si sentono incentivate a testare le rispettive linee rosse. Taiwan, nel mezzo, cerca di non recidere completamente il rapporto con la Repubblica popolare. L’interscambio commerciale, che ha raggiunto il suo record storico nel 2021 nonostante le tensioni politiche, e l’approvvigionamento tecnologico della Rpc (con i grandi colossi che fungono da veri e propri attori diplomatici in assenza di dialogo tra i due governi), sono leve fondamentali alle quali Taiwan non vuole rinunciare, nonostante le pressioni americane. Ad esempio, per i semiconduttori Biden sta cercando di costruire catene di approvvigionamento «democratiche» che escludano Pechino. O, se fosse costretta a rinunciare agli affari con la Cina, chiederebbe garanzie più chiare di una difesa completa agli Usa.
C’è chi ritiene che i rapporti tra Pechino e Taipei abbiano già oltrepassato il punto di non ritorno e che il confronto diretto sullo stretto sia solo questione di tempo, a prescindere da come andrà in Ucraina. Eppure, c’è anche chi vede le cose diversamente. «Se non ci sarà la guerra, il corso degli eventi può nuovamente cambiare direzione», sostiene Chen Kuan-Ting, amministratore delegato del think tank taiwanese NextGen, ben inserito nelle dinamiche politiche locali. «Durante l’era di Hu Jintao i taiwanesi avevano iniziato a guardare alla Cina in un’altra maniera, e tantissimi hanno deciso di andare dall’altra parte dello stretto a lavorare o vivere», dice Chen. «Pechino può ancora riuscire a cambiare la sua immagine, se vuole conquistare il cuore dei taiwanesi, ha tanti modi per farlo. Ma se usasse la forza, quella possibilità si cancellerebbe e ogni rapporto verrebbe tagliato. Come sta succedendo tra Russia e Ucraina», prosegue Chen. Ma in che modo? «Condividiamo la stessa lingua e la stessa cultura, abbiamo rapporti profondi a livello commerciale: i taiwanesi non vogliono essere unificati, ma il dialogo potrebbe ripartire, se il Pcc (Partito comunista cinese) scegliesse di essere più aperto e non mostrare solo i muscoli», conclude Chen. «Non so, magari accadrà quando la Cina avrà un nuovo leader».
Tra pochi mesi, al XX Congresso, Xi dovrebbe però ricevere lo storico terzo mandato. E le lancette della nuova era continuano a scorrere.
Lorenzo Lamperti
Lorenzo Lamperti. Giornalista professionista, è direttore editoriale di China Files, scrive di Asia orientale per varie testate tra cui La Stampa, il Manifesto, Wired e think thank come Ispi.
China Files. È un collettivo di giornalisti, sinologi ed esperti di comunicazione specializzati in affari asiatici. Nata a Pechino nel 2008 come agenzia stampa focalizzata sulla Cina si è ampliata fino a coprire l’intera Asia. Ha già collaborato con MC. www.china-files.com
![]()
testo di Marco Bello |
La missionaria inglese Gladys Aylward (abbiamo raccontato la sua storia su MC ottobre 2021), dopo aver lasciato la Cina continentale nel 1949, avrebbe voluto tornarci nel 1957, ma si era vista rifiutare l’ingresso, nonostante fosse naturalizzata cinese. Si era quindi recata a Hong Kong, dove aveva lavorato per assistere i rifugiati cinesi, che in gran numero fuggivano dalla guerra civile, fondando con altri la Hope Mission.
Gladys si spostò poi a Taiwan (Formosa), dove nel 1949 il leader nazionalista Chang Kai-shek, in guerra con i comunisti di Mao, aveva ripiegato con le sue truppe, per quella che pensava sarebbe stata una ritirata temporanea. E invece sarebbe diventata la Repubblica di Cina, ancora oggi contestata dalla Repubblica popolare cinese.
«Non rimasi ad Hong Kong. Ancora una volta credevo di dover fare un passo successivo, e andai a Formosa. Ancora una volta, non sapevo perché vi stavo andando. Ma sapevo che era quello che dovevo fare», scrisse in seguito Gladys Aylward.
A Taipei (la capitale), dopo aver iniziato ad accogliere bambini orfani in un hotel che aveva preso in affitto nella zona di Beitou, Gladys Aylward venne aiutata dalla Ong statunitense World Vision ad acquisire un terreno nella zona di Muzha (1959). Lì iniziò la costruzione di un centro per bambini, chiamato Bethany nursey school.
Galdys morì il 3 gennaio 1970, ma i suoi collaboratori portarono avanti il progetto. Così, quello che dal 2010 venne rinominato Bethany children’s home (Bch), ha festeggiato i suoi primi 60 anni nel 2019 e continua a operare.
![]()
Ma sono tempi di grandi novità per l’opera fondata da Gladys Aylward. Da qualche anno erano iniziati i lavori per un nuovo edificio che corrisponde anche a una nuova «vision». Inoltre, nei primi mesi del 2020 da Taipei parte una telefonata, per l’altra parte del pianeta, che raggiunge Sharon Chiang a Seattle, negli Stati Uniti.
«Attraversavo un periodo di riflessione. Avevo passato la cinquantina e da venti anni lavoravo nella pastorale delle famiglie e dei bambini, per la Evangelical chinese church di Seattle (Ecc). Non avrei avuto altri vent’anni per lo stesso servizio, e volevo fare chiarezza sulla mia personale missione, per non avere rimpianti alla fine della vita». Ci racconta Sharon Chiang. La incontriamo tramite una piattaforma online: un viso solare, nel quale anche gli occhi sembrano sorridere dietro gli spessi occhiali.
![]()
«Avevo sempre cercato di mettere insieme i concetti di benessere dei bambini e relazioni famigliari, molto legati tra loro, ma non sempre presi in considerazione in modo olistico. Mi era chiaro che, per il resto della mia vita, le mie priorità erano tre: la formazione degli insegnanti dei bambini, le relazioni famigliari e il recupero delle coppie di genitori che entrano in conflitto. Perché i divorzi nel mondo sono sempre più frequenti, e i bambini sono le principali vittime delle separazioni».
Sharon è originaria di Taiwan, e dopo la laurea in educazione infantile, nel 1991, ha avuto la possibilità di trasferirsi a Seattle per continuare la sua formazione in «educazione e relazioni famigliari». Ha poi fatto un master sugli stessi temi e ha iniziato a lavorare per la Ecc. Infine, anni dopo, ha conseguito un dottorato sulle stesse tematiche: «Non avrei mai pensato di fare un dottorato, pensavo fossero studi per gente intelligente. L’ho fatto per approfondire con una ricerca il mio lavoro sul campo», ci confida con modestia.
Poi arriva la telefonata di un suo ex capo da Taipei: le chiede di prendere la direzione del Bethany children’s home, che sta passando un periodo complicato.
Dopo trent’anni di vita a Seattle, un marito violinista nella filarmonica locale, la scelta non è facile: «Ho pensato alle mie capacità, le mie conoscenze, e valutato se sarei stata all’altezza. Non conoscevo nulla sulla direzione di organizzazioni. Inoltre il Bethany (così chiama famigliarmente il centro, ndr) aveva un nuovo palazzo, molto bello, che avrebbe potuto portare la gente a pensare “siete molto ricchi”, mentre invece era indebitato. E come si poteva fare raccolta fondi in quella situazione? Queste erano le sfide maggiori che mi hanno fatto esitare. Infine, penso che Dio mi abbia toccato: Lui sarebbe stato con me, mi avrebbe aiutato. Quindi, anche se sarebbe stata una grande sfida, una grande responsabilità, un grande cambiamento, dentro di me mi sentivo davvero in pace. Ho pensato di andare avanti, e siamo partiti per Taiwan».
E continua: «Poi ho imparato di più su Bethany, ho letto sulla fondatrice, Gladys Aylward. Ho pensato di essere privilegiata di avere questo incarico, perché, posso immaginare, per lei la missione fu molto difficile. Passò attraverso esperienze molto dure, nella Cina continentale. Ma anche a Taiwan, quando arrivò, era un momento storico complesso, c’era molta povertà, la gente non aveva risorse né servizi, c’erano molti orfani, e nessun fondo per aiutarli».
La direttrice ci spiega quali sono le attività che attualmente si svolgono al Bethany.
L’attività principale è l’assistenza famigliare dei bambini svantaggiati utilizzando un modello casa-famiglia residenziale. Questo avviene con coppie, che sono residenti nella struttura (il nuovo palazzo ha una serie di alloggi, ndr) e accolgono dai quattro ai sei bambini in difficoltà. Alcune coppie hanno i propri figli, per cui ne prendono di meno in accudimento, altre no e quindi ne accolgono anche sei. Uno dei membri della coppia è salariato e fa parte dello staff di Bethany.
«Nel modello di cura famigliare facciamo venire una coppia cristiana e le affidiamo alcuni bambini. Sono piccoli che magari non hanno mai avuto una famiglia o genitori che si occupano di loro. Più conosco questo modello, più mi sembra un sistema perfetto. Con esso ogni famiglia vive nella struttura, per cui ogni membro del nostro team può andare in loro appoggio rapidamente. Abbiamo professionisti dei diversi settori per seguire i casi uno per uno, e in maniera costante e ravvicinata».
Alcuni bimbi hanno gravi disabilità: «Sono bambini abbandonati e abusati, fisicamente, emotivamente. Ci sono anche orfani, cosa molto triste, ma il peggio sono quelli abbandonati. E dobbiamo fare attenzione quando c’è combinazione multipla di disabilità. Visiva, motoria, di apprendimento. Altri sembrano stare bene, ma hanno subito dei traumi, quindi sono emozionalmente complessi. Il 75% dei nostri bambini hanno bisogni speciali, il che vuol dire anche problemi mentali, emotivi, ecc. È una grande sfida».
La struttura attualmente accoglie 25 bambini, ospitati da sei nuclei famigliari, ma la capienza massima è di settanta minori.
«Siamo pronti a ospitare più bambini, perché con la nuova struttura abbiamo gli spazi, ma dobbiamo comprare i mobili per sistemare gli alloggi». Inoltre ci sono problemi di costi, perché più famiglie vuol dire più staff da pagare, oltre al cibo e le normali spese di funzionamento.
Viene da pensare a Gladys Aylward, quando negli anni ‘30 e ‘40 del secolo scorso, nel Nord della Cina, accoglieva bambini abbandonati, e faceva praticamente da mamma a tutti, senza disponibilità di fondi. Arrivò fino a un centinaio. Ma ovviamente erano altri tempi.
![]()
Un secondo aspetto delle attività del Bethany è il counseling per bambini e giovani. Gli esperti dello staff seguono bimbi e ragazzi esterni al centro, sia di persona che tramite piattaforme online.
Inoltre, fondamentale per Sharon, c’è la formazione di insegnanti, soprattutto della scuola primaria, sulla pastorale dei bambini: «Occorre parlare loro di Gesù fin da piccoli, questo può influire molto sulla crescita». Il Bethany è anche un centro di formazione, con spazi per incontri in presenza, anche residenziali, ma oggi realizza una serie di corsi online. «Molti hanno chiuso le loro formazioni a causa della pandemia, ma c’è necessità di questo servizio. Noi abbiamo aperto una classe con 300 partecipanti a distanza, servendo diverse aree del paese e anche l’estero. Si tratta di una piattaforma per la formazione di insegnanti. È in cinese, ma che potremo farlo anche in inglese.
Un’altra attività è la sensibilizzazione di bambini, giovani e famiglie marginali.
Poi c’è il cosiddetto recupero di coppie in crisi: «Abbiamo inoltre spazi per accogliere coppie che vogliono fare un ritiro, nell’ottica di migliorare le relazioni famigliari. Lo scorso maggio era previsto un incontro per famiglie, ma a causa della pandemia, abbiamo dovuto rinviarlo».
Infine, c’è una parte di pastorale. «Vogliamo essere un centro missionario per bambini e famiglie. Abbiamo un settore specifico su questo, e una zona della struttura che si chiama “vieni”, come Gesù ci ha detto “venite a me, seguitemi”».
![]()
Il Bethany è organizzato in settori, quelli operativi relativi a ciascuna attività (assistenza famigliare, formazione, counseling, ecc.), e quelli di servizio: amministrazione e comunicazione.
«Siamo attualmente 32 nello staff, comprese una persona per ogni coppia affidataria. Al di sopra di questa struttura c’è un consiglio di amministrazione (board), presieduto dal presidente e rinnovato ogni tre anni. Si tratta di 14 persone con diverso background, leader di organizzazioni cristiane, professori, tutte con ottima reputazione».
Sharon porta avanti un’altra attività legata alla sua personale missione. Quando viveva a
Seattle organizzava incontri per raccontare la Bibbia ai bambini. «Poi è iniziata la pandemia e, seppure tra mille difficoltà, ho iniziato a incontrare i bambini su piattaforme online. Quando sono partita, ho pensato di lasciare questo impegno. Ma i genitori e i bambini mi hanno chiesto di continuare, perché sentivano questi incontri molto preziosi. Ho dunque continuato anche da Taipei, e ho associato ai bambini di Seattle quelli del Bethany. I bimbi leggono la Bibbia insieme, gli uni in inglese, gli altri in cinese. Ma questo ha dato loro un’apertura particolare. Il mio sogno è che questi bambini possano un giorno incontrarsi fisicamente».
Tutto questo fa parte della cosiddetta «Piattaforma missionaria per bambini e famiglie»: «Oggi possiamo essere più globali, siamo di fronte a una e-generation, è diventato facile incontrarsi a distanza e la gente si è abituata. Il modello è facilmente replicabile».
![]()
Il Bethany si finanzia con donazioni di molti piccoli donatori e beneficia di una piccola sovvenzione dello stato. «Ma i costi sono notevolmente aumentati a causa del nuovo edificio e del personale».
Tra le nuove sfide che attendono Sharon c’è l’aumento del numero di bambini accolti, obiettivo che prevede, oltre all’acquisto di mobili e attrezzature, il pagamento di nuove persone incaricate dell’accoglienza. «Vorrei che Bethany potesse accogliere sulla base della massima capienza, ci sono molti bambini nel bisogno.
Ma la sfida principale è questa pandemia – dice la direttrice – che ci limita molto. Potremo ospitare molti meeting ma, per ora non possiamo. Voglio poi far partire i “gruppi di recupero” per adulti, ma anche bambini, fratelli, sorelle. Eventualmente li faremo online».
«Sono molto onorata di continuare la missione di Gladys Aylward, perché è stata una donna che ha dedicato la sua vita intera ai bambini meno fortunati. Con risorse limitatissime e in condizioni difficili. Ho constatato che ha lasciato un’eredità bellissima e forte, come Bethany. Sono qui da un anno, ma spesso parlo di lei con lo staff, racconto la sua storia per far loro coraggio. Quando eravamo in difficoltà, l’anno scorso, dicevo che in passato non avevano aria condizionata, né una struttura come questa. Per ricordare loro che Dio ci penserà, lo ha fatto per 60 anni, durante i quali abbiamo aiutato un migliaio di bambini, e continuerà ad aiutarci».
Marco Bello
![]()
Anche la Consolata ha una giovane, ma solida, presenza a Taiwan. Il 12 settembre 2014 sbarcarono sull’isola i primi tre missionari, i padri Eugenio Boatella, Mathews Odhiambo Owuor e Piero de Maria. Si stabilirono a Hsinchu, nell’omonima diocesi, a meno di un centinaio di chilometri a Sud Ovest della capitale Taipei. Qui iniziarono a studiare la lingua (che non è cosa da poco) e apprendere la cultura, mettendosi a disposizione del vescovo con il quale fu firmato un accordo. Nel 2017 arrivò il secondo gruppo, con i padri Jasper Kirimi e Gilberto Rodriguez da Silva. Allo stesso tempo, i missionari presero in consegna la prima parrocchia, il Sacro Cuore di Gesù a Hsinchu.
Nel novembre del 2019 arrivarono i padri Bernardo Kim e Emanuel Barnabas Temu, e circa un anno dopo la Consolata prese in consegna la seconda parrocchia, San Giuseppe, sempre nella contea di Hsinchu.
I due pilastri della presenza della Consolata in Taiwan, scrive padre Mathews Odhiambo, attuale superiore, sono: «Proclamazione del Vangelo, preferibilmente a non cristiani. Questo giustifica la nostra presenza in Taiwan, dove i cristiani sono poco meno del 4% della popolazione. Questa missione è realizzata attraverso vari metodi: animazione missionaria, dialogo interreligioso, lavoro in parrocchia, con i giovani, con i migranti, ecc».
Il secondo pilastro è la promozione umana, «per tutte quelle situazioni umane di dolore e sofferenza, come povertà, ingiustizie sociali, malattie, ecc. Per questo la congregazione è impegnata in tutte le attività e i progetti che possono migliorare lo standard di vita della gente e alleviare i loro dolori e sofferenze».
Oggi, a sette anni dal loro arrivo, i missionari presenti sono cinque (i padri Eugenio e Piero sono partiti per altre destinazioni) e aspettano rinforzi. Intanto i progetti di lavoro con le comunità indigene (popoli originari dell’isola) e con i migranti (latini di lingua ispanica e anglofoni) sono nel cuore dei missionari. Torneremo a parlare di loro.
Marco Bello
testo di Marco Bello |
![]() «Il Dio di Gladys era per lei un’armatura impenetrabile alle frecce e alle pallottole che il mondo mortale poteva lanciarle. La sua fede era incrollabile […]. Nessun problema teologico la turbò mai: le paure e i dilemmi intellettuali soffiavano al di sopra del suo capo, a un livello stratosferico». Così scrive Alan Burgess, scrittore e biografo, a cui si deve la prima biografia della missionaria inglese Gladys Aylward, nel suo «The small woman», pubblicato nel 1957 (e tradotto in italiano un anno dopo con il titolo «La locanda della sesta felicità»).
«Il Dio di Gladys era per lei un’armatura impenetrabile alle frecce e alle pallottole che il mondo mortale poteva lanciarle. La sua fede era incrollabile […]. Nessun problema teologico la turbò mai: le paure e i dilemmi intellettuali soffiavano al di sopra del suo capo, a un livello stratosferico». Così scrive Alan Burgess, scrittore e biografo, a cui si deve la prima biografia della missionaria inglese Gladys Aylward, nel suo «The small woman», pubblicato nel 1957 (e tradotto in italiano un anno dopo con il titolo «La locanda della sesta felicità»).
Gladys era nata nel 1902, a Edmonton, un sobborgo a Nord di Londra, da una famiglia della working class. Non aveva mai viaggiato, «non ero mai stata oltre a poche miglia da casa mia», avrebbe confessato un giorno. Da giovane (erano gli anni ‘20 del XX secolo) amava danzare e andare a teatro, e voleva fare l’attrice. Non era molto alta, poco più di un metro e cinquanta, aveva i capelli neri, occhi vispi e tipico accento londinese. Dall’età di 14 anni iniziò a lavorare come cameriera nelle case dei ricchi e non era mai stata particolarmente religiosa.
Una sera, mentre con alcuni amici stava per andare a ballare, in una via affollata di Londra, fu presa in mezzo a un gruppo di giovani che entravano in una chiesa. Senza volerlo si trovò a seguire la funzione. «Quella sera, per la prima volta nella mia vita, realizzai che Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, era morto per Gladys Aylward. Questa percezione mi scosse e avrebbe alterato la mia intera vita», avrebbe scritto molti anni dopo. «Corsi a casa, mi buttai sul letto e pensai: Dio se sei vero mostrati, e se lo farai, prometto che io farò qualsiasi cosa mi chiederai».
La giovane donna non frequentava una chiesa, aveva poca dimestichezza con la Bibbia e non sapeva pregare. Iniziò a cercare se stessa. Un giorno lesse su un periodico che in Cina c’erano milioni di persone che non avevano mai sentito parlare di Cristo. «Pensai che era terribile passare la propria vita senza Cristo. Qualcuno avrebbe dovuto fare qualcosa». Cominciò allora a parlare con persone istruite, con competenze e posizioni sociali migliori delle sue, pensando che sarebbero dovuti intervenire loro. Ma nessuno la prese sul serio. Propose, infine, a suo fratello di partire lui per la Cina, promettendo che lo avrebbe aiutato. Lui rifiutò e la prese in giro, ma poi le disse: «Se davvero pensi che qualcuno debba andare, perché non vai tu stessa?».
Il fratello l’aveva messa davanti a uno specchio, e Gladys sprofondò nel dubbio: «Non ho mai fatto nulla di importante, non sono istruita, non ho soldi, non so predicare, non conosco nulla della chiesa». Ma arrivò a una conclusione: «Feci al Signore due promesse: se mi avesse mostrato la via, sarei andata io in Cina e non avrei mai più chiesto a nessuno di fare quello che lui avrebbe chiesto a me».
Il primo passo fu un periodo di prova presso il China Inland Mission, un’istituzione inglese che preparava e inviava missionari in Cina dal 1865. Ma dopo tre mesi il direttore le disse che non era idonea a diventare missionaria, perché, per il suo basso livello di istruzione, non avrebbe mai imparato il cinese e la teologia.
Gladys non si perse d’animo, sentiva forte la chiamata, e decise di partire da sola, senza l’appoggio di alcuna organizzazione. Però non aveva soldi né contatti. Riprese a lavorare duro, a servizio, facendo il massimo dell’economia. Per andare in Cina, all’epoca, c’erano due possibilità: per nave o per treno attraverso la Transiberiana. Questa seconda opzione era in quegli anni – fine anni ‘20 – altamente sconsigliata, a causa di una guerra non dichiarata tra Cina e Unione Sovietica ai confini della Manciuria, proprio dove passava il treno. Ma era molto meno cara. Gladys non volle sentire ragioni, e comprò, a rate, il biglietto.
Intanto studiava la Bibbia, e andava anche a tentare prediche pubbliche, che non godevano di grande considerazione, allo speaker’s corner di Hyde Park. Ebbe l’occasione di leggere diversi libri sulla Cina, quando fu a servizio da sir Francis Younghusband, che vi aveva lavorato.
Per le sue origini, Gladys era cresciuta nel mondo protestante anglosassone, anche se, per lei, quello che contava era essere cristiana.
In quel periodo, durante una funzione in una chiesa metodista, sentì dire che una missionaria in Cina, Jeannie Lawson, di 74 anni, cercava una giovane missionaria per portare avanti il suo lavoro. Fu come un colpo di fulmine, e Gladys scrisse subito una lettera alla Lawson, la quale, dopo mesi – i tempi dell’epoca -, rispose che l’avrebbe accettata.
![]()
Il 15 ottobre 1932, Gladys Aylward partì dalla stazione londinese di Liverpool street. Aveva due valigie: una conteneva vestiti e l’altra, cibo in scatola, biscotti, un fornello ad alcool, una padella, una teiera e un po’ di riso. Aveva con sé pochissimi soldi. A salutarla al binario c’erano la madre, il padre e la sorella, che non sapeva quando e se avrebbe rivisto. Non lo fece a cuor leggero, fu un grosso sacrificio lasciare la famiglia e il paese. Non aveva mai viaggiato all’estero, non era mai stata su un traghetto, né su un treno a lunga percorrenza.
«Non ho mai chiesto il permesso ai miei genitori. Ho detto loro che sarei partita. Erano i miei soldi ed era la mia vita. E pensavo che stavo facendo quello che Dio voleva che facessi. Quindi, anche se non capirono, essi accettarono e mi lasciarono andare», avrebbe raccontato.
La sua determinazione, e forse una dose di sana sprovvedutezza, la aiutarono, ma la spinta fondamentale fu la fede in quello che credeva fermamente Dio le avesse chiesto: andare a parlare di Cristo ai cinesi.
In quell’epoca, una giovane donna (aveva 28 anni) non viaggiava da sola. La guerra, sebbene non dichiarata, c’era eccome, e la corsa del treno fu interrotta nella città siberiana di Čita. Gladys rischiò di morire di freddo in Siberia, poi di essere trattenuta in Unione Sovietica. Ma fortunosamente qualcuno la salvò e, pure senza un soldo, da Vladivostok – dove era stata deviata a causa del conflitto – prese una nave che la portò in Giappone. Anche lì, a Kobe, una coppia di missionari la aiutò, e finalmente giunse nella città portuale cinese di Tientsin, dove fu accolta in una missione ben strutturata. Jeannie Lawson era conosciuta, e si sapeva che lavorava nello Shanxi, una provincia montagnosa e selvaggia a Nord Ovest di Pechino. I missionari del Tientsin mission center la affidarono al signor Lu, un uomo d’affari che stava partendo per quella terra. Anche quello sarebbe stato un viaggio lungo e faticoso. Presero il treno per un lungo tratto e poi un autobus.
Arrivarono a Zézhou dopo un mese e Gladys fu accolta da due anziane missionarie che le indicarono dove abitava Jeannie, a Yangcheng, ad alcuni giorni di viaggio. Non c’erano strade, e l’unico mezzo per arrivarci era a dorso di mulo.
![]()
L’incontro con Jeannie Lawson non fu caloroso. La missionaria scozzese era una donna brusca e, dopo 50 anni di servizio in Cina, non era facile da trattare per una giovane appena arrivata. In città non c’erano altri cristiani, e loro erano chiamate «diavoli stranieri»: i bambini scappavano e gli adulti tiravano loro del fango.
La regione era costantemente percorsa da mulattieri che con i loro muli trasportavano le merci tra le città e i villaggi fortificati sulle colline. Jeannie ebbe un’intuizione: «Se apriamo una locanda per mulattieri, diamo loro alloggio e un pasto caldo, potremo anche intrattenerli con delle storie – cosa che di solito amano – e racconteremo le storie di Cristo. I commercianti, poi, viaggiando porteranno questi racconti nell’intera provincia».
Fu così che nacque la «Locanda delle otto felicità», sembra in riferimento alle otto virtù confuciane, ma anche alle beatitudini del Vangelo di Matteo. Gladys aveva il compito di piazzarsi sul percorso dei muli in arrivo in città, e di tirare nel cortile della casa il primo della fila, in modo che gli altri seguissero. Era questa la maniera di procurarsi i clienti. Jeannie dava la zuppa ai mulattieri e intanto raccontava passi del Vangelo, mentre Gladys badava ai muli.
«Sebbene Jeannie non mi abbia mai insegnato a mangiare il cibo cinese con le bacchette, o qualcosa sui costumi locali, e neppure mi abbia mai dato un consiglio su come imparare la lingua, [da lei] imparai come pregare e guadagnare le anime delle persone per il mio Signore», avrebbe scritto poi Gladys.

Un anno dopo il suo arrivo, Jeannie morì. Gladys si ritrovò sola, arrivata da poco e, per di più, donna e straniera. La situazione delle donne all’epoca non era molto libera: «Adesso credevo che, in quanto giovane donna da sola, avrei dovuto andarmene. Inoltre, in Cina le donne non uscivano mai da sole, erano sempre accompagnate da un uomo della famiglia o da un servitore. E se non c’era questa possibilità, non uscivano di casa. […] Mi sentivo rinchiusa. Desideravo uscire. Ero giovane, ero contenta, volevo essere libera. E adesso ero chiusa in un piccolo cortile, che ogni sera si riempiva di animali e uomini». Mentre si chiedeva perché Dio l’avesse portata in quella città sperduta, unica cristiana, ed era presa dai dubbi su come procedere, pregava per un segno. Inoltre, Jeannie aveva una piccola rendita come missionaria, che con la sua morte si era estinta. Si presentava anche un problema economico.
In quegli anni Chang Kai-Shek, il capo di stato, divenuto cristiano, aveva messo al bando l’antica, e invalidante, usanza di bendare i piedi delle bimbe, che poi sarebbero rimasti piccoli e rovinati per sempre. Servivano ufficiali del governo che, a dorso di mulo o a piedi, percorressero il paese per sensibilizzare le popolazioni sulle nuove regole.

Il mandarino (capo politico) di Yangcheng si presentò in pompa magna nel cortile della locanda, e chiese (piuttosto ordinò) a Gladys di essere l’ispettrice dei piedi della sua area. Il motivo: era l’unica donna con «piedi grandi» e sarebbe servita da esempio. «Io rifiutai. Ero andata in Cina per Gesù Cristo e non volevo mischiarmi con questioni di governo, piedi e politica. […] Ma lui non se ne andava». La piccola donna iniziò a pregare nel suo intimo, non sapeva come uscire da quella situazione. Poi sentì come una voce, ebbe un’illuminazione: essere ufficiale del governo le avrebbe permesso di viaggiare in tutta la regione, incontrare e parlare con la gente nei villaggi più remoti, e ricevere pure un compenso economico. «Occorre dare tutti se stessi. Dio in quel momento non aveva bisogno delle mie mani, ma dei miei piedi! E li ebbe». Disse al mandarino che accettava, ma essendo lei una missionaria, avrebbe pure parlato alla gente della vita di Cristo. Il politico – che sarebbe poi diventato un suo caro amico, e si sarebbe convertito al cristianesimo – non vide in ciò nulla di cui preoccuparsi.
Gladys divenne nota e rispettata in Yangcheng e in tutta la zona. Iniziarono a darle il nome di Ài Wĕi Dé, ovvero «la virtuosa». Un giorno venne chiamata per sedare una rivolta nella prigione, e non senza paura, vi riuscì. Suggerì quindi migliorie, che furono adottate, per rendere la vita dei carcerati meno dura, e riuscì a predicare il vangelo anche tra di loro.
Gladys Aylward iniziava a inserirsi nella società delle montagne dello Shanxi, ma rimaneva comunque l’unica straniera. I più vicini erano i missionari di Zézhou con i quali fece amicizia. Sentiva che qualcosa nella sua vita non andava e, inoltre, come donna, molte cose non poteva farle.
«Pregai per avere un compagno […] La gioia di avere qualcuno con cui scalare le montagne, discutere, cantare e pregare. Ma non arrivò». Gladys avrebbe poi detto in un colloquio: «[Dio] lo chiamò, ma lui non arrivò mai». Il tempo passava e Gladys pensò che il Signore non l’avrebbe lasciata sola, e forse sarebbe arrivata una compagna di missione. Ma ancora nulla.
![]() Un giorno Ài Wĕi Dé assistette a una scena raccapricciante. Una megera maltrattava un bambino vestito di stracci. Era in vendita, in quell’epoca succedeva. «Lo vuoi comprare?», disse la megera. Gladys non se l’aspettava, e non aveva quasi denaro con sé. La commerciante di bambini insistette e alla fine la missionaria offrì quello che aveva, nove soldi. Era una bambina, e fu soprannominata Novesoldi: «Comprai la bambina. Fu il primo atto di quella che sarebbe stata la mia completa sottomissione al Signore. Non avevo compreso che stavo comprando la mia prima figlia, una bimba che stava entrando nella mia vita per significare molto. Dopo di lei arrivarono, uno dopo l’altro, gli altri, tutti in maniere differenti, in varie circostanze, ognuno così diverso in carattere e temperamento. Pregai Dio per loro. Egli ci nutrì, ci vestì. La situazione divenne caotica, ma eravamo molto felici. A un certo punto avevo 40 bambini. Chiesi a Dio di non mandarmene altri per favore. Ma il Signore non sempre risponde alle tue preghiere come ti aspetti».
Un giorno Ài Wĕi Dé assistette a una scena raccapricciante. Una megera maltrattava un bambino vestito di stracci. Era in vendita, in quell’epoca succedeva. «Lo vuoi comprare?», disse la megera. Gladys non se l’aspettava, e non aveva quasi denaro con sé. La commerciante di bambini insistette e alla fine la missionaria offrì quello che aveva, nove soldi. Era una bambina, e fu soprannominata Novesoldi: «Comprai la bambina. Fu il primo atto di quella che sarebbe stata la mia completa sottomissione al Signore. Non avevo compreso che stavo comprando la mia prima figlia, una bimba che stava entrando nella mia vita per significare molto. Dopo di lei arrivarono, uno dopo l’altro, gli altri, tutti in maniere differenti, in varie circostanze, ognuno così diverso in carattere e temperamento. Pregai Dio per loro. Egli ci nutrì, ci vestì. La situazione divenne caotica, ma eravamo molto felici. A un certo punto avevo 40 bambini. Chiesi a Dio di non mandarmene altri per favore. Ma il Signore non sempre risponde alle tue preghiere come ti aspetti».
Nel frattempo, Gladys Aylward decise di prendere la cittadinanza cinese, per sentirsi meglio in mezzo alla gente, diventò ufficialmente Ài Wĕi Dé. Anche se, nella pratica, poco cambiò.
Erano gli anni in cui cominciava la seconda guerra sino-giapponese (1937-45), che faceva parte di una vasta strategia di occupazione dell’Asia da parte del Giappone. In Cina si opponevano all’invasione l’esercito regolare nazionalista, ma anche i guerriglieri comunisti. La guerra arrivava da Est e inizialmente la gente delle montagne a Yangcheng non pensava di esserne coinvolta. Invece iniziarono i bombardamenti della città che crearono morte e distruzione. Gladys si adoperò organizzando i primi soccorsi. Portò i suoi bambini in un villaggio di montagna e faceva la spola con la città per aiutare. Ma poi i militari giapponesi arrivarono e commisero atti efferati. Gladys fu anche picchiata, riportando lesioni interne che le avrebbero poi creato problemi di salute e fu ferita da una pallottola alla schiena. Intanto gli orfani che raccoglieva aumentavano, perché, a causa della guerra, molti bambini restavano soli e vagavano per le campagne.
Quando la situazione stava per precipitare, la piccola donna decise che era il momento di partire per portare i bimbi in salvo da morte certa. Ne aveva circa un centinaio, una ventina dagli 11 ai 15 anni, tra i quali Novesoldi, e un gran numero di piccoli dai quattro anni in su. Si congedò dal mandarino, che non avrebbe mai più rivisto e che l’aiutò con un po’ di cibo per i primi giorni. Poi, il chiassoso gruppo, con lei unica adulta, partì a piedi verso le montagne, direzione Ovest. Era all’incirca il marzo del 1940.
![]()
Fu una scelta molto coraggiosa, da un’analisi superficiale si potrebbe dire incosciente. In realtà fu, come sempre per Ài Wĕi Dé, dettata da una grande fede, che le dava forza e una determinazione travolgente.
Dopo quasi due settimane arrivarono sulle sponde del Fiume Giallo che segna il confine Ovest tra lo Shanxi e lo Shaanxi. Tutti i villaggi erano stati abbandonati e la popolazione sfollata aveva attraversato il fiume per fuggire ai giapponesi. Non c’erano più barche. Gladys e i bambini erano allo stremo, affamati e sporchi, ma non si trovava da magiare. Se non avessero attraversato il grande fiume, sarebbero morti.
Dopo tre giorni, comparve un ufficiale dell’esercito nazionalista che pattugliava il fiume. Vedendoli in quello stato, e stupito di quella strana compagine, si adoperò per fare venire delle barche dall’altra riva e i 100 bambini con Gladys poterono proseguire.
Ci vollero ancora giorni, a piedi e poi su un treno merci, ma Ài Wĕi Dé riuscì a portare tutti i suoi bambini al sicuro, nei pressi della città di Xian (Shaanxi), dove erano stati allestiti dei campi profughi per la gente che fuggiva da Est. Avevano percorso oltre 400 km attraversando le montagne.
Gladys Aylward era però in pessime condizioni di salute. Perse conoscenza, fu curata e accudita alla missione di Xingping e all’ospedale della missione battista di Xian. Senza le cure sarebbe morta. Ci vollero mesi, ma si riprese.
In seguito lavorò nelle città Lanzhou (Gansu) e Chengdu (nello Sichuan, più a Sud ).
Gladys Aylward tornò in Inghilterra nel 1949 grazie all’interessamento di un’associazione statunitense, che le pagò il biglietto. Lasciò la Cina a malincuore, dopo tanti ripensamenti. Perché tutto ciò che amava era lì. Aveva bisogno di cure, inoltre con la vittoria dei comunisti iniziarono le persecuzioni delle religioni. Lei non voleva causare problemi a chi stava aiutando.
«Ci incontrammo, io e la famiglia (i ragazzi e bambini, ndr), per l’ultima volta in un campo fuori dalla città di Chengdu. Avevo deciso che era tempo di partire. Mettevo in pericolo chi stava con me perché, sebbene avessi un passaporto cinese, e fossi cinese nei miei pensieri, nel mio amore, nella mia lingua, nei vestiti e in tutto tranne che nel viso, avevo ancora la faccia di una straniera».
In Inghilterra si adoperò per i migranti cinesi, e per promuovere la missione. Voleva tornare in Cina, ma le autorità le rifiutarono l’autorizzazione.
Ài Wĕi Dé andò ad Hong Kong nel 1958, ancora sotto controllo britannico. La città era invasa di profughi arrivati dalla Cina popolare. Qui si prese cura di loro e contribuì a fondare la Hope Mission che li accoglieva.
Si trasferì quindi a Taiwan, dove, sull’isola di Formosa, i nazionalisti cinesi, guidati da Chang Kai-Shek, avevano fondato la Repubblica cinese.
Affittò un hotel chiuso a Beitou, appena fuori Taipei, la capitale, e vi fondò un orfanotrofio, il Gladys Aylward orphanage. Nei primi anni ‘60 arrivò dall’Inghilterra una giovane ad aiutarla, Kathleen Longton: finalmente Gladys ebbe la sua compagna di missione.
Nel 1959 acquistò un terreno a Muzha grazie all’aiuto della Ong statunitense World Vision e vi costruì un orfanotrofio che nel 1963 chiamò Bethany nursey school.
![]()
Il 3 gennaio 1970 Gladys Ài Wĕi Dé morì per le complicazioni di una semplice influenza, poche settimane prima di compiere 68 anni. Il suo fisico ormai cronicamente debilitato non andò oltre. Ma la sua opera continua, e si espande. Un gruppo di suoi collaboratori presero in mano la struttura nel 1971.
Una missionaria inglese Linda McFerren vi ha poi lavorato 26 anni con i colleghi cinesi (1992-2018). Nel 2010 la struttura ha cambiato statuto per adattarsi alla mutazione della società, e il nome è diventato Bethany children’s home. Un moderno centro per accoglienza di bambini e adolescenti (0-18 anni) in difficoltà. Il centro sperimenta un metodo innovativo di assistenza famigliare degli orfani. Oltre a continuare con i progetti di reinserimento, realizza servizi di sostegno per bambini svantaggiati e appoggio diretto alle famiglie problematiche.
Marco Bello
(fine prima puntata)
È il più grande mosaico di culture, popoli e tradizioni religiose. L’Asia è il continente meno cristiano del mondo, ed è, per questo, un campo d’azione naturale per la missione ad gentes. È la sfida che i missionari della Consolata hanno raccolto 30 anni fa aprendo le loro presenze nel 1988 in Corea del Sud, poi in Mongolia nel 2003 e a Taiwan nel 2014.
Da allora la sfida asiatica regala prospettive nuove alla missione dell’Imc, tanto da spingere i missionari a scrivere a chiare lettere nel loro «progetto Asia» presentato e approvato un anno fa al loro XIII Capitolo Generale tenutosi a Roma: «L’Asia, con la ricchezza del suo bagaglio storico e culturale, potrà forse non sentire il bisogno dell’Imc, ma l’Imc ha bisogno oggi dell’Asia per rinnovarsi ed esplorare orizzonti nuovi della missione».
Il continente e gli orizzonti nuovi che esso regala alla missione ce li racconta padre Giorgio Marengo, torinese di 44 anni, arrivato quindici anni fa nella capitale della Mongolia, Ulaanbaatar, con il primissimo gruppo di missionari e missionarie della Consolata, e ora parroco ad Arvaiheer, un piccolo centro nel cuore della steppa dove i cattolici sono 37.
![]()
Prendendo a riferimento un’espressione dell’arcivescovo emerito di Guwahati, India, Thomas Menamparampil, padre Giorgio ci introduce alla missione in Asia descrivendola come un «sussurrare il Vangelo al cuore» del continente. Sussurrare, cioè comunicare con discrezione qualcosa di intimo e di profondo in una condizione di vicinanza fisica e di fiducia, in una relazione personale che rispetta i tempi lunghi della maturazione, quando avviene.
Prossimità, amicizia, umiltà, rispetto, profondità. La missione della Chiesa in una situazione di minoranza, a volte di discriminazione o di persecuzione, spesso di irrilevanza, è interpretata da padre Marengo come una grazia. Essere minoranza dona maggiore libertà, conduce all’essenzialità, restituisce il missionario alla centralità dell’azione di Dio, più che alla sua, essendo la sua caratterizzata da povertà di mezzi e di efficacia. Il missionario in Asia si riscopre fragile, piccolo. E così ha la possibilità di assomigliare di più al seme che cade in terra e muore, dando (forse) poco frutto dal punto di vista umano, molto frutto dal punto di vista del Regno.
I missionari della Consolata a giugno ricordano e celebrano la loro fondatrice, Maria Consolata. In Asia, sussurrare il Vangelo significa sussurrarlo con lei, per tramite suo, nel suo stile. Anche la Consolata sussurra al cuore. Sta vicina come una madre che consola indicando il senso e il centro della vita di ciascuno: suo figlio Gesù.
Luca Lorussso
![]()
Presentare uno qualsiasi dei cinque continenti è un compito difficile, tanto più se si tratta dell’Asia1, continente che occupa il 30% delle terre emerse con i suoi 49 paesi e nel quale risiede il 60% della popolazione mondiale. In Asia convivono, in un affascinante intreccio, le tradizioni più antiche e le società più avanzate. È il continente di nascita delle principali religioni mondiali (Induismo, Buddhismo, Ebraismo, Cristianesimo, Islam) e di molte altre. Di fronte a una realtà così ampia e complessa, qualsiasi tentativo di renderne un’immagine sintetica ha il difetto dell’approssimazione e della generalizzazione. Tuttavia, ci vogliamo provare.
Data la vastità del suo territorio, le Nazioni unite suddividono l’Asia in cinque macroregioni (più una): Asia occidentale, centrale, meridionale, orientale e Sud Est asiatico, a cui si aggiunge la parte asiatica della Federazione Russa, la Siberia.
Nel continente si contano ben undici famiglie linguistiche delle quali fanno parte centinaia di idiomi. Le ricche ed elaborate lingue asiatiche (e le rispettive scritture) testimoniano uno «spessore» culturale davvero impressionante, che non si può trascurare. E ne sanno qualcosa i missionari non asiatici che si trovano nel continente.
![]()
Per entrare in empatia con i popoli che abitano l’Asia è necessario, innanzitutto, provare a individuare le tendenze di pensiero che li attraversano, spesso intrecciandosi tra loro.
Tra le fonti autorevoli c’è l’Ecclesia in Asia, l’esortazione apostolica postsinodale di Giovanni Paolo II, pubblicata nel 1999, che ci autorizza a spingerci in questa direzione: «I popoli dell’Asia sono fieri dei propri valori religiosi e culturali tipici, come ad esempio l’amore per il silenzio e la contemplazione, la semplicità, l’armonia, il distacco, la non violenza, lo spirito di duro lavoro, di disciplina, di vita frugale, la sete di conoscenza e di ricerca filosofica. Essi hanno cari i valori del rispetto per la vita, della compassione per ogni essere vivente, della vicinanza alla natura, del filiale rispetto per i genitori, per gli anziani e per gli antenati, ed un senso della comunità altamente sviluppato. In modo tutto particolare, considerano la famiglia come una sorgente vitale di forza, come una comunità strettamente intrecciata, che possiede un forte senso della solidarietà. I popoli dell’Asia sono conosciuti per il loro spirito di tolleranza religiosa e di coesistenza pacifica». Più avanti il testo chiama in causa «un innato intuito spirituale e una saggezza morale tipica dell’animo asiatico, che costituisce il nucleo attorno al quale si edifica una crescente coscienza di “essere abitante dell’Asia”».
Entrare in questo «intuito spirituale» è di fondamentale importanza per noi missionari. Thomas Menamparampil, arcivescovo emerito di Guwahati (India), asiatico ed esperto del settore, con una visione d’insieme ampia e allo stesso tempo dettagliata della vita religiosa del suo continente, ne propone quattro caratteristiche peculiari: il senso del sacro; l’intensità della ricerca di Dio e del divino; la semplicità di vita; l’aspirazione a propagare gli insegnamenti religiosi.
![]()
Il sacro e il divino fanno parte essenziale della psicologia collettiva asiatica. In molte parti del continente, i ritmi del vivere comune sono ancora oggi scanditi dalle pratiche religiose di svariate tradizioni (Induismo, Buddhismo, Islam, Giainismo, Taoismo, Shintornismo e altre ancora), senza che questo rappresenti in sé una stravaganza o una minaccia alla società regolata dai governi statali.
In alcuni paesi, anzi, sono tutt’ora in vigore forme di governo intimamente associate al potere religioso. In ogni caso, il sacro è qualcosa che non si discute neanche, perché appartiene all’evidenza del vissuto.
Altrove l’impatto con la modernità di stampo occidentale ha cambiato radicalmente l’atmosfera, imponendo stili e ritmi più secolari e apparentemente neutrali rispetto al dato religioso. Ma anche in tali contesti il riferimento religioso fondamentale resta un dato indiscusso, magari più relegato alla sfera privata, ma mai dimenticato o trascurabile. In Asia di solito non ci s’imbatte nell’affermazione «Dio è morto», bensì nella domanda «Quale Dio seguire?».
![]()
C’è un’aspettativa nel cuore di chi appartiene alle tradizioni religiose dell’Asia: il maestro, a qualunque gruppo appartenga, deve essere capace di indicare Dio, di parlare di lui e del suo piano per il bene del suo popolo. Questa è l’area in cui le persone religiose sono chiamate a essere competenti.
Il misticismo non è la scelta di una élite, ma una dimensione della vita che, se non tutti possono praticare (in molte tradizioni è riservata ai monaci), appartiene comunque all’immaginario collettivo come ideale da raggiungere.
Un’altra parola chiave della religiosità orientale è profondità. Una proposta spirituale che mancasse di questo carattere, apparirebbe inaffidabile, ingannevole. Profondo è ciò su cui si può costruire, ciò che sostiene anche se non si vede, è ciò che resta quando finiscono le parole; ciò che s’intuisce durante una cerimonia sacra o nell’armonia dell’arte religiosa; ciò che dura nel tempo, perché ha già attraversato tante generazioni e si è sedimentato in una letteratura, in testi sacri da maneggiare con rispetto.
Il passo dalla profondità alla preghiera è molto breve, anzi spontaneo. Preghiera e devozione sono un altro aspetto della medesima ricerca di Dio e del divino che in Asia ha prodotto esperienze tra le più ricche. La dimensione della preghiera, del culto e dei riti non si è mai offuscata (come invece è successo in Occidente), ha conosciuto un percorso storico in cui è rimasta viva e articolata. Pregare è la norma, non l’eccezione. Non va giustificata la preghiera, semmai va spiegata la sua originalità che la distingue da quella praticata in un’altra religione. In ogni caso l’esperienza di preghiera appartiene al cuore del cammino spirituale e costituisce il contesto più adatto alla comprensione e diffusione del messaggio religioso. Un aspetto strettamente collegato alla dimensione orante della vita è la ricerca di solitudine, di raccoglimento. In tutte le forme religiose sviluppatesi in Asia esiste un anelito all’intimità con il divino che solo una certa dose di isolamento e silenzio sembrano favorire. L’esercizio delle pratiche ascetiche richiede un contatto con se stessi che esige attenzione all’interiorità e distacco, almeno temporaneo.
![]()
Un altro aspetto della religiosità asiatica è il convergere di tante fedi sulla necessità e sul valore di uno stile di vita sobrio. La semplicità riflette un’attitudine molto apprezzata nella persona religiosa in Asia: il giusto distacco dalla materialità delle cose.
Semplicità e sobrietà favoriscono una vita centrata sull’essenziale, identificato quasi sempre con la ricerca spirituale. Una vita che si lasci sommergere da preoccupazioni mondane di ricchezza, accumulo e competizione tiene il praticante lontano dal raggiungimento dei suoi ideali.
Il concetto di «missione» è maturato in ambito cristiano e dunque gode di una sua originalità che l’Occidente postmoderno fa fatica a comprendere e accettare. In Asia invece la tendenza di una dottrina religiosa a diffondersi e quella dei suoi fedeli a propagarla è un dato pacificamente accettato, anzi ne testimonia la validità. Mentre in Occidente si manifesta resistenza (sensi di colpa storici, timore d’ingerenza nella libertà altrui, ecc.) nel panorama religioso asiatico non desta stupore il fatto che una dottrina o una via di sapienza cerchi di diffondersi.
![]()
In questa terra vasta e complessa, trova il suo spazio anche la fede cristiana, benché sia praticata per lo più in condizioni di minoranza e talvolta di discriminazione (o di aperta persecuzione; cfr Cristian Nani, Una fede pericolosa, MC maggio 2018). Negli ambienti missionari si parla di ad gentes per indicare lo specifico della missione in contesti in cui essa rappresenta per gli interlocutori il venire in contatto per la prima volta con il Vangelo e la persona di Gesù Cristo, dal momento che altre tradizioni religiose e culturali hanno plasmato quelle società. Ebbene, in Asia l’ad gentes è una realtà evidente. Non v’è dubbio che i non cristiani sono gli interlocutori principali della Chiesa in Asia. Per questo motivo il magistero missionario del postconcilio ha più volte richiamato l’attenzione proprio sul continente asiatico descrivendolo come il più bisognoso di evangelizzazione2.
A questo riguardo Ecclesia in Asia, al n.1 dice: «Dato che Gesù è nato, vissuto, morto e risorto in Terra Santa, questa piccola porzione dell’Asia occidentale è diventata terra di promessa e di speranza per tutto il genere umano. Gesù conobbe ed amò quella terra, facendo sue la storia, le sofferenze e le speranze di quel popolo; ne ebbe cara la gente». Soffermiamoci su queste ultime parole: anche noi siamo chiamati a entrare in questo movimento di amore per i popoli dell’Asia. È la legge dell’incarnazione che ci spinge a entrare in profonda sintonia con le persone a cui siamo mandati, e quindi con le loro culture, la loro storia, le loro tradizioni religiose e filosofiche, la loro sapienza, la loro psicologia.
Giorgio Marengo
1 M. De Giorgi, Missione e culture in Asia. Tra passato e presente, in «Quaderni del Centro Studi Asiatico», 11 (2016).
2 Giovanni Paolo II indicava il continente asiatico come quello «verso cui dovrebbe orientarsi principalmente la missione ad gentes» (Redemptoris Missio, 37).
![]()
Il Cristianesimo ha conosciuto una sua diffusione in Asia già dai primi secoli. C’è un dato storico che a molti sfugge: all’indomani della Pentecoste, la prima generazione di credenti si spinse in due direzioni, nel bacino del Mediterraneo, giungendo fino al cuore dell’Impero romano, e in direzione Est, verso l’Asia appunto.
I cristiani d’Oriente avevano centri di eccellenza teologica, monasteri e biblioteche nella zona dell’attuale Turchia e Iran. Questa cristianità assunse ben presto dei tratti peculiari, arrivando anche a dissentire su questioni teologiche ai concili ecumenici, come testimoniato dal caso del patriarca di Costantinopoli Nestorio a Calcedonia (451).
Fu proprio grazie ai credenti delle prime generazioni, soprattutto attraverso le vie del commercio che già attraversavano il continente (come la via della seta), che il Vangelo giunse alle popolazioni asiatiche.
La storiografia tende a identificare questi cristiani con l’appellativo di Nestoriani. Occorrerebbe precisare questo titolo e il suo significato; in ogni caso, accettando convenzionalmente la dicitura, dobbiamo riconoscere che già intorno al VII secolo la fede cristiana era attestata in Cina e quasi contemporaneamente nelle zone centrali del continente. Per non parlare dell’India, con la sua tradizione sull’apostolo Tommaso.
Furono poi gli ordini mendicanti del XIII secolo a prendere il testimone dell’evangelizzazione del continente, dopo l’avanzata dell’Islam e il consolidarsi del Buddhismo in gran parte dei territori.
Quando i Gesuiti arrivarono in Cina e Giappone nel XVI secolo iniziò una nuova fase. Il dato è che, per vari fattori storico culturali, a quel tempo il Cristianesimo era rimasto ai margini delle società in cui era penetrato e, in alcuni casi, del tutto perduto.
Eventi storici non favorevoli? Errori di strategia missionaria? Mancanze e debolezze dei missionari stessi? Incidenti diplomatici?
Tutto va certamente analizzato, però a me piace pensare che la situazione di minoranza in cui versa la fede cristiana anche oggi in Asia non sia da ascriversi solamente a una congiuntura storico sociale, e che ci riveli qualcosa di profondo e, in qualche modo, di provvidenziale: non necessariamente il cristianesimo è destinato a diventare cristianità, a plasmare cioè società intere, al punto di diventare la religione principale (e dominante).
Se in occidente questa è stata l’evoluzione, non è detto che essa sia l’unica possibile e neanche la più auspicabile. È importante rendersi conto che non esiste solo il modello Europeo, come se le società dovessero in qualche modo attestarsi tutte in modo naturale sulle stesse posizioni.
Il nostro punto di riferimento deve sempre rimanere il Vangelo, la logica del Regno di Dio che Gesù ha sempre descritto in termini di piccolezza, sproporzione, inferiorità, seme che cade in terra e muore, lievito nella pasta, lume di una candela che illumina la stanza.
Il primo Asian Mission Congress, tenutosi in Thailandia nel 2006, tirava queste conclusioni, guardando alla storia del Cristianesimo nel continente: la Chiesa Cattolica in Asia ha dato il più alto numero di martiri. Dovunque ci sono missionari o cristiani locali che sopportano fatiche per la loro fede, facendo della loro vita un dono per gli altri, la Chiesa cresce. La testimonianza vivente di molti cristiani in Asia è un miracolo degno di essere celebrato.
G.M.
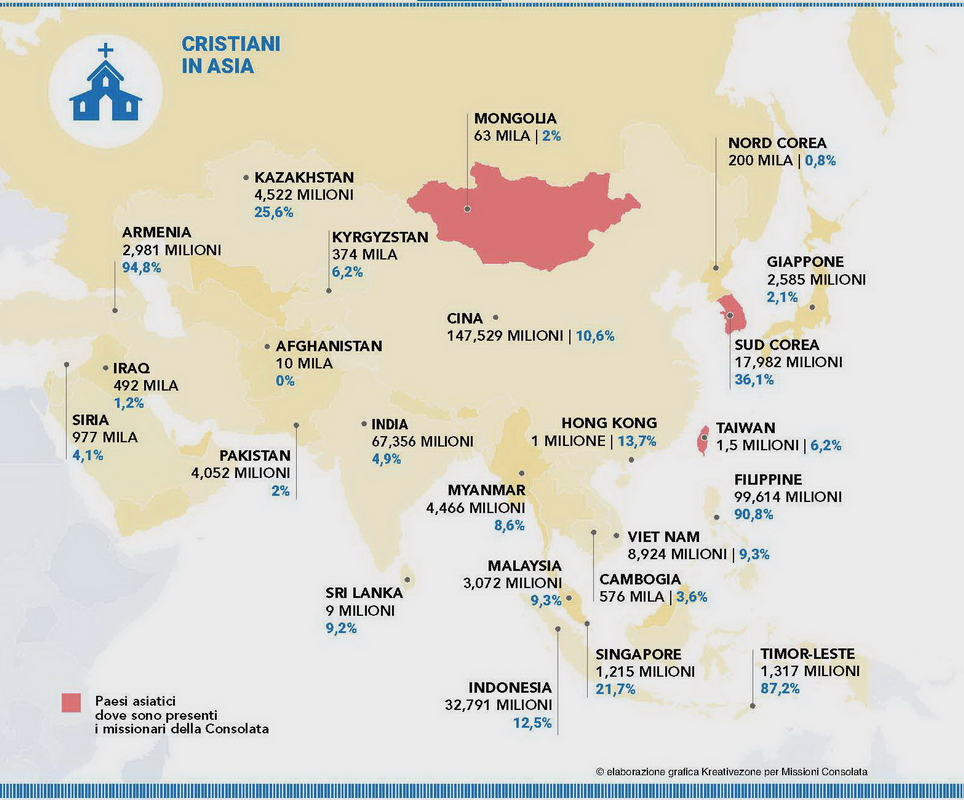
Il parlare cristiano di Dio è percepito nell’Occidente postmoderno come qualcosa di «antipatico». Forse è per questo che viene spontaneo concentrarsi più sui mezzi per farlo che sui contenuti. Come se dovessimo ottenere un lasciapassare, un’autorizzazione che ci verrebbe concessa, appunto, per il semplice fatto di usare tecniche comunemente riconosciute.
Se questo fosse vero, il rischio grave sarebbe quello di perdere l’originalità del messaggio cristiano che sta proprio nel suo essere scandaloso. Parla, infatti, dell’irruzione nel mondo di Dio fattosi carne, di Dio che abita la nostra umanità allargandola al cielo.
Il dire cristiano su Dio e la missione, stanno in questo paradosso: del Dio ineffabile non si può parlare e, allo stesso tempo, non si può tacere.
![]()
La missione sta nel mettere in comunicazione il «cuore» con il Vangelo e nell’innescare quel delicato processo di dialogo e crescita nel quale nessuno dei due interlocutori rimane indifferente all’altro. Ecco perché vorrei parlare della missione come di un «sussurrare il Vangelo al cuore dell’Asia», prendendo in prestito l’espressione usata al sinodo per l’Asia del 1999 da Thomas Menamparampil, arcivescovo emerito di Guwahati (India): perché ritengo che per parlare del mistero di quest’incontro, sia più efficace un’espressione evocativa, un’immagine, piuttosto che una teoria o un «paradigma» missionario.
Quest’espressione sta avendo, con sorpresa dello stesso Menamparampil, un grande impatto nella riflessione missiologica del continente. Egli la usa come una sorta di bilancio dei suoi 80 anni spesi ad annunciare il Vangelo nel mondo indiano e nelle tante parti d’Asia nelle quali la Provvidenza lo ha chiamato. Allo stesso tempo ritiene che sia in qualche modo la «formula» per il futuro del lavoro missionario nel suo continente. E, io aggiungerei, anche negli altri.
Il verbo «sussurrare» allude a una relazione. Nel nostro caso, una relazione con Dio ricevuta come dono e coltivata come scelta d’intimità, preghiera, dialogo vitale. Noi missionari siamo chiamati a sussurrare al cuore di Dio e a lasciare che Colui che ci manda a essere sue epifanie presso i popoli asiatici sussurri al nostro cuore. Siamo chiamati a metterci in relazione con le persone alle quali siamo inviati, alla vicinanza, all’immersione nel loro mondo.
Due persone si sussurrano a vicenda qualcosa solo quando sono in confidenza. Non si sussurra all’orecchio del primo che capita. E quello che si comunica nel sussurro è qualcosa di profondo, di vitale, che esige un certo pudore, un’aura di mistero, oltre che di rispetto.
Da quando mons. Menamparampil ha usato quest’espressione, essa è rimasta impressa in molti. Alcuni gli hanno fatto notare che suonava come una posizione troppo timida, quasi in contrasto con il coraggio che proprio in quegli anni Giovanni Paolo II chiedeva alla chiesa missionaria. In realtà l’espressione non invita al timore o al calcolo («se sussurriamo forse evitiamo conflitti»), ma alla necessità di mettere al centro dello stile missionario prossimità, fiducia e profondità.
Non sono forse questi gli strumenti con cui il Signore introdusse progressivamente i suoi amici al mistero della sua persona? Vengono in mente le scene dell’incontro di Gesù con la samaritana, con Nicodemo e, soprattutto, con i discepoli al cenacolo. Gesù si consegna ai suoi, versa il suo cuore proprio nel contesto di un incontro intimo, che anticipa il suo sacrificio.
![]()
Il verbo «sussurrare» è evocativo già nella sua pronuncia: è musicale, produce un suono leggero e gradevole per l’orecchio. Ha il significato di «dire a voce bassa e sommessa, perché senta solo chi è vicino, o la persona a cui ci si rivolge»3. Esso indica, quindi, una modalità di comunicazione personale, che avviene nell’ambito di una relazione di amicizia, confidenzialità e sintonia, in un clima di empatia, discrezione e pacatezza. Torna alla mente l’immagine del servo del Signore che «non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce» (Is 42,2), scelta da Gesù per descrivere il suo ministero (cfr. Mt 12).
In Asia ci sono insegnamenti sacri nelle sue numerose tradizioni religiose che vanno trasmessi in confidenzialità: i sutra, ad esempio, ma anche i mantra, parole sacre recitate spesso sottovoce.
Così la Parola evangelica: per la sua qualità di essere allo stesso tempo rivelata e ineffabile, perché appartenente a Dio Altissimo, rifugge i toni chiassosi e gli slogan. Pensiamo a colui che è padre di noi missionari della Consolata nella sequela e nella missione, il beato Giuseppe Allamano, e alla sua attenzione alla persona, alla sua riservatezza, al suo stile discreto. La consegna della Parola sembra più adeguata quando a sussurrarla sono persone diventate segno di quel mistero che essa significa e a cui rimanda.
La missione in Asia ci spinge oggi a riaprirci a dimensioni che forse non eravamo più abituati a considerare come specifiche della nostra vocazione. Una di esse è la preghiera. Normalmente, infatti, si associa alla missione prima di tutto l’idea della promozione umana, della lotta alla povertà, all’ingiustizia. C’è stato un tempo in cui lo slancio per le grandi cause dell’umanità ci aveva quasi fatto mettere da parte la preghiera, considerata una caratteristica adatta più ai contemplativi che a noi. «Noi – si diceva – siamo missionari, quindi…». Quindi? Pensiamo veramente che la missione sia esclusivamente un «fare»? E cos’è che davvero qualifica il nostro fare? La preghiera è solo una sorta di dovere da adempiere per essere dei bravi missionari, ma che «accadrebbe» separatamente dalla missione? Prima o dopo, ma non contemporaneamente? Devo a tutti i costi «fare qualcosa» per sentirmi missionario o posso prendermi del tempo per capire quali siano le «cose» più richieste dalla realtà in cui vivo?
![]()
Non esiste un solo modo di essere missionari; è invece importante che le nostre scelte siano in piena sintonia con il carisma del Beato Allamano.
Non si tratta di rinunciare all’azione per ritirarsi in una contemplazione staccata dalla realtà, ma di cogliere la sfida che l’Asia ci lancia per (ri)scoprire tutta la fecondità della dimensione contemplativa della missione.
Sembra, infatti, che nei nostri ambienti si faccia ancora fatica a comprendere che facciamo missione nell’atto stesso del nostro darci a Dio nella preghiera. Nonostante l’esempio di alcuni grandi missionari degli ultimi decenni: Charles de Foucauld, i monaci martiri dell’Algeria, madre Teresa di Calcutta, per non parlare del nostro Fondatore.
Mons. Menamparampil lo dice così: «La necessità di penetrare il mondo interiore di una società e di capire il suo funzionamento e la conformazione dei suoi ritmi emozionali è estremamente importante quando si tratta di condividere la propria fede. Più la si condivide in maniera casuale, più essa rimane superficiale. L’aspetto della profondità è importante come la qualità dell’intimità. Gli Asiatici stimano la profondità al di là di quale sia la fede a cui uno appartiene. Essa indica anche l’intimità che la persona ha con il suo “sé” reale. Nella spiritualità indiana, la ricerca del “sé” è uno degli obiettivi più alti. Se il comunicatore è vicino al suo “sé superficiale”, anche il contenuto e lo stile della sua comunicazione lo rifletteranno. Ma se egli è spesso con il suo “sé più profondo”, quando comunica un messaggio attrae l’attenzione»4. Oggi, anche grazie all’esperienza della missione in Asia, siamo più consapevoli che la preghiera è essa stessa via di evangelizzazione.
Tornando all’immagine del «sussurrare», è importante sottolineare che è il Vangelo a essere sussurrato e nient’altro, tanto meno qualcosa che appartenga solo all’evangelizzatore. Ad accogliere (o rifiutare) il Vangelo, poi, è niente meno che il cuore dell’altro, quel luogo nel quale risiede il suo mondo, la sua cultura, il suo orizzonte.
«Parlare di Dio non può essere come far calare una cappa di piombo sulle cose – scrive Fabrice Hadjadj, scrittore e filosofo francese -. Prima di tutto è un’alba che sorge. […] Ecco l’ineffabile: sta di casa sotto le parole di tutti i giorni. […] Non possiamo parlarne come si parla di una cosa fra le tante, ma non possiamo neppure parlare delle cose della vita se taciamo di Lui che è il loro principio e il loro fine. Portare il suo Nome non vuol dire farlo cadere dall’alto, ma lasciarlo salire dal fondo di ogni realtà. In questo modo la domanda “come parlare di Dio?”, rinvia non tanto a un argomento di conversazione, ma a una modalità ospitale di uso della parola»5.
![]()
Il carattere «ospitale» è proprio quello che vorrei descrivere per la missione in Asia: un’ospitalità evangelica restituita a chi ha accolto a casa sua i missionari del Vangelo. E quanto impegno devono profondere i missionari per farsi accogliere davvero dai popoli asiatici. Spesso è forte la sensazione di essere appena tollerati. In questo impegno di empatia, ascolto, studio, inculturazione, non dobbiamo mai perdere di vista il carattere scandaloso del Vangelo: infatti non è raro che la libertà altrui, rispettata e fattivamente accolta, comporti il rifiuto. Scrive ancora Hadjadj: «L’efficacia della proclamazione genera sempre la possibilità di un rifiuto ancora più violento di quello prodotto da una proclamazione meno efficace. […] Sarebbe un errore credere che, se perfetta, la comunicazione evangelica otterrebbe un consenso necessario»6.
Tra le varie figure di spicco che nel secolo scorso hanno saputo andare in profondità nell’esplorare (e vivere) la missione e che ci pare utile citare, c’è Catherine Doherty (1896 – 1985). Ispirandosi a uno scritto di Jacques Loew, l’attivista russa emigrata in America riassumeva l’attività missionaria in tre fasi: un tempo di amicizia, un tempo della Parola e un tempo del sacramento. La prima fase, quella dell’amicizia, è per lei fondamentale: non è semplicemente una preparazione, destinata a scomparire in uno stadio successivo, ma la costante che accompagna sempre la vita missionaria. È da seguire con pazienza, senza fretta. Questo tempo di amicizia è il tempo più lungo, la dimensione principale che caratterizza l’azione missionaria. Nella vita dell’evangelizzatore è il risvolto esistenziale, pratico, dell’incarnazione di Dio: assumere la condizione umana, entrare nella trama del tempo e dello spazio e, dunque, della cultura, della storia, della terra così come si presenta nel luogo specifico nel quale ci si trova.
C’è poi la seconda fase, quella della parola. Essa si realizza solo quando l’amicizia ha messo radici profonde. Solo allora si è in grado di esternare la «notizia bella» che si è stati inviati ad annunciare.
Anche qui l’insistenza di Catherine Doherty è sulla delicatezza, la prudenza: «Lo facciamo lentamente, con gentilezza, cambiando la fraseologia e la semantica, in modo che siano adatte ad ogni persona e ad ogni contesto».
È in questo momento che si fa esperienza di tutta l’inadeguatezza strutturale che ci si porta addosso. Per gli evangelizzatori che hanno abbandonato la loro terra per inserirsi in un’altra, questa è l’esperienza più radicale: lingua, riferimenti socio-culturali, storia, tradizioni, religioni sono altri rispetto ai propri, e ci si rende conto che questo incide non poco sulla comunicazione e l’annuncio. È allora che si diventa veri strumenti di chi invia, perché si apre la bocca «in suo nome», non confidando nelle proprie strategie e risorse. S’impara a riconoscere chi si è veramente: un seme che deve morire se vuol portare frutto. In questa impotenza consegnata si apre il solco perché la Parola venga sussurrata, cada e porti frutto.
La terza fase infine è quella del sacramento. È il passaggio cruciale, anzi cruciforme. È il vivere in prima persona la Pasqua, il passaggio dal predominio del proprio io a quello della Grazia. Questo rende liberi, come lo era san Paolo al termine del suo pellegrinaggio terreno. Non si dipende più dalla realizzazione di un qualche proposito o dal giudizio altrui (positivo o negativo che sia), ma unicamente dallo Spirito che cristifica, che porta l’immagine alla somiglianza.
![]()
Una riflessione missionaria che non tenga conto di questo mistero di conformazione al Cristo crocifisso e risorto si ferma sulla soglia. Le tre fasi descritte dalla Doherty non sono altro che gli stadi attraversati da Cristo stesso. E la proporzione tra di essi dice qualcosa d’importante al modo di concepire e vivere la missione: trent’anni spesi nel tempo dell’amicizia, tre anni di Parola (il suo ministero pubblico) e pochi giorni nel compimento del mistero pasquale.
Raccontare il Vangelo, anzi, sussurrarlo, trasmette la fede – o, meglio, genera alla fede – solo dentro una particolare vicinanza, quella che si crea in relazioni di prossimità discreta che possono diventare autentica fraternità.
Far fiorire è il mestiere di Dio. All’evangelizzatore è riservato il lavoro sul terreno.
Giorgio Marengo
3 Cfr. la voce «sussurrare» in Treccani 2014 – Dizionario della Lingua Italiana, Giunti Scuola, Firenze 2013.
4 Citazione da un testo inedito di T. Menamparampil, condivisomi di recente da lui stesso.
5 F. Hadjadj, Come parlare di Dio oggi? Antimanuale di evangelizzazione, Edizioni Messaggero, Padova 2013, 56-57.
6 Come parlare di Dio oggi?, cit., 101.
![]() Siamo nel mese del quale celebriamo la Consolata. In tutto il mondo, decine di comunità la ricordano e festeggiano. Cosa succederebbe se sostituissimo la parola «Vangelo» con il nome di Maria nell’espressione di mons. Menamparampil, «Sussurrare la Consolata al cuore dell’Asia»?
Siamo nel mese del quale celebriamo la Consolata. In tutto il mondo, decine di comunità la ricordano e festeggiano. Cosa succederebbe se sostituissimo la parola «Vangelo» con il nome di Maria nell’espressione di mons. Menamparampil, «Sussurrare la Consolata al cuore dell’Asia»?
Sarebbe forse suggestivo, ci dice padre Giorgio Marengo, autore di questo dossier, ma si arriverebbe allo stesso punto. Perché sussurrare la Consolata all’orecchio di qualcuno vorrebbe comunque dire indicare Maria che, a sua volta, indica suo Figlio.
«Penso che “sussurrare la Consolata” si possa dire nel senso di aiutare le persone a riferirsi a lei in una maniera esperienziale, confidenziale. Cosa che tra l’altro in qualche modo gli asiatici già fanno.
Se noi sussurriamo Gesù, dentro quel sussurro c’è anche lei. Ogni volta che invitiamo qualcuno ad aprirsi al Signore, in questa dinamica c’è la presenza di Maria. Viceversa, più si sta con lei, più si va verso Gesù».

Nel processo di sussurrare il Vangelo, la Madonna è quella dalla quale i missionari imparano, perché la vicinanza, la discrezione, l’ascolto, la profondità sono tutte caratteristiche di Maria che, con la sua presenza discreta che non attira a sé ma a suo figlio, indica lo stile giusto. «Sussurriamo suo figlio e allo stesso tempo imitiamo lei, che è schiva ma anche presente».
Oltre alla figura di Maria Consolata, anche il tema della consolazione è in sintonia con lo stile del sussurro. «L’aspetto della Consolazione credo che sia una delle nostre caratteristiche che meglio si sposa con l’Asia, con alcune delle componenti della sua spiritualità. Ad esempio uno dei pilastri forti della spiritualità buddhista è la compassione», ci conferma padre Ugo Pozzoli, fino a un anno fa membro del consiglio Generale dell’Imc con l’incarico speciale di seguire l’Europa e l’Asia. «Per dire consolazione in mongolo – aggiunge padre Giorgio – ci sono almeno tre espressioni: la prima si riferisce all’azione di calmare un dolore fisico. Si trova ad esempio nei bugiardini delle medicine: sollievo da una pena. Poi c’è una seconda espressione che ha un significato più ampio, simile a quello che intendiamo noi per consolare. Infine la terza espressione può essere tradotta letteralmente con “aggiustare il cuore”, nel senso di riparare, sistemare, come fa un meccanico con un motore. Effettivamente Maria aggiusta il nostro cuore, lo sintonizza con il cuore di Dio. Lo purifica, lo cura».
Sussurrare il Vangelo con la Consolata, quindi, sapendo che il contenuto del sussurro rimane Gesù.
Luca Lorusso

Il sogno asiatico dell’Istituto è antico. Un primo tentativo di «sbarcare» in Asia avviene tra il 1928 e il ‘29, quando quattro missionari della Consolata giungonoi in India, nella provincia del Madhia Pradesh. L’esperienza dura solo tre mesi, interrotta dalle decisioni della Visita Apostolica che l’Istituto subisce in quegli anni.
Quando si apre la prima stabile presenza Imc in Corea del Sud nel 1988, si realizza un desiderio che è appartenuto già al beato Giuseppe Allamano: «Io non vedrò, ma un giorno andrete in Cina, India, Giappone, Tibet…». Nel gennaio di quell’anno arrivano nel paese asiatico i primi quattro missionari della Consolata. Le altre due aperture avvengono nel 2003 in Mongolia e nel 2014 a Taiwan. In Mongolia, i primi missionari, arrivati assieme alle missionarie della Consolata, entrano nell’estate del 2003, si stabiliscono nella capitale, Ulaanbaatar, con l’intento di «fare missione insieme, in comunione». A Taiwan si inizia nel settembre 2014.
Il mandato dell’ultimo Capitolo Generale è quello di rafforzare le presenze attuali in modo da consolidarle e dare all’Imc in Asia una prospettiva concreta di permanenza e sviluppo.
Luca Lorusso
![]()
L’ambiente umano in cui la Chiesa si trova a vivere e testimoniare la propria fede in Asia è per lo più di vero ad gentes, nel senso che trova i propri riferimenti e identità al di fuori del Cristianesimo.
Questo dato è di notevole importanza, perché indica che la presenza e l’operato della Chiesa si confrontano quotidianamente con la poca visibilità e, molto spesso, la pura insignificanza. Siamo lontani da realtà in cui la Chiesa rappresenta una forza trainante della società e un’istituzione riconosciuta e stimata (o criticata).
Il confronto storico forse più pregnante è quello con le prime comunità cristiane diffusesi a Est del fiume Eufrate nell’età postapostolica. Esse dovettero misurarsi da subito con culture e tradizioni religiose preesistenti e con i più diversi sistemi politici, quasi sempre non benevoli nei loro confronti.
Proprio questo carattere minoritario, defilato, quasi nascosto è, però, altamente significativo e può rappresentare una grande risorsa. La Chiesa è più simile al seme caduto in terra. Cresce nel nascondimento e può dedicarsi più liberamente all’essenziale. Si regge sull’oblatività dei suoi membri ed è scevra da protagonismi e tentazioni mediatiche. Niente a che vedere con una mentalità da ghetto o da rifugio esclusivista, al contrario, la povertà di immagine e di influenza sociale permette una maggiore trasparenza al messaggio evangelico.
Questa condizione di minoritarietà può allora diventare scelta consapevole di un’evangelizzazione portata avanti con la testimonianza personale, i contatti fraterni, l’impegno non rumoroso per una società più giusta e accogliente.
![]()
È interessante constatare come anche nell’Occidente postmoderno questa dimensione della testimonianza sembra aprire spazi di luce sul tema della missione. «L’annuncio si trasforma in testimonianza vissuta; testimonianza che, appunto, presuppone una mancanza di dimostrazione e di evidenza, ma che unica può trasformare il linguaggio verbale in un linguaggio pratico ed etico. In questa maniera la missionarietà non indirizza le sue energie nel raccapezzare un senso ormai disperso, ma tenta di evangelizzare il frammento diventando in sé stessa richiamo agapico. […] La testimonianza lascia spazio alla meraviglia, allo stupore, all’incomprensione, cioè a quegli atteggiamenti che trasportano il soggetto postmoderno “al di fuori di sé” nell’attimo di un incontro»7.
L’Ecclesia in Asia lo ha detto chiaramente al n. 23: «Un fuoco non può essere acceso che mediante qualcosa che sia esso stesso infiammato». Non sentiamo qui riecheggiare le parole del nostro fondatore il beato Giuseppe Allamano? Dovremmo forse fermarci a considerare più a lungo il suo insegnamento: la sua è una vera e propria «mistica dell’annuncio missionario», come l’ha sviscerata e portata in luce il troppo poco conosciuto studio del domenicano padre Ceslao Pera8.
L’originalità di una missione veramente ad gentes è anche questa: il missionario vive in un ambiente privo di riferimenti (almeno espliciti) al Cristianesimo. L’impegno per comprendere e decifrare tale ambiente apporta conoscenze nuove, fa scoprire modi altri di vedere la vita e la relazione con il divino e, dunque, provoca la fede a una ricomprensione radicale di se stessa.
Il dialogo diventa allora una scuola di studio e di riflessione che, oltre ad arricchire il missionario di conoscenze su altre tradizioni, l’aiuta a dischiudere la profondità del mistero cristiano in un modo forse più determinante di quanto non avvenga all’interno di una società «cristiana».

L’aveva capito molto bene san Francesco Saverio nel XVI secolo: nelle sue lettere rivolte a chi lo avrebbe seguito in India e in Giappone egli insisteva molto sulla virtù apostolica dell’umiltà interiore. In una lettera del 1549 da Kagoshima (Giappone) avvisava i candidati alla missione asiatica che avrebbero dovuto affrontare una triplice tentazione: il pericolo della paura, il rischio della presunzione e la possibilità di evasione dal reale.
L’impatto con culture, religioni, società, situazioni ambientali e umane così altre mette paura, provoca un inaspettato contatto con la parte più fragile di noi stessi. Ecco allora il primo grande vantaggio: dalle ceneri del nostro io andato in frantumi può nascere una nuova fiducia in Dio: «Vi scongiuro pertanto, in tutte le vostre cose fondatevi totalmente in Dio, senza confidare nel vostro potere o sapere od opinione umana»9.
La seconda tentazione è quella della presunzione: a volte, il missionario è tentato di giudicare le cose non a partire dal Vangelo, ma dai propri riferimenti culturali, rasentando il complesso di superiorità. Il contatto con le ricche tradizioni asiatiche può stemperare questo rischio: «Credetemi, voi che verrete in questo paese, avrete l’occasione di provare quanto valete. Per quanta diligenza voi mettiate per guadagnare ed ottenere molte virtù, siate certi che non ne avrete mai abbastanza»10. Anche questa è una grazia.
Ma c’è una terza prova a cui i missionari sono sottoposti in Asia: il rischio di evadere continuamente dalle sfide del quotidiano rifugiandosi in una realtà creata da loro stessi. Oggi, con l’aiuto di social network e nuove tecnologie, rischiamo di essere fisicamente in un posto e col cuore in un altro: «Stanno nelle Indie, ma vivono col desiderio in Portogallo»11. Anche in questo caso l’unica medicina è l’umiltà di affidarsi a Dio in quel presente che magari vorremmo diverso, ma che è l’unico orizzonte in cui possiamo davvero incontrare il Signore.
Mettendo in guardia i suoi confratelli gesuiti, san Francesco li conduce al cuore dell’esperienza apostolica. Lo stesso fa papa Francesco quando ci dice che siamo testimoni del Risorto in mezzo ai popoli proprio perché abbiamo toccato con mano la nostra povertà e l’abbiamo consegnata a Lui, confidando nella sua misericordia. Siamo «paralitici guariti». Questa fiducia ci abilita a chinarci sulle ferite del prossimo per versarvi l’olio della consolazione. È questa l’esperienza fontale dell’apostolo, e noi in Asia siamo chiamati a viverla ogni giorno, accompagnando persone che, con il loro cammino di fede, ci aiutano a fare verità in noi stessi e a percorrere insieme a loro lo stesso sentiero di rinascita12.
![]()
Da san Francesco Saverio impariamo poi un aspetto della prima evangelizzazione che talvolta viene taciuto o mal interpretato. Il grande missionario ritorna spesso a considerare come il male si opponga all’avanzata del Regno di Dio. La missione ad gentes deve trovarci attenti a questo scontro, quello che san Giovanni nel suo Vangelo descrive come la resistenza delle tenebre ad accettare la luce. Con questo non si vuol dire che il mondo non ancora raggiunto dall’annuncio evangelico sia in sé compromesso dal male, anzi, con il libro della Sapienza, noi crediamo che «le creature del mondo sono sane, in esse non c’è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra» (Sap 1,14), ma allo stesso tempo crediamo anche che forze nemiche alla luce di Cristo operino per contrastarla. A cominciare dal nostro io, spesso diviso, e dai tanti interessi mondani che spesso opprimono la coscienza di interi gruppi umani.
Queste forze negative sono un motivo in più per prendere sul serio la dimensione orante della missione. Per poter stare in piedi, dobbiamo saper stare in ginocchio.
Prima e al di là di qualsiasi atto pratico (il progetto, l’iniziativa di sviluppo, ecc.), la missione è manifestazione umana, relazionale, della misericordia divina che Gesù ha incarnato. L’esperienza missionaria in Asia ci insegna molto, aiutandoci ad andare all’essenziale: un annuncio che si fa sussurro confidenziale, condivisione sincera, umile servizio offerto senza aspettarsi nulla in cambio. Non abbiamo nulla da dimostrare, ma «solo» Gesù da mostrare con la vita e, se necessario, con la parola.
Padre Gabriele Ferrari, già padre generale dei missionari Saveriani, parla addirittura di «esposizione di Gesù», che «sarà tanto più efficace quanto più semplice, povero e disarmato sarà lo stile di missione»13. L’esposizione del Santissimo Sacramento sui nostri altari diventi allora la sua esposizione in vite trasfigurate dalla sua bellezza: la notizia non è solo «buona», ma principalmente «bella». Il bello sconvolgente dell’amore crocifisso di Gesù attirerà le persone in mezzo alle quali noi viviamo in semplicità, non in case piene di regole, porte e strutture, ma in umili dimore accoglienti, povere e belle, dove l’armonia esteriore sarà un richiamo al fatto che un altro mondo è possibile, la vita non è solo miseria e stenti, la vita in Cristo è luminosa e vale la pena di essere vissuta.
Giorgio Marengo
7 T. Tosolini, Dire Dio nel tramonto. Per una teologia della missione nel postmoderno, Emi, Bologna 1999, 15.
8 Ceslao Pera O.P., La spiritualità missionaria nel pensiero del Servo di Dio Giuseppe Allamano, Edizioni Missioni Consolata, Torino, 1973.
9 F. X. Léon-Dufour, Francesco Saverio. Vita avventurosa e dimensione mistica dell’apostolo delle Indie, primo missionario gesuita, Piemme, Casale Monferrato 1995.
10 Id, 83.
11 Id, 88.
12 Da più di un anno seguiamo ad Arvaiheer un gruppo di Alcolisti Anonimi; il primo dei 12 passi che costituiscono il loro percorso di guarigione è riconoscere di averne bisogno. Mi sembra il punto di partenza di ogni vera conversione.
13 G. Ferrari, È proprio impossibile uscirne?, in «Testimoni», 2/2017, 12-16.
![]()
Testo Mirco Elena |
Un recente studio, pubblicato dal quotidiano United Daily News1, sostiene quanto segue: il 73% della popolazione dell’isola dichiara di sentirsi taiwanese, mentre cinese solo l’11%2. Un’analoga inchiesta effettuata vent’anni prima, trovava valori rispettivamente del 44% e del 31%. Se ne può quindi dedurre come un certo spirito indipendentista si sia molto rafforzato. Ancora più impressionante appare il cambiamento se si considera che, nella fascia d’età 20-29 anni, questo dato sale addirittura all’85%. Per completare il quadro, si noti che il 10% della popolazione si sente sia taiwanese che cinese, mentre il 6% delle persone si è rifiutato di rispondere alle domande dell’indagine. Una domanda più politica ha infine riguardato l’indipendenza del paese, con il 46% della popolazione che si è dichiarata in favore della prosecuzione indefinita dell’attuale situazione, mentre il 19% preferirebbe muovere velocemente verso l’indipendenza e solo il 4% vorrebbe invece una rapida unificazione con il continente. Il 17% è infine a favore dell’indipendenza, ma preceduta da un lungo status quo. Considerando tutti quelli in vario modo a favore dell’indipendenza, si nota infine che il loro numero è aumentato dell’8% rispetto all’anno precedente.
Essendo chiaro a tutti che il processo di distacco formale dall’idea di una Cina unificata potrebbe comportare gravi rischi, l’indagine ha anche esaminato il prezzo che i cittadini sarebbero disposti a pagare, pur di ottenere l’indipendenza formale. Ne è risultato che il 43% della popolazione complessiva taiwanese potrebbe accettare un drastico calo dei turisti provenienti dalla Cina; per un 20%, l’isola potrebbe sopportare la perdita della maggior parte dei suoi circa 20 alleati diplomatici all’Onu, e addirittura una guerra. Il 16% affronterebbe un blocco economico. Infine poco più del 20% della popolazione pensa invece che l’indipendenza dell’isola non meriti alcun sacrificio.

Quando si arriva a Taipei, capitale di Taiwan, ci si potrebbe attendere di trovarsi in un ambiente tipicamente cinese. Certamente lo è, per gli ideogrammi presenti ovunque, per la simbologia religiosa, per le decorazioni, ma basta poco per rendersi conto che ci sono alcune notevoli differenze rispetto alla Cina continentale. Se la popolazione di quest’ultima è, per certi aspetti e modi di fare, molto simile a quella italiana3, i taiwanesi sono in un certo senso molto più «tedeschi» (ma, per ragioni geografiche e storiche, meglio sarebbe dire «giapponesi»). La capitale taiwanese è più pulita rispetto alla media cinese; la gente ha un maggior civismo e senso dell’ordine.
Da quanto detto in precedenza, risulterà facile capire come questa differenza si possa probabilmente far risalire all’effetto del mezzo secolo di colonizzazione giapponese, durata dal 1895 al 1945. Con tipica efficienza nipponica l’amministrazione isolana di quel periodo operò in modo da inculcare nella popolazione locale i modi ed i valori propri dell’arcipelago del sol levante: pulizia, ordine, efficienza, senso del dovere. Quando subentrarono i nazionalisti cinesi di Chiang Kai-shek, questi portarono con loro alcune tradizionali caratteristiche cinesi antitetiche a quelle giapponesi: burocrazia arrogante, familismo, corruzione diffusa, disorganizzazione, individualismo anarcoide ed egoistico. Non proprio quello cui erano stati abituati i taiwanesi. Aggiungiamoci l’esercizio della violenza per reprimere ogni protesta e dissenso ed ecco che l’origine dell’insoddisfazione di molti taiwanesi diventa comprensibile. Se ciò non bastasse, ricordiamo come un ruolo non trascurabile debba averlo giocato anche la notizia delle atrocità e delle distruzioni perpetrate dalle guardie rosse al tempo della rivoluzione culturale scatenata da Mao sulla terraferma.

Quanto ancor oggi ci sia di «giapponese» nella società taiwanese lo possiamo dedurre da qualche episodio, successo direttamente all’autore di queste righe o riferitogli da fonti affidabili. Iniziamo da quel che capita un sabato quando alle quattro di mattina mi trovo a dover attraversare una strada cittadina a quattro corsie per prendere l’autobus che avrebbe dovuto poi portarmi all’aeroporto di Taipei. Traffico zero. Nessuno in giro. O quasi. Quando arrivo al semaforo che regola l’attraversamento pedonale c’è lì un signore che disciplinatamente attende che diventi verde. La tentazione di attraversare, pur col rosso, è forte. Mi pare illogico e inutile aspettare in quelle condizioni; oltre a noi due non c’è anima viva né traccia di autoveicoli nei dintorni. Lui, tranquillo, aspetta; io fremo. Mi dà però fastidio l’idea di mostrarmi un ospite cafone, che arriva in una nazione e ne viola le regole. Allora attendo anch’io. Il silenzioso e paziente signore, forse senza nemmeno volerlo, mi ha dato una lezione di civismo.
La disciplina dei taiwanesi appare chiara anche al momento di salire su un mezzo di trasporto pubblico, o di avvicinarsi ad uno sportello. Anziché gettarsi all’assalto, come tende ad avvenire sulla terraferma, i cittadini dell’isola si dispongono in fila e pazientemente attendono il loro turno. Come gentlemen inglesi.
Cyril, un francese stabilitosi sull’isola dopo aver sposato una ragazza locale, mi racconta che qui tantissime persone usano moto e motorini. Ma non era necessario che me lo dicesse lui; me ne ero già accorto, girando per la città. Quel che mi sorprende è invece la sua assicurazione che tutti usano lasciare il casco (che si deve obbligatoriamente indossare quando si è sul mezzo) semplicemente appoggiato sulla moto, quando questa viene parcheggiata; anche quando la si lascia per la notte a lato della strada. Nessuno lo fissa con un lucchetto, dato che non c’è chi pensi di rubarlo. O quasi. Cyril mi confessa che, in dodici anni di permanenza sull’isola, gliene hanno involato solo uno, nuovissimo e rosso brillante, proprio il giorno in cui lo aveva comperato. Il commento del filosofico Cyril è semplicemente «era troppo bello, avrebbe fatto gola a chiunque!». Ancora in fatto di furti, mi dice che, per la sua esperienza di insegnante di lingue, se uno scolaretto trova per terra una banconota da cento dollari, la prima cosa che fa è andare dalla polizia o da un vigile a consegnarla. Non proprio il tipo di comportamento che ci si aspetta di trovare in Cina continentale (ma nemmeno in Italia, a essere sinceri).
Da questi piccoli esempi non possiamo certo trarre nulla di più che qualche modesta indicazione sull’animo, la cultura, i modi di fare dei taiwanesi. Resta il fatto che, come si è visto un poco anche alle ultime elezioni, l’insofferenza per Pechino è forte in ampi settori sociali.

Come si esce da una situazione in cui potrebbe bastare un errore di valutazione, una dichiarazione azzardata, un intervento esterno mal progettato e peggio eseguito per scatenare uno scontro militare di ampie e imprevedibili proporzioni? Abbiamo già detto che gli Usa sono da tempo impegnati a difendere Taiwan nel caso venisse attaccata dalla Cina. Data anche la loro tendenza storica ad usare la forza per risolvere intricati problemi politici, questo potrebbe facilmente portare ad uno scontro tra le due grandi potenze4, che potrebbe sfociare in uno scambio nucleare. Nonostante la disparità di forze in campo (la Cina ha circa 300 ordigni, mentre gli Usa oltre 5.000, di cui «solo» 1.500 operativi) gli esiti sarebbero certo pesanti per entrambe le nazioni e l’intero quadrante geopolitico Est asiatico (se non addirittura quello mondiale) potrebbe venirne stravolto.

La modalità più sicura per evitare problemi così seri sarebbe certo quella di ridurre la tensione e la probabilità del ricorso ai mezzi militari. Potrebbe risultare decisiva una ribadita adesione taiwanese all’idea di una sola grande Cina, immaginata, almeno in prospettiva, riunificata. In subordine potrebbe bastare, almeno per il momento, il mantenimento dello status quo, in cui Taiwan non si esprime chiaramente né a favore né contro l’unificazione o l’indipendenza.
Un utile passo avanti si potrebbe poi avere se lo speciale regime autonomo vigente a Hong Kong5 continuasse ad avere successo nel garantire le libertà politiche, economiche e sociali. In tal modo assicurando i taiwanesi che, anche nell’ipotesi di una riunificazione con Pechino, le caratteristiche fondamentali della loro democrazia sarebbero preservate e protette.
Positiva sarebbe anche una maggior comprensione da parte americana delle sensibilità della Repubblica popolare, così da evitare mosse interpretate come provocatorie ed offensive. Purtroppo, specie in epoca Trump, questo appare niente più che un evanescente sogno.
Non si dimentichi tuttavia che proprio la Cina ha bisogno di una situazione di perdurante pace, per poter continuare il proprio ambizioso programma di ammodernamento e di miglioramento degli standard di vita di tutta la popolazione. Inoltre la sua attuale forte inferiorità militare può e deve indurre Pechino ad essere prudente, anche nel caso debba ingoiare qualche indigesto rospo a stelle e strisce.
Sulla base di queste considerazioni, e ricorrendo abbondantemente all’ottimismo, possiamo confidare che, nonostante le periodiche tensioni e le loro accentuazioni, non si giunga a scontri militari potenzialmente in grado di portare a una situazione catastrofica. Questo detto, forse è meglio che chi ha fede, preghi che davvero sia così. E chi non crede, incroci le dita.
Mirco Elena
(seconda parte – fine)
(1) Giornale che si caratterizza per una posizione fondamentalmente a favore dell’unificazione con la Cina.
(2) Rilevazione compiuta tra il 15 e il 19 febbraio 2016, su un campione di 1.019 persone, con un margine di errore dichiarato del +/-3,1%.
(3) Si veda il libro «Cina e Italia allo specchio», di Mirco Elena e Yu Jin, pubblicato nel 2015 dal «Centro studi Martino Martini per le relazioni culturali Europa-Cina» di Trento.
(4) Certo si potrebbe pensare che la promessa americana costituisca nulla più che un bluff, dato che la Cina ha la capacita di lanciare missili con testata nucleare in grado di raggiungere il territorio statunitense, con ciò disponendo di un potente strumento di dissuasione nei confronti degli statunitensi.
(5) Riassunto nel motto «Un paese, due sistemi».

Al contrario che nella Cina continentale a Taiwan la libertà religiosa è assicurata. Questo ha generato un mosaico di fedi assai variegato.
L’ultima inchiesta pubblica – condotta dalla sezione affari religiosi del ministero dell’Interno – sulla situazione a Taiwan risale al 2005. Secondo questo studio, il 35% della popolazione taiwanese si considera buddhista e un 33% taoista. Di rilievo sono anche alcune religioni sincretiche di origine cinese come il Yiguandao (I-Kuan Tao), che attinge da buddhismo, taoismo e confucianesimo, ma anche dal cristianesimo. Questa religione è illegale nella Cina continentale.
La ricerca del 2005 evidenzia anche la presenza di circa un milione di aderenti al Falun Gong, la disciplina spirituale che utilizza elementi della cultura tradizionale cinese (ma che in Cina è fuorilegge dal 1999).
Il cristianesimo arrivò a Taiwan (allora nota come Formosa, dal nome affibbiato all’isola dai marinai portoghesi) con gli spagnoli (1626-1642) e con gli olandesi (1624-1662), che alla fine prevalsero. I primi vi portarono il cattolicesimo, i secondi il protestantesimo. Oggi si contano più di 900mila cristiani, di cui 600mila protestanti e 300mila cattolici. I cristiani – pari a circa il 3,9 per cento della popolazione totale – sono soprattutto tra le popolazioni aborigene (appartenenti queste al gruppo austronesiano) e tra gli immigrati filippini. Anche l’islam è presente, ma quasi esclusivamente tra gli immigrati indonesiani.
Pa.Mo.

Testo di MIRCO ELENA; foto di MIRCO ELENA e AfMC |
Tra i tanti luoghi del nostro pianeta ove le tensioni politiche potrebbero portare a uno scontro militare su grande scala, spicca sicuramente Taiwan per la sua storia drammatica.
Con la fine della seconda guerra mondiale, si ebbe in Cina la ripresa del conflitto civile che divideva da tempo i nazionalisti del Kuomintang (Kmt) e i comunisti di Mao Ze Dong. Lo scontro fratricida era stato momentaneamente sospeso per fare fronte comune all’invasione giapponese, ma riprese nel 1946, poco dopo la sconfitta dell’esercito nipponico. Temprati da molti anni di lotta, i comunisti ebbero la meglio e, nel 1949, costrinsero gli avversari del Kmt a ritirarsi dal continente e a rifugiarsi, assieme a due milioni di profughi politici, sulla piccola isola che si trovava poco al largo delle coste della provincia del Fujian. Qui giunta, l’armata in rotta impose la legge marziale1, applicata con il pugno di ferro dal suo leader, il «generalissimo» Jiang Jieshi (da noi meglio noto come Chiang Kai-shek). Egli rimase al potere fino al 1975, anno della sua morte. A tutt’oggi non è mai stata firmata ufficialmente una tregua tra i due contendenti, né tanto meno la pace.
![]()
Nel 1945, la gran parte della popolazione taiwanese parlava correntemente il giapponese2. Nell’ottobre di quell’anno, dopo la resa dei Giapponesi, il territorio dell’isola fu affidato dall’Unrra (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) al governo della «Repubblica di Cina» che era in lotta con la «Repubblica popolare» che aveva la propria capitale a Pechino. Fu inevitabile qualche problema comunicativo, dato che a Taiwan il giapponese era stato per decenni la lingua ufficiale, mentre la popolazione parlava dialetti hoklo, hakka o idiomi aborigeni. Da parte loro, i nuovi occupanti, arrivati dal continente, parlavano prevalentemente dialetti di Pechino e di Shanghai. Dopo il «massacro 228»3 del febbraio ‘47, il cinese mandarino divenne la lingua ufficiale dell’amministrazione statale e l’unica impiegata nell’insegnamento, mentre l’uso pubblico di altre lingue fu pesantemente sanzionato.
La politica fortemente anticomunista di Chiang Kai-shek gli procurò per molti anni l’appoggio politico incondizionato e gli aiuti economici degli Stati Uniti e di tutte le potenze occidentali, che vedevano in lui il governo legittimo di tutta la Cina. Solo nel 1979 gli Usa instaurarono relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare. Nel frattempo (1971) Taiwan aveva perso il proprio seggio all’Onu e nel Consiglio di sicurezza, seggi che vennero ambedue trasferiti al governo di Pechino.
Per quasi quarant’anni Taiwan fu governata in modo autoritario da leader tutti nati sul continente, in una realtà sociopolitica piuttosto differente da quella isolana. Ogni protesta venne repressa con la violenza. Poi, lentamente, a partire dal 1987 si verificò un processo di liberalizzazione che nel 2000 portò per la prima volta alla vittoria elettorale di un partito diverso dal Kmt: quello Progressista democratico. Ma se il Kmt aveva sempre sostenuto l’unità di tutta la Cina, includendo quindi il grande territorio continentale, il nuovo governo sembrava invece intenzionato a dichiarare l’indipendenza completa dell’isola. Ciò causò forti tensioni con Pechino, che minacciò di attaccare militarmente l’isola, considerata una provincia ribelle. Non era la prima volta che Pechino mostrava i muscoli. A queste minacce gli Stati Uniti, alleati di Taiwan per la comune ideologia anticomunista, avevano sempre risposto ribadendo il loro impegno a difesa dell’isola, arrivando anche a far passare le loro possenti portaerei nello stretto di Formosa che separa i due rivali. Nel 2000 la situazione si risolse fortunatamente in modo pacifico, ma fu chiaro che la questione dell’indipendenza dell’isola poteva costituire un casus belli capace di provocare un conflitto su grande scala. Notiamo anche come nel 2005 il parlamento cinese abbia approvato la cosiddetta legge antisecessione, che autorizza il governo ad usare la forza militare nel caso l’isola ribelle dichiari l’indipendenza.
La complessa situazione sino-taiwanese si può riassumere, almeno nei suoi aspetti essenziali, in alcuni punti che proviamo a descrivere.
Negli scorsi due secoli l’interazione della Cina con il mondo esterno, in particolare occidentale e giapponese, non è certo stata felice. Ha subito aggressioni e invasioni militari, perdite territoriali e trattati iniqui, obbligo di legalizzare l’importazione di oppio x riequilibrare la bilancia dei pagamenti altrui4. La proverbiale lunga memoria cinese fa sì che il ricordo di queste vicissitudini sia ancora vivo. Questo aiuta, almeno in parte, a spiegare il difficile rapporto odierno che intercorre tra Pechino e Washington e di cui accenniamo nel seguito.
![]()
Cina e Taiwan hanno entrambe avuto regimi autoritari che, se da una parte hanno represso violentemente qualunque richiesta democratica, negli ultimi decenni hanno anche garantito un progresso economico impressionante.
Se a tutt’oggi la Cina è ancora caratterizzata da un regime totalitario, Taiwan si è incamminata su un positivo percorso di democratizzazione che ne ha ormai fatto un esempio per tutto il mondo. Le elezioni si svolgono regolarmente e hanno garantito una salutare alternanza dei partiti al potere.
La Cina vanta una civiltà antichissima e prestigiosa, che ha esportato filosofia e scrittura (in una parola sola: «cultura») in tutto l’estremo oriente. Come tale si ritiene un po’ «l’ombelico del mondo», almeno di quello dell’Asia dell’Est. Per i suoi governanti e anche per i normali cittadini, quindi, può risultare difficile capire ed accettare che una piccola popolazione come quella di Taiwan5 possa non desiderare di far parte della grande famiglia, specie in un momento come quello attuale, nel quale la Cina è diventata una grande potenza, rispettata dal mondo intero.
![]() Si può pertanto capire come la pretesa ideologica di avere una Cina unificata, comprendente la parte continentale e l’isola, sia ancora saldissima a Pechino (mentre è passata del tutto in secondo piano a Taiwan). L’unificazione di tutte le popolazioni parlanti i vari dialetti cinesi e la completezza territoriale vengono viste come il passo finale del recupero di dignità nazionale, dopo i tristi eventi del passato che avevano fatto «perdere la faccia» a questo paese (e per la cultura cinese non c’è cosa peggiore). Il partito comunista cinese (che ormai di comunista ha ben poco, ma questo è un altro discorso) e quasi tutta la popolazione sinica del continente (martellata per decenni dalla propaganda ufficiale) sono convinti che una ipotetica dichiarazione di indipendenza taiwanese sia del tutto inaccettabile e che essa debba essere impedita a qualunque costo, anche arrivando a scatenare una guerra.
Si può pertanto capire come la pretesa ideologica di avere una Cina unificata, comprendente la parte continentale e l’isola, sia ancora saldissima a Pechino (mentre è passata del tutto in secondo piano a Taiwan). L’unificazione di tutte le popolazioni parlanti i vari dialetti cinesi e la completezza territoriale vengono viste come il passo finale del recupero di dignità nazionale, dopo i tristi eventi del passato che avevano fatto «perdere la faccia» a questo paese (e per la cultura cinese non c’è cosa peggiore). Il partito comunista cinese (che ormai di comunista ha ben poco, ma questo è un altro discorso) e quasi tutta la popolazione sinica del continente (martellata per decenni dalla propaganda ufficiale) sono convinti che una ipotetica dichiarazione di indipendenza taiwanese sia del tutto inaccettabile e che essa debba essere impedita a qualunque costo, anche arrivando a scatenare una guerra.
Qualche anno fa, parlando con giovani universitari cinesi, a cui avevo chiesto cosa avrebbero fatto nel caso in cui Taiwan avesse dichiarato l’indipendenza da Pechino, mi colpì molto sentirmi dire all’unisono «ci arruoliamo come volontari per andare a combattere per l’unita della patria». Non ci fu modo di farli recedere da questa posizione, nemmeno facendo notare loro che, stante l’ancora enorme vantaggio militare che gli Stati Uniti possiedono sulla Cina, ciò avrebbe comportato pesantissime distruzioni per il loro paese, e un probabile blocco del suo sviluppo economico. Ma niente e nessuno poteva scalfire il sentimento patriottico di costoro. E questi giovani rappresentavano l’elite colta e preparata del paese, non il popolino, così facile a farsi influenzare dalla propaganda governativa.
La Cina, governata quasi sempre durante la sua plurimillenaria storia da regimi totalitari, è riuscita a modernizzarsi nel giro di pochi decenni e a trarre dalla miseria più nera centinaia di milioni di cittadini. Nel corso degli ultimi secoli, molto raramente ha intrapreso azioni aggressive nei confronti degli stati vicini e non ha mai avuto particolari tendenze espansioniste, mirando invece a mantenere la propria integrità territoriale, spesso minacciata dalle potenze occidentali e dal Giappone, e concentrandosi su un accelerato sviluppo economico.
Dopo la fine della seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti, temendo l’espansione del comunismo, appoggiarono senza esitazioni il regime del Kmt, a prescindere dalla natura dittatoriale, violenta e repressiva che lo stesso ha mantenuto fino al 1987. Questo comportamento non era propriamente consono al propagandato impegno americano per la democrazia e i diritti umani (valori che oltretutto si incolpava la Repubblica popolare di non possedere).
Gli Stati Uniti hanno esercitato una fortissima influenza politica, economica e culturale su Taiwan. Molti taiwanesi hanno studiato o lavorato negli Usa e non sono poche le persone appartenenti all’elite governativa, militare ed economica in possesso della doppia cittadinanza. È forse per questo che taluni di questi sono visceralmente anti-Pechino, e sono favorevoli ad opporsi con ogni mezzo militare alle pressioni cinesi, disposti anche ad una guerra totale pur di mantenere l’indipendenza dell’isola, che sarebbe però presumibilmente ridotta ad un cumulo di macerie. Viene da sospettare che persone di questo tipo abbiano posizioni così estreme in quanto, in tale sfortunato caso, loro potrebbero comunque sempre tornare a vivere in America.
Aggiungo un piccolo aneddoto: nel corso di un convegno, un tecnico che lavora nel settore armiero sostenne il concetto che i taiwanesi avrebbero un «diritto umano» a dotarsi di ogni genere di armamenti, anche dei più distruttivi.
Nell’ottica di Pechino è indubbio che gli Usa abbiano ripetutamente interferito nelle loro questioni interne: Pechino considera che il rapporto con Taiwan rientri in quell’ambito. L’ingerenza americana non sarebbe che l’ultima in ordine di tempo, dopo quelle avvenute nel passato da parte di molte potenze europee (Italia inclusa) e del Giappone. Anche per questo motivo, gli interventi americani rivestono particolare importanza, riaprendo la piaga delle antiche umiliazioni e dei tanti soprusi subiti. Dall’altro lato l’utilità per gli Usa di disporre di un fidatissimo alleato a poche centinaia di chilometri dalle coste cinesi è evidente, specie dal punto di vista militare. Per gli Usa, Taiwan è come un’inaffondabile portaerei da cui poter influenzare, spiare, attaccare il territorio estremo asiatico e chiaramente hanno tutto l’interesse a che questa situazione si prolunghi il più possibile.
![]()
II tre decenni trascorsi dall’inizio del processo di liberalizzazione a Taiwan hanno fatto sì che, specialmente le nuove generazioni, si siano abituate a vivere in democrazia e ad apprezzarne i vantaggi, in termini soprattutto di libertà di parola, espressione e movimento.
Notevole è la differenza con la situazione politica della Cina continentale, ove il regime è totalitario, non accetta nessun dissenso, limita la libertà di stampa, incarcera chi vuole. Sulla base di queste grandi differenze, è facilmente comprensibile come quella parte di popolazione taiwanese più affezionata all’ideale democratico veda con grande preoccupazione la possibilità di un’annessione da parte di Pechino.
Mirco Elena
(prima parte- continua)
Il momento è finalmente arrivato. La nostra comunità sta per compiere tre anni di presenza nella diocesi di Hsinchu, a Taiwan, un tempo conosciuta come isola di Formosa: l’isola «bella». Siamo arrivati in tre, dopo un periodo di discernimento e studio, per capire se questo piccolo paese del Pacifico potesse diventare la terza presenza dei Missionari della Consolata nel continente asiatico.
Il Capitolo generale del 2011 aveva chiesto che l’Istituto, prevalentemente orientato al lavoro di evangelizzazione in Africa e America Meridionale, si aprisse all’Asia con decisione. Gli obiettivi erano due: creare tra i missionari una maggiore consapevolezza e una conoscenza più profonda della missione in Asia e operare una nuova apertura che, dopo la Corea (1988) e la Mongolia (2003), fosse il segno tangibile dell’assunzione di questo impegno da parte dell’Istituto.
Il lavoro di discernimento, portato avanti dalla Direzione generale insieme ai missionari già presenti nel continente, aveva sin da subito suggerito Taiwan come una delle possibili mete; questo per tre ragioni principali:
1) l’importanza, per un Istituto come il nostro, di avere una qualche apertura verso il mondo cinese, in modo da esporsi alla cultura, impararne la lingua, conoscerne le caratteristiche principali;
2) rimanere compatti e non distanziarsi troppo dalle altre presenze, per avere la possibilità di incontrarsi periodicamente;
3) la relativa facilità di accesso e la positiva accoglienza da parte del governo e della Chiesa locale.
![]()
![]()
Le due visite fatte dal sottoscritto insieme all’allora consigliere generale per l’Asia, padre Ugo Pozzoli, nel luglio 2013 e maggio 2014 avevano offerto nuovi elementi capaci di far pendere definitivamente il piatto della bilancia a favore della scelta di Taiwan. Determinante era stato l’incontro con mons. John Baptist Lee, vescovo della diocesi di Hsinchu dove poi ci siamo diretti e attualmente lavoriamo.
Hsinchu si trova molto vicina alla capitale Taipei. È una cittadina industriale che vive sui proventi dell’industria tessile e di quella della tecnologia. Ospita una grande quantità di migranti provenienti da moltissimi altri paesi del Sud Est asiatico, in particolare Filippine, Vietnam e Thailandia, ma anche da alcuni paesi dell’America Latina. Durante il periodo di studi della lingua cinese ci siamo avvicinati a questo mondo complesso e bisognoso di «consolazione» rappresentato dai lavoratori stranieri.
La chiesa locale ha anche un grande bisogno di clero, fattore che ha contribuito in maniera risolutiva alla scelta di Hsinchu come nostra meta. Il vescovo ci ha ospitati presso l’episcopato per tutto il tempo del nostro inserimento nella realtà di Taiwan, garantendoci accompagnamento e incoraggiamento nella prima, arida fase di apprendistato nella nuova realtà. I primi due anni e mezzo di permanenza sono stati infatti dedicati allo studio intensivo del cinese mandarino, senza la conoscenza del quale si è praticamente bloccati in ogni attività pastorale. Eravamo in due: padre Mathews Odhiambo, keniano, e il sottoscritto, spagnolo. Personalmente avevo già fatto la fatica di imparare un idioma complesso come il coreano e adesso mi trovavo davanti a questa nuova domanda: sarei stato capace di iniziare un lavoro pastorale efficace con la conoscenza del cinese che avevo maturato fino a quel momento? Dove, soprattutto, il vescovo ci avrebbe chiesto di iniziare la nostra missione «sul campo»? Con padre Mathews, sovente ci chiedevamo quale sarebbe potuta essere, al termine dei nostri primi due anni in Taiwan la nostra responsabilità pastorale. Forse una parrocchia in qualche città della diocesi? O in una zona rurale dove vivono i nativi? Saremmo stati capaci, col nostro cinese così limitato, ad affrontare una tale responsabilità?

Alcuni di questi dubbi si sono sciolti quando il vescovo Lee mi ha chiamato per dirmi: «Ho già pensato quale sarà la parrocchia per voi missionari della Consolata. È la parrocchia dei Gesuiti, quella del Sacro Cuore. Loro stanno per consegnare la parrocchia alla diocesi e così ho pensato a voi!». Che sorpresa! Non lo avremmo mai immaginato. La conoscevamo già, perché è una di quelle che avevamo visitato con padre Ugo durante il nostro secondo viaggio di esplorazione prima di fare la scelta di aprire una missione in Taiwan. È una chiesa molto significativa nella diocesi di Hsinchu, e il vescovo l’ha anche designata come santuario per i pellegrinaggi. Eravamo rimasti allora colpiti dalla forma particolare di questa chiesa, unica per la sua bellezza, costruita 45 anni fa ispirandosi all’architettura dei palazzi cinesi.
A gennaio di quest’anno, terminati i nostri primi due anni di studio del mandarino, il vescovo ci ha inviato in questa parrocchia come assistenti fino a oggi, 30 di luglio, giorno in cui ne abbiamo assunto la completa responsabilità. Fino a oggi padre Mathews e io abbiamo vissuto e lavorato insieme con la comunità dei Gesuiti (quattro padri anziani e un fratello), e questo ci ha permesso di conoscere a poco a poco le persone e la vita della comunità.
Il lavoro pastorale e missionario della diocesi di Hsinchu fu assegnato fin dal 1952 alla Compagnia di Gesù. Molti dei padri espulsi dalla Cina comunista vennero qui e cominciarono un gran lavoro missionario che diede come frutto la costruzione delle attuali parrocchie di questa città. E tra queste la nostra, la parrocchia del Sacro Cuore. Ovviamente i Gesuiti godono del rispetto e dell’ammirazione di tutti i fedeli della diocesi per il loro impegno di evangelizzazione. E questo vale anche per l’ultimo parroco, il padre Sun di 93 anni nato nella Cina continentale, e per il suo vice parroco, il padre Arturo, ottantenne colombiano, che hanno guidato questa comunità con grande visione, facendola crescere in 10 anni sia come numero che come qualità di fede. I fedeli sono una novantina e sono attivi in vari gruppi parrocchiali, come la Legio Mariae, la catechesi domenicale dei bambini, il coro, il gruppo di preghiera «Taizé», lo studio della Bibbia e dei documenti del Vaticano II, il gruppo anziani, il gruppo di formazione di evangelizzatori e la catechesi battesimale.
Certo, questo numero di fedeli è veramente piccolo a confronto delle chiese di altri paesi. Ma noi guardiamo a questo piccolo gregge con tanta speranza. Saranno loro che ci aiuteranno a entrare in questa cultura e con loro potremo arrivare a quelli «di fuori», che ancora non conoscono il Vangelo, e così realizzare il primo obiettivo della nostra missione.
![]()
Oggi, 30 luglio, finalmente è stato passato il testimone. Il nostro vescovo Lee ha presieduto la cerimonia di consegna della parrocchia, dai Gesuiti ai missionari della Consolata. Per questa occasione sono venuti dalla Corea il nostro superiore regionale, padre Tamrat Defar, e padre Gian Paolo Lamberto, il quale ci ha anche predicato il ritiro annuale la settimana precedente a questa cerimonia.
È stato un momento emozionante per tutti, specialmente per i padri gesuiti che dopo tanti anni lasciano questa comunità parrocchiale tanto amata. Il provinciale dei Gesuiti ha ricordato ai fedeli che la parrocchia non è qualcosa dei Gesuiti, o del vescovo o della Consolata, ma di Gesù, che dona questa comunità alla Chiesa.
Da oggi padre Mathews è parroco, e si assume la responsabilità di questa comunità. Potete immaginarvi le sfide che ha davanti, tra cui forse la più grande è quella di una lingua che non si finisce mai di imparare, anche se lui già se la cava molto bene. Questa parrocchia per noi non è solamente la prima opportunità di realizzare il nostro servizio pastorale a Taiwan, ma è anche la sede della nostra comunità, formata per ora da quattro padri (Mathews Odhiambo, Gilberto Da Silva, il sottoscritto Eugenio Boatella, e Jasper Kirimi – foto a sinistra). La diocesi ha ristrutturato per noi un secondo piano dell’edificio, trasformando cinque uffici e un salone nella nostra attuale residenza, che diventa così sede e punto di riferimento della nostra presenza nella bella isola di Taiwan.
Oserei quindi dire che questo è un momento storico della nostra presenza in Asia. È un passo importantissimo per la nostra famiglia missionaria, per il suo desiderio di aprirsi con decisione all’Asia. Oggi siamo già con un piede in mezzo al popolo cinese. Che il Padrone della Missione ci assista in questo lungo cammino in cui oggi ci ha fatto fare un gran passo in avanti.
Eugenio Boatella
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()