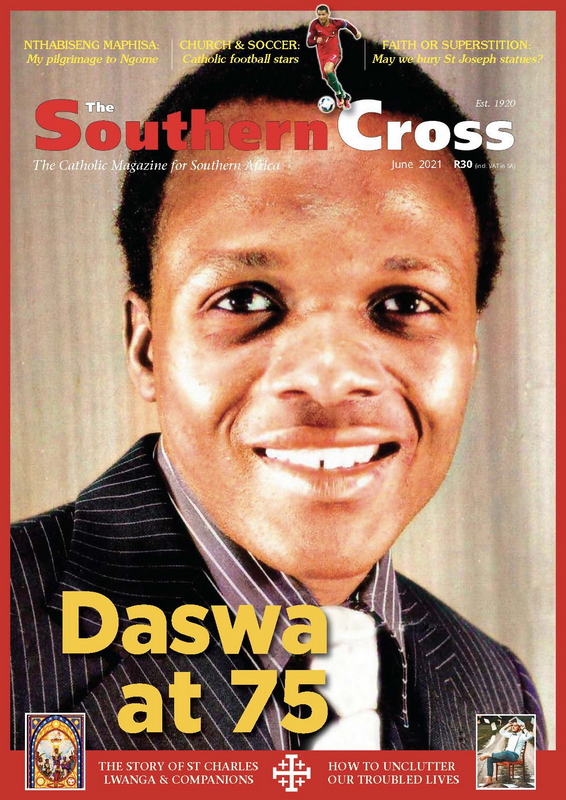La santità che scuote
Il 20 ottobre scorso Giuseppe Allamano è diventato ufficialmente santo. Pellegrini da 35 paesi hanno raggiunto Roma per l’evento. Missionarie e missionari della Consolata di tante nazionalità erano presenti. È stata una grande festa di famiglia. Reportage.
Roma, 19 ottobre. È già buio quando fuori dalla Chiesa Nuova di Santa Maria in Vallicella, a pochi passi da piazza Navona, incontriamo un brulicare di gente. A guardare bene, e ad ascoltare la cacofonia di voci, ci sono persone da diverse parti del mondo. Si abbracciano, parlano, cercano qualcuno di conosciuto, prima di entrare alla veglia che inizierà tra poco. È il popolo di Giuseppe Allamano, che si è riunito da 35 paesi di quattro continenti, perché il 20 ottobre, il sacerdote torinese fondatore dei missionari e delle missionarie della Consolata, sarà canonizzato da papa Francesco, ovvero, diventerà ufficialmente santo.
Intanto la chiesa si riempie, è stracolma e molti sono in piedi o seduti per terra nell’area davanti all’altare. I cori Tatanzambe di Nervesa (Tv) e Massawe di Bevera (Lc), uniti per l’occasione, suonano e cantano in kiswahili.
Verso le 20 suor Alessandra Pulina, direttrice di Andare alle genti, prende la parola per spiegare il programma della serata. Con lei, condurrà padre Edwin Osaleh, missionario in Marocco.
![]()
La veglia abbia inizio
Il benvenuto è di suor Lucia Bortolomasi, madre generale delle missionarie della Consolata, anche a nome di padre James Lengarin, superiore generale dei missionari. Di colpo la chiassosa e variopinta assembela si zittisce. «Che gioia indescrivibile, quanti sentimenti abitano il nostro cuore. […]
Alcuni di noi hanno varcato oceani, attraversato continenti, viaggiato giorni per arrivare qui. […] è necessario fermarci tutti insieme a preparare il cuore. per sintonizzarci a quanto sta accadendo sotto i nostri occhi e coglierne il senso più profondo».
Suor Lucia ricorda la beatificazione di Allamano, nel 1990 e riflette sul significato di essere riconosciuto santo: «Questo riconoscimento ufficiale varca i confini della nostra famiglia, diventando un modello rivolto ai fedeli della Chiesa tutta. Da domani Allamano è un po’ meno nostro e sempre più di tutti».
Suor Lucia richiama la santità che il fondatore chiedeva ai suoi: «Non miracoli, ma fare tutto bene. Farci santi nella via ordinaria» e ricorda i tanti missionari e missionarie che sono rimasti ai loro posti, in missione, e quelli che non sono potuti venire perché impediti dall’età o dalla malattia. Suor Lucia fa, infine, un richiamo alla responsabilità: «siamo tutti chiamati a operare con sempre maggiore dedizione».
Dopo di lei, parla monsignor Giacomo Martinacci, rettore del santuario della Consolata doi Torino, che ricorda i 47 anni a guida di Giuseppe Allamano.
Per ogni intervento lei due guide della veglia, fanno sintesi in inglese, spagnolo, portoghese.
![]()
Raccontare il miracolo
Viene il momento di parlare del miracolo che ha portato alla canonizzazione di Giuseppe Allamano. La guarigione di Sorino Yanomami, nella missione di Catrimani, a Roraima, in Brasile, nel 1996. Sorino, a caccia nella foresta, era stato aggredito da un giaguaro, che aveva causato gravi ferite alla scatola cranica.
La dottoressa Roberta Barbero ha seguito dal punto di vista medico la vicenda. Racconta come abbia vissuto il contrasto tra il ruolo di medico, che ha bisogno di osservare, misurare, e il suo essere donna di fede, alla quale bastano le testimonianze.
Racconta, ad esempio, come a volte si sia sentita isolata dalla comunità scientifica, quando raccontava il caso, perché lo scienziato fa fatica ad andare oltre a quello che si può misurare: «Le guarigioni inspiegabili avvengono, e l’atteggiamento della medicina è quasi come quello di chi subisce un affronto». Ma «la fede può fare la differenza. Questa guarigione ha cambiato il mio modo di vedere le cose, e anche di testimoniare la mia fede all’interno di un ambiente che non sempre permette questa apertura».
Si alza poi suor Felicita Muthoni Nyaga, la testimone più diretta dell’evento occorso nel febbraio 1996 a Roraima. Prende il microfono e va verso la gente. Tra le centinaia di persone, adesso, cala un silenzio assoluto: sono tutti con il fiato sospeso per ascoltare la sua storia (vedi dossier MC ottobre 2024). Quando conclude dicendo che Sorino «è un uomo che non è registrato all’anagrafe, né nei nostri registri di battesimo, ma c’è, Dio lo ha visto», scoppia un lungo applauso. L’atmosfera è diventata caldissima.
Parlano ancora i vescovi di Roraima: quello attuale, monsignor Evaristo Spleger, e alcuni predecessori e vicari, monsignor Roche Paloschi, e monsignor Raimundo Vanthay Neto.
Gli interventi sono intervallati da canti del coro in diverse lingue.
![]()
Testimonianze
Dopo un breve saluto di monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliario dell’arcidiocesi di Torino, si susseguono alcune testimonianze di laici e laiche.
Toccante è quella di Nadia, ragazza marocchina musulmana di Oujda, dove è operativo il centro per migranti coordinato da padre Edwin.
Una preghiera del cardinale Giorgio Marengo conclude la serata.
Sono le dieci passate, i pellegrini chiassosi defluiscono lentamente dalla Chiesa Nuova. Si vede la stanchezza di chi è arrivato da lontano, ma si sente l’entusiasmo, e molta attesa per quello che avverrà domani.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=k6dxF1L6aAI?feature=oembed&w=500&h=281]
![]()
Piazza san Pietro, 20 ottobre
È festa grande
Fino dalle 7 del mattino, a giorno non ancora fatto, lunghe code di pellegrini aspettano ai controlli della polizia necessari per entrare nella piazza.
Nella coda, tra la gente che si stropiccia gli occhi, si sentono decine di lingue: portoghese, spagnolo, francese, inglese, italiano, kiswahili. Ma c’è anche l’Asia, con la Corea, la Mongolia e Taiwan.
Su alcune asticelle viene issata l’immagine di Giuseppe Allamano, nella sua versione colorata o «pop art», che resta un riferimento tra la marea di teste.
Oggi saranno, infatti, «canonizzati» anche Elena Guerra, Marie-Léonie Paradis e gli undici martiri di Damasco (Manuel Ruiz e compagni). Ci si distingue anche per il foulard, bianco ma colorato con le 35 bandiere dei paesi dove lavorano i missionari e le missionarie della Consolata, e con il volto di Allamano e l’immagine della Consolata. L’organizzazione ha anche previsto per tutti un badge verde con il logo studiato specificamente per questo giorno.
Entriamo tra i primi, dopo il controllo con il metal detector. La platea davanti alla scalinata di San Pietro è ancora da riempire.
I pellegrini sono assonnati, ma nei volti si nota la gioia e l’eccitazione. Molti si salutano, si abbracciano. È spesso un rivedersi dopo anni, talvolta un incontrarsi per la prima volta, entrando subito in sintonia.
Intanto si è fatto giorno. È nuvoloso, ma non piove.
È un momento di attesa, e si approfitta per farsi foto, video, scambiarsi un contatto o un sorriso. Vediamo una folta delegazione dall’Uganda, poi la bandiera del Kenya (primo paese di missione dei Missionari della Consolata). Il Congo Rdc è presente, così come la Costa d’Avorio. A un certo punto compare la bandiera del Marocco: è il gruppo di Oujda, del quale fanno parte alcune migranti subsahariane.
Vediamo il gruppo dei laici della Consolata del Portogallo, con le magliette del loro 25° anno di esistenza. E poi tantissime suore, di svariate età e nazionalità. Così metà della piazza, quella con i posti a sedere, si è riempita.
Intanto, alla sinistra dell’altare si siedono cardinali, vescovi e sacerdoti. Alla destra, invece, le autorità e i diplomatici.
![]()
Francesco accolto dai suoi
Dopo il rosario in latino, inizia uno scampanio, poi il coro ufficiale intona alcuni canti diffuse con i potenti altoparlanti. L’attesa si fa più intensa tra le migliaia di persone venute da tutto il pianeta, spaccato di umanità.
Alle 10,20, quasi all’improvviso, arriva papa Francesco sulla sua carrozzina e si siede sulla poltrona papale. Tenue, quasi sotto voce, sul lato destro della platea, un gruppo di pellegrini intona: «Papa Francesco, papa Francesco». Altri iniziano, è come se il coro si spostasse nello spazio antistante alla basilica, e intanto diventa «papa Francisco», per culminare con un grande applauso. Nel frattempo è comparso un pallido sole.
Scorgiamo evidente, in prima fila nel gruppo delle autorità, il presidente Sergio Mattarella.
La celebrazione ha inizio. Vengono lette le brevi biografie dei nuovi santi. Quando è nominato Giuseppe Allamano, parte un applauso dalla piazza.
«Vince non chi domina, ma chi serve per amore», dice il Papa nella sua omelia, a commento del Vangelo del giorno (Mc 10,35-45).
«Gesù svela pensieri nel nostro cuore smascherando, talvolta, i nostri desideri di vanità e di potere». E poi ci insegna lo «stile di Dio», ovvero il «servizio». Le parole magiche per il Papa sono: «Vicinanza, compassione e tenerezza, applicate all’azione di servire. […] A questo dobbiamo anelare».
Uno stile che nasce dall’amore e non ha una scadenza o un limite.
«I nuovi santi hanno vissuto questo stile di Gesù: il servizio», continua il Papa.
![]()
Allamano e gli Yanomami
All’Angelus il pontefice mette l’accento sui popoli indigeni: «La testimonianza di san Giuseppe Allamano ci ricorda la necessaria attenzione verso le popolazioni più fragili e vulnerabili. Penso in particolare al popolo Yanomami, nella foresta amazzonica brasiliana, tra i cui membri è avvenuto proprio il miracolo legato alla sua canonizzazione. Faccio appello alle autorità politiche e civili affinché assicurino la protezione di questi popoli e dei loro diritti fondamentali e contro ogni forma di sfruttamento della loro dignità e dei loro territori».
Il nome «Yanomami», dunque, echeggia in piazza san Pietro, proprio grazie al nuovo santo.
Papa Francesco conclude con un giro in carrozzina a salutare i cardinali, per poi salire sulla papamobile, e fare un lungo percorso nella piazza. I pellegrini e i fedeli hanno oramai lasciato le loro sedie e si accalcano alle transenne per salutare il Santo Padre.
Dopodiché, inizia il lento deflusso di migliaia di persone, mentre gruppi di svariate nazionalità e lingue si fanno le ultime foto sulla piazza, con lo sfondo della basilica di san Pietro sulla cui facciata spicca lo stendardo di san Giuseppe Allamano.
Chiediamo a padre James Lengarin, superiore dei missionari della Consolata, le sue impressioni: «È stata una bellissima giornata. Quando si nominava san Giuseppe Allamano, dalla piazza si alzava un urlo di gioia. Il Papa ha ancora parlato di lui all’Angelus, sottolineando il suo spirito missionario: oggi è anche la Giornata missionaria mondiale».
«Poi ci siamo trovati tutti al Teresianum (la Pontificia università teologica), per festeggiare. Eravamo più di 1.300 persone da tutto il mondo. Questo ci fa vedere come il cuore della Consolata sia vivo». Gli chiediamo come si sente a essere il successore di un santo: «Mi sento come uno dei suoi figli, ma anche come frutto della missione. Io vengo da una popolazione di pastori nomadi. Vuole dire che Allamano aveva questa attenzione per le persone che di solito sono emarginate, alla periferia del mondo. Io adesso mi sento animatore dei miei fratelli».
![]()
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=eMG2kXp9iho?feature=oembed&w=500&h=281]
Roma, 21 ottobre
«Coraggio, avanti»
Lunedì pomeriggio i pellegrini di san Giuseppe Allamano si trovano nuovamente tutti insieme per una celebrazione di ringraziamento nella splendida cornice della basilica di san Paolo fuori le mura.
La messa inizia con una danza africana realizzata da suore e novizie, che scalda subito l’atmosfera. Sfilano vestite con colori africani, a dominante azzurra. Dietro alle danzatrici, fanno il loro ingresso centodieci sacerdoti vestiti di bianco, due fratelli missionari, seguiti da ventidue vescovi e, in ultimo, dal cardinale Giorgio Marengo. È lui che, con la sua solita semplicità, ma al tempo stesso profondità, prende la parola: «Questa mattina, alla sessione del sinodo, sono andato a ringraziare il Santo Padre, che era lì con noi, per il dono della canonizzazione. Mi ha colpito, perché, sedutomi davanti a lui, mi ha preso le mani e mi ha detto “Coraggio, avanti”. Quello che ci diceva sempre san Giuseppe Allamano».
![]()
Continua il cardinale: «Oggi è un giorno di ringraziamento per san Giuseppe Allamano. È il primo giorno nel quale possiamo chiamarlo così». Le sue parole, quasi emozionate, scatenano l’euforia dei presenti.
Tra questi spicca una folta delegazione di fedeli di Roraima, lo stato del Brasile dove è avvenuto il miracolo della guarigione dell’indigeno yanomami Sorino. Sono riconoscibili da una maglietta fatta per l’occasione, con la scritta in portoghese: «Annunziate la mia gloria alle nazioni» (Is 66,19), e con i loghi della diocesi di Roraima e quello ufficiale della canonizzazione. Poi tante fedeli africane, con vestiti dai tipici colori sgargianti, e moltissime religiose. Ci sono anche i laici missionari della Consolata, e i tanti amici del nuovo santo venuti da quattro continenti. Quasi tutti hanno al collo il foulard della canonizzazione.
Iniziano le letture. Poi il salmo viene recitato da uno studente e una studentessa missionari, e il coro risponde cantando in maniera soave: «Popoli tutti, lodate il Signore».
Dopo la seconda lettura, parte di nuovo il coro, diretto dall’accalorato padre Douglas Lukunza del Kenya. I musici – tastiera, batteria, due djembé (tamburi africani) e pure un bravo violino – sono altri studenti missionari, tutti africani. Il coro variegato segue i movimenti del direttore, che non si limita a muovere le braccia, ma praticamente balla. Una danza contagiosa, che in pochi secondi prende tutti i presenti e, chi più chi meno, inizia a muoversi a ritmo di musica. E parte l’entusiasmo della grande festa.
![]()
Un punto di partenza
Con la preghiera dei fedeli torna la calma. Alcuni lettori e lettrici si alternano nelle diverse lingue: italiano, inglese, portoghese, spagnolo, coreano, kiswahili e francese. A leggere quest’ultima è una ragazza migrante del Burkina Faso, attualmente a Oujda in Marocco. La sua è una supplica toccante, forse perché nasce dall’esperienza personale: chiede di pregare affinché i governi rendano più vivibili i Paesi del mondo, in modo che i giovani non siano più costretti a partire.
Durante la cerimonia di ringraziamento, come nei giorni precedenti, il collegamento con l’Amazzonia è forte: all’offertorio, oltre al pane e al vino, viene portato anche un tipico copricapo indigeno, fatto di piume blu e gialle del grande pappagallo ara, mandato da coloro, spiega la voce di commento, «che sono assetati di fede e di giustizia».
Ma oltre alla festa, il ringraziamento è pure un momento di riflessione, stimolata dalle parole, talvolta provocatorie, del cardinale Marengo che nella sua omelia si è soffermato sull’importanza della contemporaneità: l’impegno deve essere «una successione continua di oggi e qui», e occorre «attingere la forza per la missione dalla contemplazione».
«Dobbiamo dircelo: la sua santità (di Allamano, ndr) ci deve scuotere, altrimenti non ci gioverà. I nostri istituti attraversano un momento delicato della loro storia, con incertezze nei cammini del mondo. Oggi non è solo un punto di arrivo, deve essere anche un punto di ripartenza».
Considerando il percorso e gli sforzi fatti per arrivare a questa canonizzazione, «tutto sarà ripagato se prenderemo sul serio questo oggi, l’avere gli occhi fissi sul Signore, teneramente amato e servito da san Giuseppe Allamano, e realizzeremo davvero il suo desiderio di vederci famiglia della Consolata che si vuole bene e che arde di zelo apostolico».
La cerimonia si avvia alla conclusione con il canto del Magnificat in versione africana, danzato e cantato da tutti i presenti. Il cardinale incensa lo stendardo con il volto di Giuseppe Allamano, che pare sorridente come non mai. Anche lui, oramai coinvolto nella festa per il nuovo santo.
Marco Bello
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=TovV1r44H-c?feature=oembed&w=500&h=281]
![]()