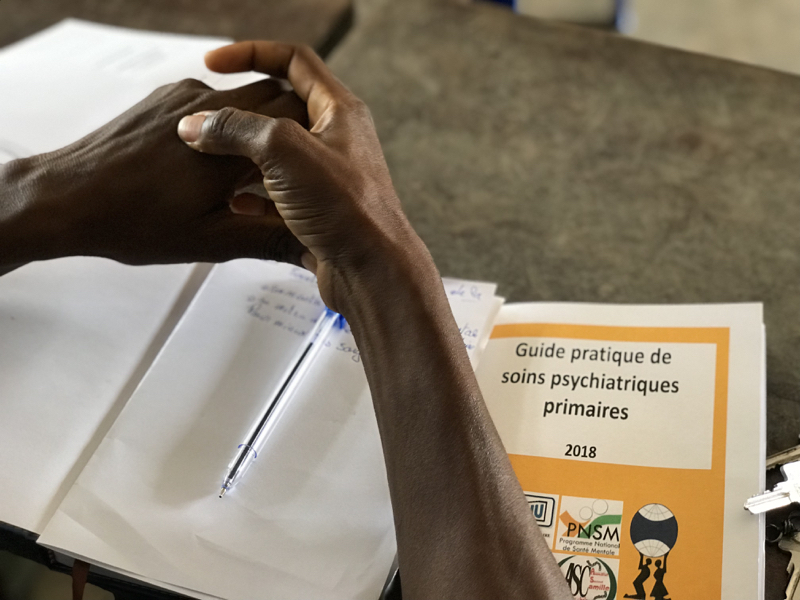Mondo e tortura. Cresce l’uso dei Taser
L’uso dei dispositivi a scarica elettrica, noti come Pesw (Projectile electric shock weapons) o Taser (dal nome del modello più diffuso), da parte delle forze di polizia è in costante aumento in tutto il mondo.
Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani denunciano da anni il loro abuso, soprattutto in contesti di detenzione, manifestazioni pubbliche e contro gruppi vulnerabili come bambini, anziani, fasce di popolazione emarginate. Tuttavia, manca ancora un trattato internazionale che ne limiti la produzione, la commercializzazione e l’uso indiscriminato.
Ne parla un rapporto dell’organizzazione per i diritti umani pubblicato lo scorso 6 marzo: «I still can’t sleep at night». The global abuse of electric shock equipment. («Non riesco ancora a dormire la notte». L’abuso globale di apparecchiature per le scosse elettriche). Un lavoro che descrive i due tipi di apparecchiature a scarica elettrica in commercio: quelle a contatto diretto, che Amnesty assieme a molte altre organizzazioni internazionali chiedono di eliminare, e le Pesw a proiettili, armi paralizzanti che funzionano con una carica elettrica a distanza, legittime, ma il cui uso è da limitare a casi estremi.
Il costo umano del commercio e dell’uso non regolamentato di questi prodotti richiede l’urgente necessità di un’azione coordinata e globale.
Esempi concreti di abuso: Iran e Francia
Il lavoro di Amnesty presenta casi di tortura e maltrattamenti avvenuti in tutto il mondo tramite queste apparecchiature negli ultimi dieci anni.
L’Iran è uno dei Paesi nei quale Amnesty International ha documentato l’uso di dispositivi elettrici contro manifestanti pacifici, prigionieri politici e dissidenti.
Molti detenuti hanno subito torture con scariche elettriche prolungate per estorcere confessioni o come forma di punizione.
Le conseguenze per le vittime sono di diversa gravità: ustioni; danni neurologici permanenti, traumi psicologici profondi.
Anche in Francia, per fare solo un altro esempio, nonostante le rigide normative europee, sono stati segnalati abusi. Le forze dell’ordine hanno utilizzato i Taser durante operazioni di polizia, spesso su persone che non rappresentavano una minaccia immediata.
Torture con scosse elettriche: una lunga storia
L’uso della scossa elettrica come strumento di tortura ha radici storiche lontane.
I dispositivi per elettroshock, scrive Amnesty, sono stati a lungo utilizzati per la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti in tutto il mondo, spesso utilizzando metodi improvvisati, come pungoli elettrici per bovini, fili collegati alla rete elettrica o alle batterie delle auto.
I telefoni da campo a manovella «magneto» o «dinamo» furono utilizzati per la prima volta per la tortura dall’esercito francese in Indocina e dalla polizia militare giapponese in tutto il Giappone imperiale negli anni 30.
Dopo la Seconda guerra mondiale, il telefono da campo fu utilizzato per la tortura in tutta la Francia coloniale, dall’Algeria al Madagascar, nel Kenya britannico e in Vietnam dai marines statunitensi. Nello stesso periodo, negli Stati Uniti sono emerse armi a scossa elettrica a contatto diretto progettate per le forze dell’ordine.
Negli anni 30 la polizia argentina ha adottato l’uso della picana eléctrica (manganello elettrico), un dispositivo che si sarebbe diffuso in Uruguay, Paraguay e Bolivia, mentre la tortura basata sulla scossa elettrica sarebbe stata ampiamente adottata in America Latina sotto le dittature militari degli anni 70 e 80 per reprimere il dissenso politico.
Oggi, la disponibilità commerciale di Pesw e dispositivi affini ha reso questa pratica più diffusa e difficile da monitorare.
Le conseguenze sulla salute
L’uso di strumenti a scossa elettrica può avere effetti devastanti sulla salute delle persone. Le scariche causano dolore intenso, convulsioni, perdita di controllo motorio e, in alcuni casi, arresto cardiaco.
Sono stati registrati numerosi decessi in seguito all’uso del Taser su individui in precarie condizioni di salute. Gli effetti psicologici, tra cui ansia, depressione e disturbi da stress post-traumatico, sono altrettanto gravi.
Uso contro gruppi vulnerabili
Il problema più allarmante è l’uso di questi trumenti contro categorie di persone vulnerabili.
I detenuti subiscono scosse elettriche come forma di punizione o coercizione. I manifestanti vengono colpiti per disperdere le folle, anche quando non costituiscono una minaccia reale. Le persone con problemi di salute mentale, i minori e gli anziani sono particolarmente vulnerabili agli effetti delle scariche elettriche, che possono causare danni irreversibili.
Amnesty International ha documentato diversi casi di abuso contro minori, spesso in situazioni in cui non rappresentavano alcun pericolo.
Negli Stati Uniti, alcuni bambini di appena 10 anni sono stati colpiti con i Taser da agenti di polizia durante interventi scolastici, per aver mostrato segni di disagio o per piccoli atti di ribellione. In un caso, un bambino autistico è stato colpito durante una crisi emotiva.
Per quanto riguarda gli anziani e le persone con problemi di salute mentale, Amnesty ha registrato casi in cui individui in evidente stato di confusione o in emergenza medica sono stati immobilizzati con Taser, aggravando le loro condizioni.
Negli ospedali psichiatrici e nei centri di detenzione, l’uso dei Taser è stato denunciato come una forma di abuso sistematico.
In alcune occasioni, l’uso della scarica elettrica ha provocato arresti cardiaci fatali.
Produzione e commercio: un mercato in crescita senza regole globali
Il mercato dei dispositivi a scarica elettrica è in espansione. Il modello più diffuso di Pesw è il Taser. Tanto diffuso che nel linguaggio comune il suo nome raggruppa per antonomasia tutti i dispositivi Pesw. È prodotto da Axon Enterprise, la principale azienda del settore, che fornisce le sue armi a oltre 18mila agenzie di polizia in più di 80 Paesi.
Non esistono, però, regolamenti internazionali vincolanti per limitare la produzione e la vendita di questi strumenti. La maggior parte degli Stati non ha controlli adeguati per evitare che questi dispositivi finiscano nelle mani di regimi repressivi o forze di polizia che violano i diritti umani.
La proposta di un Trattato internazionale
Per colmare questa lacuna, Unione Europea, Argentina e Mongolia hanno lanciato l’Alleanza per un commercio libero dalla tortura, con l’obiettivo di vietare la produzione e la compravendita di strumenti di tortura, compresi i Pesw.
Amnesty International e altre Ong chiedono un trattato internazionale che vieti completamente la produzione e l’uso di dispositivi a scarica elettrica da contatto diretto, e che regoli rigorosamente l’uso dei Pesw, imponendo limiti chiari e meccanismi di controllo efficaci.
Un trattato di questo tipo stabilirebbe regole chiare per il commercio e l’uso dei Pesw, riducendo il loro uso come strumenti di repressione e tortura. Solo una regolamentazione globale potrà proteggere i diritti umani e prevenire ulteriori abusi nel mondo.
Luca Lorusso