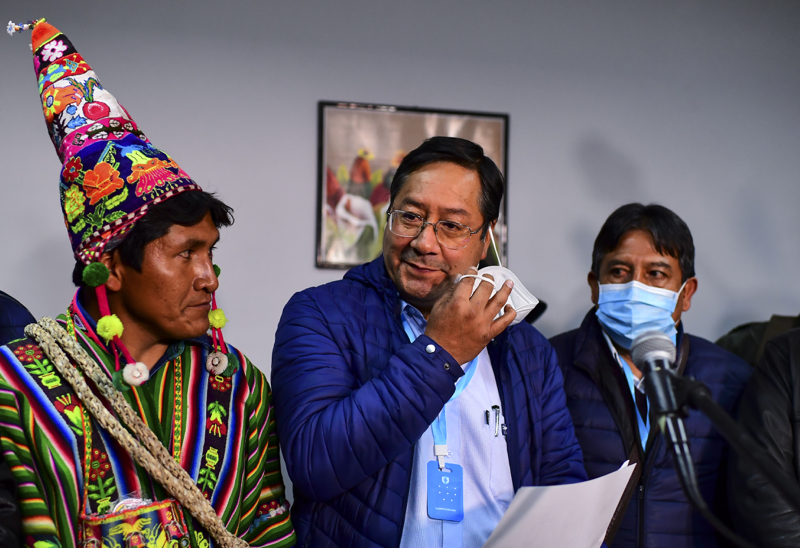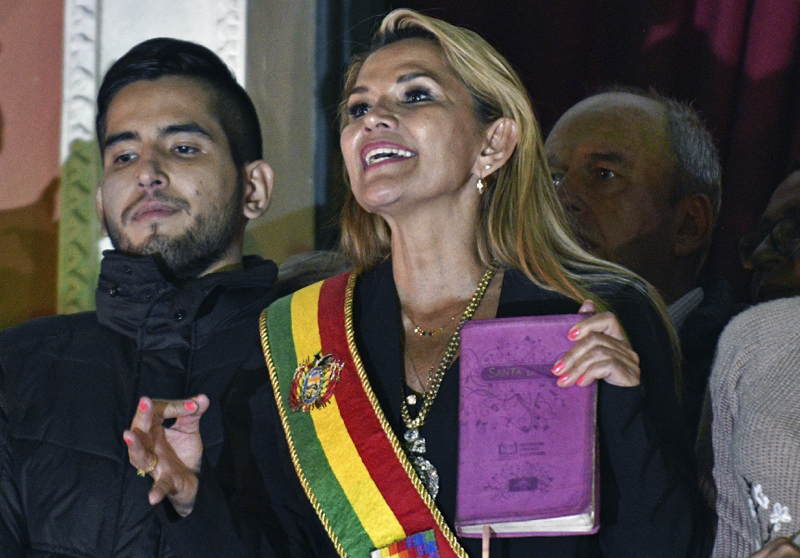Rd Congo: Ripartire dalle donne (vittime di violenza)
testo di Luca Salvatore Pistone |
L’Est di uno dei paesi più ricchi d’Africa non trova pace. Nonostante la presenza delle Nazioni unite, decine di milizie imperversano. I civili subiscono ogni sorta di vessazione. Mentre il mondo sta a guardare o, meglio, si gira dall’altra parte.
La guerra nel Nord della Repubblica democratica del Congo (Rdc) è un abominio. Covava da lungo tempo, ma è con il genocidio ruandese del 1994 che, nell’immenso stato dell’Africa centrale, si è scatenata la catastrofe. Vertiginosa diffusione di gruppi armati, negligenza delle autorità, saccheggio di risorse naturali sono solo alcuni degli ingredienti di quello che gli esperti definiscono «conflitto a bassa intensità». Una barbarie, che si protrae da oltre due decenni (di cui MC ha più volte parlato, ndr).
La prima vittima di tanta violenza? La donna. Seni amputati, clitoridi tagliati e ani sventrati sono le firme dei macellai. In Congo il corpo della donna è diventato un campo di battaglia la quale è lecito infliggere dolore, umiliazione, terrore.
![]()
Goma
Raggiungiamo Goma, il capoluogo della provincia del Nord Kivu, via terra dal Ruanda. Lasciati i bagagli in albergo, la prima cosa che facciamo è recarci al comando regionale della Monusco (Missione dell’Onu per la stabilizzazione nella Repubblica democratica del Congo). Bisogna muoversi per tempo per trovare posto a bordo di uno dei suoi aerei diretti a Bunia, capoluogo della provincia di Ituri, prima meta del nostro viaggio.
Sbrigata la burocrazia dell’Onu e strappata a un funzionario indiano la promessa che saremo inseriti al più presto nella lista dei passeggeri, ci rechiamo all’appuntamento con Caleb in un bar con terrazza sul lago Kivu. Il tramonto contribuisce a rendere il paesaggio ancora più mozzafiato.
«Finalmente ci conosciamo!». Quarantacinque anni, alto, pochi denti in bocca, Caleb è un simpaticone. Giornalista, ha collaborato con prestigiose testate internazionali. È lui il nostro fixer (la persona che negli scenari di guerra o di crisi, assiste il giornalista che si muove sul campo). «Fidati di me, per capire come le cose vanno in Congo bisogna parlare con le donne».
La casa delle donne
![]() La mattina seguente Caleb passa a prendermi con il suo fuoristrada. In meno di mezz’ora raggiungiamo il villaggio di Bulengo. Continuiamo per un paio di chilometri di strada sterrata e, nascosta da una fittissima vegetazione, troviamo un’enorme villa. Siamo alla Maison des femmes. Ci accolgono una ventina di donne con altrettanti bambini. Terminati i convenevoli, tutte tornano alle loro attività. C’è chi si dedica alla tintura di stoffe per abiti femminili, chi all’intreccio di cestini di plastica riciclata e chi all’allevamento di polli e maiali.
La mattina seguente Caleb passa a prendermi con il suo fuoristrada. In meno di mezz’ora raggiungiamo il villaggio di Bulengo. Continuiamo per un paio di chilometri di strada sterrata e, nascosta da una fittissima vegetazione, troviamo un’enorme villa. Siamo alla Maison des femmes. Ci accolgono una ventina di donne con altrettanti bambini. Terminati i convenevoli, tutte tornano alle loro attività. C’è chi si dedica alla tintura di stoffe per abiti femminili, chi all’intreccio di cestini di plastica riciclata e chi all’allevamento di polli e maiali.
Justine Masika è la presidente di Synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles (Sfvs), una piattaforma nata nel 2002 che raggruppa 35 piccole Ong locali con sede a Goma. «Sfvs gestisce il progetto Maison des femmes. Teniamo dei corsi di formazione professionale e, grazie al microcredito, contribuiamo all’avvio di piccoli esercizi commerciali. Qui le nostre assistite parlano dei traumi che hanno vissuto. Capiscono di non essere sole e che si può andare avanti. Operiamo sulle conseguenze dello stupro, ma ci siamo rese conto che è necessario intervenire alla base di questo male, e cioè lavorare sulle cause che rendono la violenza sessuale un fenomeno così diffuso».
Justine ha un bel da fare. Alla porta del suo ufficio bussano in continuazione le sue collaboratrici per farle firmare pile di scartoffie. «Per porre un freno a questo crimine bisogna combattere l’impunità di cui godono gli stupratori, coinvolgere maggiormente i politici e gli investitori stranieri per mettere fine al saccheggio delle materie prime e, quindi, ai conflitti per il sottosuolo che dilaniano il nostro Congo. Occorre anche capire che gli stupri non distruggono solo il fisico di chi li subisce, ma l’intera società. Le donne, dopo essere state abusate, vengono considerate colpevoli per ciò che è successo loro: vengono ripudiate dai mariti e i figli restano abbandonati a se stessi».
Sfvs si assume le spese per la riparazione chirurgica di fistole retto-vaginali, dei test per l’Hiv e dei trattamenti per malattie sessualmente trasmissibili. Ha istituito venti consultori dove vengono invitate sia le vittime che i loro familiari, allo scopo di far capire a questi ultimi che la «gogna» perpetrata anche da loro non è la via giusta. La sezione per la difesa legale fa pressioni presso le Corti, dinanzi alle quali vengono portati i casi delle donne stuprate, e ha avviato un’intensa campagna per la creazione di tribunali che si occupino esclusivamente di violenze sessuali.
![]()
Il dolore
È mezzogiorno. Può avere inizio il douleur (dolore), come Justine chiama l’orario dei colloqui dello psicologo del centro con le vittime di violenza sessuale.
Provengono tutte dalla zona di Masisi, una città del Nord Kivu nota per essere il centro di conflitti che vedono coinvolti almeno 140 piccoli gruppi armati irregolari. «Mettetevi comodi. Vedrete quanto in basso può arrivare l’uomo», ci annuncia Justine.
La prima a entrare è Judithe, di 57 anni. Dieci anni fa dovette assistere all’assassinio del marito e dei due figli, fatti a pezzi col machete. «Il nostro villaggio fu attaccato dai miliziani Mai Mai. Piangevo e quelli mi violentarono uno dopo l’altro, picchiandomi a sangue. La mia comunità mi ripudiò».
È il turno di Mamy, di 35 anni, madre di tre bambini: «Ero andata al pozzo per prendere dell’acqua e ho incontrato degli uomini armati. Mi hanno detto che potevo scegliere tra la vita e lo stupro. Quando vieni stuprata vieni marchiata a vita. Il tuo uomo si sente umiliato e ti caccia via di casa. Per l’intero villaggio sei come morta o una prostituta. Io invece nella disgrazia sono stata fortunata perché mio marito ha capito la situazione e mi ha tenuta con sé».
Therèse ha da poco compiuto 15 anni ed è al settimo mese di gravidanza. Sorride solo quando pensa a Julie, il nome che ha scelto per sua figlia. Per più di un mese è rimasta nelle mani di criminali nella foresta. «Quando mi volevano venivano nella capanna in cui mi avevano rinchiusa. Lo facevano a turno, anche in due, per più volte al giorno. Ero la donna di tutti. Mi costringevano pure a cucinare per loro. Poi un giorno all’improvviso mi bendarono e mi riportarono all’ingresso del mio villaggio».
Chantal ha 19 anni e tra un mese partorirà: «Al mio villaggio non c’è una sola famiglia che non abbia una donna violentata. Io ho tre cugine che sono state abusate. La mia famiglia è in ginocchio, nessuno ci rivolge più la parola».
Secondo le stime delle Nazioni unite, nella regione si verifica uno stupro ogni trenta minuti. Una pratica che non accenna a placarsi.
Ringraziamo la Maison des Femmes e torniamo alla macchina. Regna il silenzio. A infrangerlo, una volta immessi sulla strada asfaltata, è Caleb: «Adesso capisci come siamo messi? In Congo la donna è il campo di battaglia». Mi squilla il cellulare e sul display compare il nome del funzionario della Monusco. È stato di parola: tra un paio di giorni potremo volare su Bunia.
![]()
Bunia
Un’enorme distesa bianca e blu. È così che Bunia appare dall’alto. Poi, a mano a mano che l’aereo plana, ci si rende conto di come migliaia di teli di plastica dei colori dell’Onu abbiano inghiottito l’intera città. Sono le tende degli sfollati provenienti da tutto l’Ituri, la martoriata provincia di cui Bunia è capoluogo.
Ituri, un vasto territorio di circa 65mila chilometri quadrati nel Congo Nord orientale, è da lungo tempo teatro di abominevoli scontri tra due etnie, gli Hema e i Lendu. I primi storicamente pastori, i secondi agricoltori. Le rivalità tra i due gruppi risalgono al periodo coloniale, quando i belgi favorirono gli Hema, creando non poche disparità che i governi succedutisi fino ai nostri giorni non hanno voluto e saputo limare.
Le dispute vere, quelle sfociate nel sangue, sono iniziate negli anni Settanta in concomitanza della promulgazione di leggi sulla distribuzione delle terre che avevano avvantaggiato gli Hema. Picchi di violenza si sono registrati nel 1972, 1985, 1996, 2001 e 2003, mentre scontri minori si sono protratti fino al 2007. Negli anni Novanta gli sfollati raggiunsero la cifra record di 400mila. Le varie missioni di stabilizzazione dell’Onu nella Rdc non sono riuscite a fermare i massacri, registrando peraltro un alto numero di morti tra i propri militari. Negli ultimi mesi hanno avuto luogo nuovi scontri con almeno una ventina di morti tra i civili, e le rappresaglie, fomentate da gruppi armati vicini alle due etnie interessati dalle ricchezze del posto, sembrano non avere fine.
![]()
Un mare di sfollati
L’Onu ritiene che gli sfollati dovuti a quest’ennesimo incidente, sparsi in campi ufficiali e irregolari soprattutto a Bunia, o rifugiatisi nel vicino Uganda, siano 340mila, circa l’8% dell’intera popolazione della provincia.
Per motivi di sicurezza dobbiamo alloggiare a Bunia, dove ha sede una base della Monusco, gestita dai contingenti marocchino e bengalese. Il responsabile dell’ufficio stampa della missione, un sergente marocchino, ci dà un lasciapassare per raggiungere autonomamente Djugu, la terza città per estensione di Ituri, divenuta uno degli epicentri delle violenze, a patto di tornare a Bunia prima di sera. Un percorso di 70 chilometri su strada sterrata con buche che inghiottirebbero una jeep. Caleb scorre la rubrica di uno dei suoi tre Iphone e contatta Richard, un autista locale. «Tutto ok, domattina alle 4 in punto ci passa a prendere con un pick up».
Richard spacca il minuto. Lasciamo Bunia e a ogni curva rimaniamo a bocca aperta per la bellezza del territorio. Colline verde smeraldo, cascate azzurrissime, fiori mai visti prima. Il viaggio procede liscio e in meno di tre ore siamo alle porte di Djugu.
![]()
La città bruciata
Il colore che domina in città è il nero: non c’è un solo edificio o catapecchia che non sia stato incendiato. La cenere è ovunque. Per la loro opera di devastazione sia gli Hema che i Lendu si servono di «serbatoi incendiari», ovvero serbatoi di motociclette lanciati a come molotov contro le case di quelli che ritengono nemici.
Pochissime le persone che incontriamo per strada. Nessuno ha voglia di parlare con noi e così decidiamo di proseguire per un’altra ventina di chilometri fino a Fataki, una piccola località sotto l’amministrazione di Djugu dove è attivo l’unico ospedale del circondario.
Da una stanza provengono urla strazianti di una giovane. Yvonne sta per dare alla luce il suo primogenito. Il dottor Bavi, il giovane direttore dell’Ospedale di Fataki, ci chiede se vogliamo assistere ma decliniamo l’offerta, rimanendo al di qua della tenda che delimita la sala parto. Ephala, la madre della ragazza, è seduta su una sedia in un angolino. Quella che tra pochi minuti diverrà nonna ha appena trent’anni. «Prima è toccato a me, adesso a lei. A sedici anni fui violentata, Yvonne a quattordici. Mia figlia nacque in seguito a quello stupro, come il figlio che ora sta partorendo. Spero sia un maschio, così non potrà essere violentato come noi».
Prendiamo la direzione per Bunia e siamo in hotel prima di sera, come promesso al sergente marocchino.
![]()
I campi profughi
Il giorno seguente ci viene assegnata una scorta di caschi blu bengalesi per visitare il Site1 e il Site2, i due campi ufficiali per sfollati di Bunia, uno a poche centinaia di metri dall’altro. Gli chiedo il perché di una simile misura di sicurezza, apparentemente eccessiva, e lui non mi lascia diritto di replica: «Un poliziotto è stato ucciso all’interno del Site1. Tranquillo, avrete massima libertà di movimento».
Il Site1 è il campo più grande della regione. Sorto lungo la recinzione dell’Ospedale Generale di Bunia, ospita circa diecimila sfollati in stragrande maggioranza di etnia Hema. Nel Site2, nato poco dopo su un terreno messo a disposizione dalla Diocesi di Bunia, ce ne sono quasi novemila.
È la Ong congolese Lasi (Ligue anti-sida en Ituri), diretta dal pastore Ignaci Bingi, ad aver ricevuto dal governo provinciale l’incarico di gestire gli aiuti al Site1 elargiti dal Pam (Programma alimentare mondiale) e Oxam (Oxford committee for famine relief). Per distribuire meglio le derrate alimentari, il pastore ha personalmente diviso il campo in dieci blocchi, facendo eleggere dalla comunità un rappresentante per ogni blocco. «Gli sfollati mi riferiscono tutto ciò che non va nel campo in modo che io possa portare le loro rimostranze a chi di dovere. È gente esausta, che ha perso tutto ciò che aveva, incattivita. Una bomba a orologeria insomma».
A occuparsi invece del Site2 sono Caritas Congo e Unicef (Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia). Di scuole non ce ne sono e così l’unico spazio aggregativo che i bambini possono frequentare è un piccolo centro costituito da quattro pareti di legno all’interno delle quali alcuni animatori li intrattengono con balli e canti. «Tantissimi dei nostri sfollati sono minori – dice Clementine Pelosi, funzionaria Unicef – e tantissimi sono orfani perché i loro genitori sono stati uccisi durante gli scontri».
![]()
I due campi sono un distillato di atrocità. Testimonianze verbali e testimonianze visibili sulla loro pelle. La storia di Grace e Rachel appartiene a queste ultime. Non lascia molto spazio alla fantasia. Due bambine, sorelle, rispettivamente di undici e due anni. Da pochi giorni sono uscite dal reparto di chirurgia dell’Ospedale generale di Bunia, dove erano state condotte due mesi prima in fin di vita.
A raccontarcela è loro zia Charlotte: «I Lendu hanno attaccato Tchee, il nostro villaggio. Hanno violentato davanti agli occhi di Grace e Rachel la loro madre, mia sorella. Sempre davanti ai loro occhi hanno ucciso i loro genitori e i tre fratelli più grandi. I Lendu, non soddisfatti, si sono divertiti coi machete. Hanno tagliato parte del braccio sinistro di Grace e l’hanno ferita alla nuca. Poi sono passati a Rachel. L’hanno squarciata da guancia a guancia e da orecchio a orecchio. Io ho già i miei figli a cui badare, come posso sfamarle? Sapete che nessuno le sposerà in queste condizioni?». Grace è appoggiata alla sua spalla mentre Rachel dorme tranquillamente tra le sue braccia.
Accanto a me un casco blu bengalese. Ha gli occhi lucidi. Infila in tasca a Grace una merendina. Si è fatto buio, dobbiamo andare.
Luca Salvatore Pistone
![]()
Dieci anni dal «Rapporto Mapping»
Il genocidio senza storia
Il primo ottobre 2020 ricorrevano i 10 anni dalla pubblicazione del «Rapporto Mapping» dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani (Unhchr) sulla Repubblica democratica del Congo.
![]() Per capire meglio di cosa si tratta, occorre fare un passo indietro. Nel 1994, al termine del genocidio in Ruanda, durato 100 giorni senza che la comunità internazionale intervenisse, il Fronte patriottico ruandese (Fpr) di Paul Kagame assunse il controllo del paese (milizia a maggioranza Tutsi anglofona, ndr). Nella speranza di salvarsi dalle violenze dell’Fpr, deciso a vendicarsi del genocidio subito dagli Hutu, circa due milioni di ruandesi di etnia Hutu si rifugiarono nell’allora Zaire di Mobutu. Questi era malato, stanco e ormai abbandonato dagli alleati.
Per capire meglio di cosa si tratta, occorre fare un passo indietro. Nel 1994, al termine del genocidio in Ruanda, durato 100 giorni senza che la comunità internazionale intervenisse, il Fronte patriottico ruandese (Fpr) di Paul Kagame assunse il controllo del paese (milizia a maggioranza Tutsi anglofona, ndr). Nella speranza di salvarsi dalle violenze dell’Fpr, deciso a vendicarsi del genocidio subito dagli Hutu, circa due milioni di ruandesi di etnia Hutu si rifugiarono nell’allora Zaire di Mobutu. Questi era malato, stanco e ormai abbandonato dagli alleati.
Con il genocidio in Ruanda, l’invasione dello Zaire da parte di quest’ultimo era solo questione di tempo e, con la scusa di inseguire i genocidari hutu, si è concretizzata con la «Prima guerra del Congo» che si è combattuta fra il 1996 e il 1997 e che ha messo fine al regime di Mobutu. Per non destare sospetti durante l’invasione, è stato messo a capo dell’avanzata un cittadino zairese, Laurent-Désiré Kabila che è diventato presidente nel paese nel 1997. Nel 1998 Kabila ha intimato ai ruandesi di ritornare a casa loro e così è iniziata la «Seconda guerra del Congo», detta anche Guerra mondiale africana, che, con milioni di vittime, si è conclusa nel 2003 con un governo di transizione guidato da Joseph Kabila, al potere dal 2001, dopo l’assassinio di Laurent-Désiré Kabila.
In seguito alla scoperta di molte fosse comuni nel 2005, l’Unhchr decise di investigare, e mandò i suoi esperti che indagarono sul decennio 1993-2003 producendo il Rapporto Mapping, uno studio molto dettagliato che sarà pubblicato il 1 ottobre 2010, ma subito messo nel cassetto, in seguito a pressioni di Paul Kagame e dei suoi alleati. Questo rapporto denunciava la morte di 6 milioni di persone e individuava 617 massacri classificabili come crimini di guerra, crimini contro l’umanità e, alcuni, come crimini di genocidio. Tutti crimini imprescrittibili.
Oggi sono in tanti, congolesi e amici del Congo, a chiedere la verità su questo dramma. Nel decimo anniversario del Rapporto Mapping, il dottor Denis Mukwege (cfr. Mc aprile 2018), Premio Nobel per la Pace 2018, ha lanciato, insieme alla società civile congolese ed esponenti della diaspora, una campagna di sensibilizzazione per chiedere alle Nazioni unite l’applicazione delle raccomandazioni di quel rapporto. In particolare, la creazione di un Tribunale penale internazionale ad hoc per giudicare i crimini commessi nella Rd Congo negli ultimi decenni, crimini, lo ricordiamo, che avvengono tuttora nel silenzio, seppure sotto gli occhi della comunità internazionale. Nessuno si illuda però. La strada per arrivare alla verità e alla giustizia è davvero molto lunga e piena di insidie. Ricordiamoci che le responsabilità non si limitano al solo Ruanda ma toccano potenze mondiali ed esponenti della politica congolese. E soprattutto, non dimentichiamoci i troppi interessi economici in ballo.
John Mpaliza*
*Attivista per i diritti umani e per la pace
FB: facebook.com/johnmpaliza/ (ospite di MC giugno 2016)
![]()
![]()