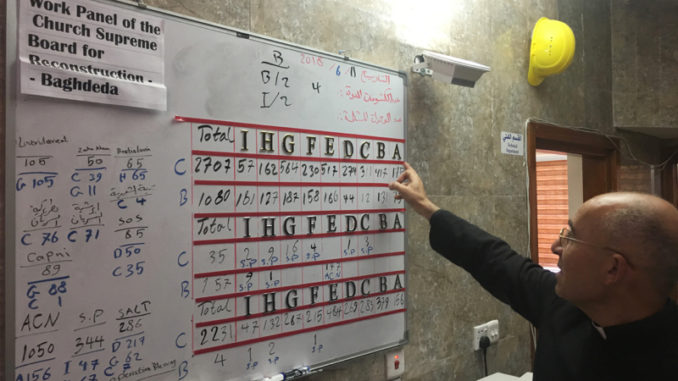Gocce di speranza
I Missionari della Consolata sono arrivati nel 2018 a Luacano, diocesi di Luena nella provincia di Moxico. Proprio nella regione dove, sedici anni prima, aveva avuto i suoi momenti conclusivi la guerra civile che ha stravolto la vita del paese dal 1975 al 2002 lasciando pesanti distruzioni e numerosi campi minati.
Luacano si trova 220 km a est di Luena (anche Lwena, ndr), capoluogo della provincia di Moxico, a 1.300 km da Luanda, capitale dell’Angola, e ad appena 100 km dai confini con il Congo Rd. La cittadina è stata fondata nel 1931. Moxico, con i suoi nove comuni, compreso Luacano, ha un’estensione territoriale di 223.023 km2 (circa dieci volte la Lombardia, con un decimo della sua popolazione, ndr). È la provincia dove si sono combattute le ultime fasi della guerra civile. Nel comune di Luacano, dove i Missionari della Consolata sono arrivati nel 2018, oltre a provocare innumerevoli morti, la guerra ha portato la distruzione di infrastrutture, scuole, case e chiese, e ha causato un massiccio esodo di popolazione che ha lasciato il territorio senza insegnanti, infermieri, medici, artigiani e tecnici.
Secondo l’ultimo censimento, nel 2014 Luacano aveva 21.447 abitanti. Considerando un tasso di natalità annuo intorno al 7%, e le difficoltà di registrazione e le incertezze dei documenti, oggi si stima ci siano circa 40mila abitanti. Le principali attività economiche sono la pesca e la coltivazione della manioca. La popolazione è composta da due gruppi etnolinguistici: i Tchokwe e i Luvale, che hanno un profondo patrimonio culturale. Di particolare rilievo sono i «mukanda», i riti di circoncisione per l’iniziazione dei «wali» (giovani), riti che però non comportano la mutilazione genitale femminile.
![]()
Le nostre comunità
La parrocchia santa Maria Mãe de Deus di Luacano è nella diocesi di Luena. A servirla siamo in due Missionari della Consolata: insieme a me, lavora padre Bernard Maina Wambui. Ha sette centri sparsi su un’area di 13.573 km2 (grande come la Campania, ndr). Il primo centro è Calomba dove c’è una piccola comunità di cattolici. Sono in tre, tra i quali l’unica donna catechista, la signora Victorina Tumba (Soba), che non sa né leggere né scrivere.
Il secondo è la comunità di Caifuche che vede crescere il numero di fedeli di giorno in giorno. Lì, non c’è ancora un responsabile della comunità che, per ora, è guidata da una piccola commissione di fedeli. Gli incontri di preghiera o la celebrazione della messa avvengono sotto un albero di mango.
Il terzo è la comunità di Lituta. Questa soffre per il fatto che la maggior parte dei suoi membri è analfabeta e molto attaccata alla religione tradizionale.
Il quarto centro è la comunità di Cazanguissa. È quella meglio organizzata di tutta la parrocchia, perché le responsabilità sono condivise, e così riesce anche ad aiutare due comunità vicine (Sambololo e Cualendende). I pochi giovani collaborano nelle attività pratiche e animano il coro. Esiste un gruppo di 48 catecumeni di diverse età che, con il nostro aiuto, è attualmente suddiviso secondo le varie tappe del cammino di iniziazione cristiana. La comunità però non è in grado di autofinanziarsi, in quanto i suoi membri non hanno risorse economiche da condividere, possono offrire solo servizi e lavori concreti.
Il quinto è quello del Lago Dilolo che è stata senza la messa per dieci anni fino all’anno scorso. La vita della comunità è guidata da un piccolo consiglio locale. La maggior parte dei fedeli non è battezzata e per questo abbiamo organizzato insieme un piano di formazione e catechesi.
Il sesto centro è la comunità di Caxita che è quella più lontana da Luacano (200 km). È una comunità vivace guidata da tre catechisti che hanno costruito una cappella in legno ed erba. Questa comunità ha il potenziale per diventare una chiesa forte, ma la sua distanza e le strade dissestate costituiscono una grande sfida per noi.
Il settimo è la comunità parrocchiale di Luacano dove c’è la celebrazione quotidiana della messa, l’adorazione eucaristica settimanale, la disponibilità al sacramento della riconciliazione due volte alla settimana, oltre all’accompagnamento di gruppi e movimenti. Anche il catechismo viene insegnato su base settimanale.
La comunità è divisa in diversi gruppi: bambini, giovani, uomini e donne. Sperimenta anche l’incostanza nella partecipazione a causa del grande movimento di persone verso altre località (Luau e Luena) alla ricerca di pascoli più verdi.
È da notare che i bambini e i giovani sono una parte importante della popolazione e un gran numero di loro non sa né scrivere né leggere, il che rende molto difficile trasmettere qualsiasi formazione religiosa o sociale.

Programma di eradicazione dell’analfabetismo
Per capire meglio la situazione di Luacano, dobbiamo vedere come va in generale il sistema educativo in Angola. Secondo i dati ufficiali del ministero dell’Istruzione per l’anno 2019@, quasi il 25% della popolazione angolana è analfabeta. Tuttavia, la realtà sul campo è molto varia e non corrisponde alle statistiche ufficiali.
Secondo il servizio della televisione pubblica dell’Angola (Tpa) del 26 marzo 2019, nella provincia di Cuanza Norte, che dista solo 211 km dalla capitale, oltre il 90% degli studenti di prima media non sa né leggere né scrivere. Se quella provincia così vicina a Luanda è in queste condizioni, possiamo immaginare la situazione scolastica in comuni remoti come Luacano.
Infatti, il tasso reale di analfabetismo, secondo le organizzazioni non governative, è del 45-55%, ovvero 13 milioni di angolani dai 15 anni in su@.
Il rapporto Undp (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) sull’Angola degli anni 2014-2018 mostra un tasso del 47% di angolani tra i 5 e i 23 anni che non frequentano la scuola e, tra questi, il 16% non l’ha mai frequentata.
Va notato che in province come Lunda Norte, oltre l’85% della popolazione adulta è analfabeta.
La causa principale di questa drammatica situazione è la lunga guerra civile durata più di 25 anni fino al 2002. Ma, dopo l’accordo di pace, nel paese è emerso un pessimo sistema educativo: scuole senza strutture, senza materiale didattico, e con insegnanti senza un’adeguata preparazione.
Stando così le così, noi missionari della Consolata abbiamo intrapreso un programma di alfabetizzazione in cui educhiamo la gente del posto a leggere e scrivere. Durante la settimana i nostri giovani si incontrano nel pomeriggio per corsi di alfabetizzazione che coinvolgono anche la sensibilizzazione vocazionale. Infatti, da questa attività sono uscite cinque ragazze che studiano in diverse case di suore e cinque giovani entrati nel seminario minore.

Maternità precoce
Purtroppo è frequente incontrare ragazze di appena 12 anni incinte o sposate. La maggior parte viene da noi chiedendo aiuto, ma con i mezzi limitati che abbiamo possiamo solo incoraggiarle a rimanere positive, mentre nel profondo di noi siamo turbati.
Un pomeriggio, mentre stavo camminando nel villaggio di nome bairro Morango, le nuvole hanno iniziato ad addensarsi e presto ho sentito le prime gocce di pioggia sulla fronte. Mi sono riparato velocemente nella casa più vicina, una capanna dal tetto di erba secca. Entrando, mi sono stupito che nella sua semplicità quella casa fosse in grado di ospitare ben quattordici bambini. Tra di essi c’era una ragazza di 13 anni che allattava un bambino nato da appena due settimane. Il resto dei suoi fratelli non era mai entrato in una scuola. Nessuno sapeva pronunciare una parola portoghese, tutti parlavano solo luvale. Non c’era niente da offrire allo sconosciuto appena entrato in casa: nessuna sedia, niente acqua e, con sorpresa, non c’era nemmeno un piccolo segno dell’imminente pasto per l’intera famiglia.
Più avanti, nella settimana, li abbiamo inclusi nel programma alimentare, ma ancora una volta la sfida principale è l’incapacità di finanziare un programma umanitario così nobile.
Salute
Nel comune di Luacano c’è una struttura sanitaria, ma purtroppo mancano i medici, e il loro laboratorio non ha le attrezzature per far fronte al crescente numero di malattie.
Qui la malaria è comune a causa dei prolungati periodi di piogge e della mancanza di un buon sistema di drenaggio e di fognature. La mancanza di conoscenza dell’igiene di base contribuisce anche a diverse malattie. La maggior parte dei cittadini soffre costantemente di diarrea e vomito. L’assenza di acqua potabile è la causa della maggior parte delle malattie. Per questo, nonostante le nostre ristrettezze economiche, abbiamo contribuito a scavare numerosi pozzi per migliorare il benessere della nostra gente.
In questa situazione ci sono persone che hanno optato per l’assistenza domiciliare, cioè le cure tradizionali.
Il comune di Luacano non ha obitori. All’ospedale comunale e al centro di maternità infantile non c’è mai stata una camera mortuaria, così, quando qualcuno muore, il funerale si fa entro il giorno seguente, prima che il corpo inizi la decomposizione.
![]()
Trasporti
La distanza tra Luena, sede della diocesi e capitale della provincia, e Luacano, è un’altra delle difficoltà che tutti hanno. L’unica via di comunicazione esistente è la ferrovia, mentre la strada è in condizioni impossibili. Sono solo 220 km, ma con il treno ci vogliono cinque ore. I treni sono disponibili cinque giorni alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato).
Se invece si decide di utilizzare la strada, uno lo fa a suo rischio e pericolo. Le strade hanno due caratteristiche principali: sono molto sabbiose durante il periodo secco e diventano un pantano durante la stagione delle piogge.
![]() Tornando al treno, vale la pena sottolineare alcune sue caratteristiche che lo rendono unico: è un treno con motore alimentato a diesel; c’è un continuo movimento di persone da una carrozza all’altra; ogni stazione in cui si ferma diventa un mercato all’aperto dove si comprano prodotti alimentari (principalmente limoni, pesce ecc.) e dove un gran numero di bambini cercano di venderti di tutto, anche quando ci sono condizioni meteorologiche avverse.
Tornando al treno, vale la pena sottolineare alcune sue caratteristiche che lo rendono unico: è un treno con motore alimentato a diesel; c’è un continuo movimento di persone da una carrozza all’altra; ogni stazione in cui si ferma diventa un mercato all’aperto dove si comprano prodotti alimentari (principalmente limoni, pesce ecc.) e dove un gran numero di bambini cercano di venderti di tutto, anche quando ci sono condizioni meteorologiche avverse.
Questa unicità è enfatizzata anche da una natura bellissima e lussureggiante lungo la linea ferroviaria.
Stando così le cose continuiamo a dialogare con le autorità locali affinché intervengano sul mantenimento delle poche infrastrutture di questo meraviglioso paese. Abbiamo con loro ottime relazioni che ci permettono anche di godere di una buona sicurezza, specialmente in previsione di offrire ai nostri amici la possibilità di visitare la missione.
La nostra casa
La nostra casa si trova in un quartiere costruito dal governo locale dopo la guerra. Era stata donata al vescovo di Luena, dom Tirso Blanco (defunto il 22/02/2022).
È una casa semplice con i servizi essenziali e dotata di pannelli solari. A poca distanza c’è un’altra casa conosciuta localmente come la «casa del vescovo», che gli era stata donata dallo stesso comune come sua dimora per le sue le visite pastorali. Questa casa è più ampia ed è a disposizione degli ospiti. Per l’acqua è stato scavato un pozzo che serve egregiamente per le nostre necessità e per quelle dei fedeli quando vengono alla chiesa.
Siamo in un rapporto molto positivo e cordiale con i nostri vicini, bella gente che ha un cuore grande nella propria semplicità e che fa anche buona guardia alla casa quando noi siamo lontani per visitare i centri.
![]()
Manioca, cibo di base
La popolazione locale è sempre vissuta dipendendo dalle piogge stagionali e, nella stagione secca, dalle acque raccolte negli stagni naturali. I continui drastici cambiamenti climatici hanno rotto questo equilibrio ed è stato necessario scavare nuovi pozzi per rispondere ai bisogni della gente.
L’alimentazione dipende per il 90% dalla manioca. Foglie di manioca come verdure, steli di manioca come legna da ardere e tuberi di manioca come pasto principale. Con una dieta così limitata, ci sono molti casi di sindrome da insufficienza alimentare soprattutto nei bambini piccoli. L’unica volta che c’è un cambiamento di menù è quando viene cucinato un pesce essiccato della stagione precedente.
Per cambiare questa realtà stiamo iniziando a introdurre altre colture stagionali intercambiabili, come il mais e i fagioli che maturano in un tempo più breve della manioca, la quale impiega un anno intero prima di essere pronta per il consumo.
Sfide
A Luacano bisogna imparare a vivere senza internet, visto che la rete mobile è debole e instabile. In compenso il contatto con la gente del posto è sempre pieno, a ogni ora del giorno.
Anche la nostra mobilità è limitata perché durante la stagione delle piogge (da settembre a marzo) siamo costretti a fermarci nella sede centrale a causa dell’acqua che rende le «strade» impossibili anche con un potente fuoristrada.
Per fare le spese poi, non possiamo contare sull’unico negozio locale. Esso vende i prodotti a un prezzo tre o quattro volte più alto che in città, così bisogna percorrere i 220 km che ci separano da Luena con il treno che parte il pomeriggio alle tre, pernottare in città, comprare il necessario e poi prendere un altro treno per ritornare a casa il giorno dopo alle quattro del mattino. Sono qui a Luacano da meno di un anno. Non era certo nelle mie previsioni essere inviato in un posto così remoto e impegnativo. Ma è una bella sfida per la mia passione missionaria. Ringrazio di cuore tutti quelli che ci sono vicini con la loro preghiera e il loro sostegno.
Martin Mbai Ndumia
![]()
Angola
- 1.246.700 km² di superfice (23° del mondo per estensione)
- 25.789.024 abitanti nel 2014
- 35.928.000 abitanti al 23/03/2023, h 15, secondo l’United nations world population prospect.
Paese situato nell’Africa sudoccidentale. Sotto influenza portoghese dal XV secolo, colonia fino al 1951, poi provincia d’oltremare e infine indipendente dal Portogallo l’11 novembre 1975 dopo un’aspra guerra.
Al momento dell’indipendenza il Paese era diviso, da una parte il Movimento popolare di liberazione dell’Angola (Mpla), fondato nel 1956 e appoggiato dall’Urss, dall’altra l’Unione Nazionale per l’Indipendenza totale dell’Angola (Unita) e il Fronte di liberazione nazionale dell’Angola (Flna), più vicini agli Stati Uniti. In gioco c’erano non solo contrasti etnici e interni, ma anche il controllo delle ricche risorse (petrolio e diamanti in particolare) del Paese. Iniziò così la guerra civile che sarebbe durata fino al 2002.
La guerra ha devastato le infrastrutture e danneggiato gravemente la pubblica amministrazione, l’economia e le istituzioni religiose.
È importante notare che i 27 anni di guerra civile in Angola hanno lasciato milioni di famiglie alla fame, altre sono state costrette a fuggire dalle loro case nei paesi vicini, Congo e Zambia, e oltre 100mila bambini sono stati separati dalle loro famiglie.
Quando i combattimenti sono terminati nel 2002, mine antiuomo ed esplosivi erano disseminati ovunque in campi,
villaggi e città, e hanno continuato a uccidere e ferire migliaia di persone. Le vittime delle mine antiuomo non ricevono alcun sostegno dal governo.
M.M.N.
LA RELIGIONE
La popolazione dell’Angola è prevalentemente cristiana. Non esistono statistiche accurate sull’argomento. La maggioranza è cattolica, circa il 20% è protestante di varie denominazioni e gli altri aderiscono a credenze tradizionali. Solo una piccola percentuale (forse il 2%) aderisce all’Islam o ad altre religioni. I cattolici sono più numerosi nella regione costiera occidentale densamente popolata. La Chiesa cattolica continua a svolgere un ruolo importante nel fornire istruzione al popolo dell’Angola. Il Paese ha attualmente cinque arcidiocesi e 19 diocesi: Huambo (diocesi di Huambo, Benguela, Kwito-Bié), Luanda (Luanda, Cabinda, Caxito, Mbanza Congo, Sumbe, Viana), Lubango (Lubango, Menongue, Ondjiva, Namibe), Malanje (Malanje, Ndalatando, Uije) e Saurimo (Saurimo, Dundo, Lwena). La nostra diocesi, Lwena, dopo la morte del salesiano dom Tirso Blanco il 22/02/2022, è in attesa della nomina di un nuovo vescovo Si stima che il 47% della popolazione angolana, soprattutto nelle aree rurali, pratichi varie forme di religioni indigene. Anche molte persone che professano il cristianesimo, si trovano ancora attaccate ad aspetti delle pratiche e delle credenze religiose tradizionali.
M.M.N.
Archivio MC
- Marco Bello, Verso una nuova missione ad gentes, MC giugno 2018.
- Mark Symbeie, Luacano vive, nella rubrica Fuoricarta sul sito, ottobre 2020.
![]()