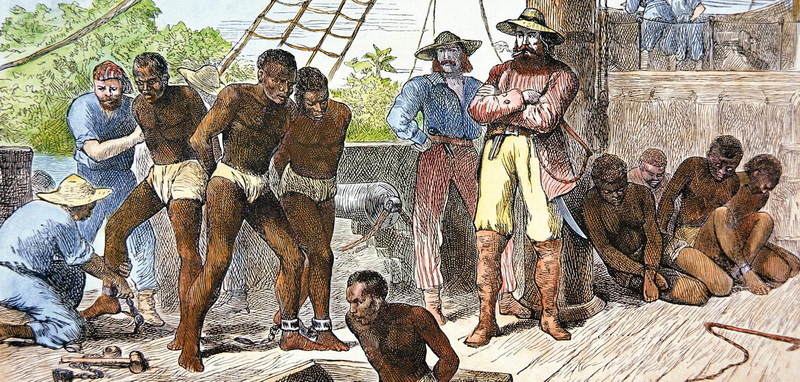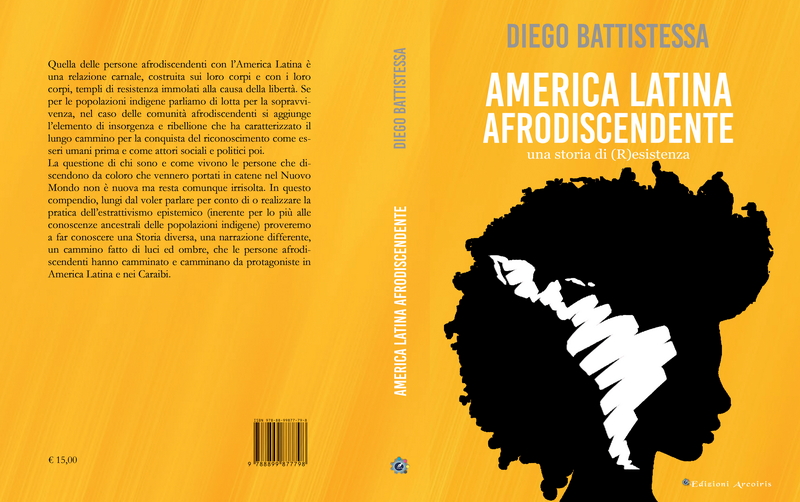Maschere e campanacci
In Barbagia, Sardegna, antichi riti rivelano il legame tra sacro e profano, e svelano i retroscena della cristianizzazione dell’isola.
Nel 594 papa Gregorio Magno scriveva a un certo Ospitone, riconosciuto «dux barbaricinorum», capo dei barbaricini (abitanti della Barbagia). Un documento importante che ci racconta come, nel cuore della Sardegna, ai tempi si praticassero ancora antichi culti legati alla natura, probabilmente di origine nuragica. Il Papa chiedeva a Ospitone di usare la sua «posizione» per convertire il popolo al cattolicesimo.
La Barbagia prima di essere un luogo fisico è una forma mentis. Per questo i suoi confini geografici sono discutibili, tanto che al di fuori del territorio comunemente riconosciuto come barbaricino ci sono paesi che si considerano legati ai suoi usi e costumi.
La Barbagia occupa un vasto territorio che si estende sui versanti del Gennargentu, un massiccio montuoso che sorge proprio al centro dell’isola. Il nome Barbagia, derivante dalla stessa radice di «barbaro», è legato al fatto che in questi luoghi si rifugiarono i sardi che resistettero alle conquiste dei cartaginesi e dei romani.
Un paesaggio vario: dalle rocce di granito ai pascoli montani sino al mare, la Barbagia si divide a sua volta in diverse Barbagie, ciascuna con usanze proprie che la caratterizzano.
Il dux barbaricino Ospitone accettò dunque di operare la conversione al cristianesimo del suo popolo, ma in una modalità rispettosa degli usi e costumi già esistenti purché non fossero in contrasto con il messaggio cristiano.
I missionari seguivano al riguardo una direttiva molto saggia che papa Gregorio aveva dato già agli evangelizzatori dell’Inghilterra, ovvero quella di non distruggere gli edifici sacri pagani, ma trasformarli in luoghi di culto cristiani, conciliando così la nuova fede con le vecchie tradizioni religiose, cui gli abitanti della Barbagia erano ancora legati. Si ebbe così un incontro tra vecchio e nuovo, un’integrazione tra cristianesimo e paganesimo, che tutt’ora si rivela agli occhi di chi capita in questi luoghi nel periodo che va da gennaio a febbraio. Nei secoli, infatti, benché il processo di evangelizzazione abbia portato la Sardegna a diventare cattolica, non si sono spenti riti e credenze tradizionali.
![]()
I fuochi di Sant’Antonio
Tre giri intorno al fuoco, il santo portato in processione, i chierichetti, le donne devote che reggono le candele votive e il sacerdote ad aprire la fila.
La processione avanza lenta e solenne dalla piccola chiesa dedicata a Sant’Antonio, fino al grande fuoco che arde nel mezzo della piazza di Ottana, che la separa dalla cattedrale di San Nicola, maestosa e bellissima. È un momento di festa per tutto il paese, ma fino a quando il prete non raggiunge il fuoco per la benedizione, il silenzio e il rispetto per il rito sacro che si sta celebrando non viene interrotto.
I fedeli seguono attentamente questo rituale: l’acqua santa che lambisce il grande falò, un fuoco alto e potente, il cui calore colpisce i volti e, se non si presta attenzione, può diventare pericoloso, e colora di un arancio-rossastro le figure che gli si muovono attorno.
Dalle finestre delle case, grandi e piccini si affacciano per godersi lo spettacolo ancestrale. La processione torna verso la chiesa di Sant’Antonio dove il santo verrà deposto. La funzione terminerà con il dono a tutti i fedeli del pane votivo preparato dalle donne del paese nei giorni precedenti e benedetto dal prete.Già si sentono in lontananza i campanacci delle maschere. In Barbagia, infatti, con i fuochi di Sant’Antonio Abate (17 gennaio) inizia ufficialmente il carnevale barbaricino.
Il rito del falò è legato al «Santo del fuoco» perché, secondo la leggenda, questi sarebbe sceso negli inferi per rubare un tizzone ardente con il quale diffondere il fuoco per riscaldare la Terra.
In questa occasione, in tutta la Sardegna, fanno la prima uscita le maschere del carnevale che ballano fra i grandi fuochi accesi nei rioni o sui sagrati delle chiese, bevendo un bicchiere di vino e assaggiando dolci tipici preparati in onore del santo.
![]()
Le maschere di Ottana
Ogni paese ha la propria maschera e qui a Ottana ci sono i boes (bue) e merdules (padrone): incarnazioni dell’eterna lotta fra istinto e ragione, fra essere umano e animale, il bue viene inseguito, frustato e catturato dal merdule. I boes indossano sul volto una maschera chiamata in sardo «caratza» che ha le fattezze di un bue, mentre i merdules indossano pelli di pecora e campanacci che possono arrivare a pesare sino a 30 o 40 kg e maschere dalle fattezze umane.
Durante la sfilata, i merdules – propriamente i guardiani dei buoi – cercano di comandare e ammansire i boes.
Un’altra figura segue queste maschere: è «sa filonzana», un personaggio femminile, seppur interpretato da un uomo perché le donne non si mascherano. È un’anziana zoppa e gobba, indossa un fazzoletto nero sul capo e una maschera di legno di pero selvatico, albero considerato sacro.
Intenta a filare la lana come le tre Parche della mitologia greca, coloro che tessevano il filo della vita di ogni persona.
Sa filonzana rappresenta una figura che se non rispettata e temuta per evitare sventura. In un mondo legato al capriccio delle stagioni e a forze naturali, la benevolenza delle divinità gioca un ruolo fondamentale.
La donna regge tra le mani un fuso e, attorno a esso, un filo che continua a girare e a filare e una forbice, con la quale mima il gesto del taglio.
Essa chiude la processione, restando dietro ai boes e ai merdules. Quando taglia il filo, i boes cadono a terra rialzandosi dopo pochi minuti, a simboleggiare il ciclo della vita.
![]()
Mamoiada
Se a Ottana troviamo buoi e guardiani, spostandoci a Mamoiada osserviamo intorno ai fuochi in onore di Sant’Antonio, delle maschere molto diverse: quelle dei mamuthones, forse le più note della Sardegna.
I fuochi, qui, sono sparsi per tutto il paese. Ogni rione ha il proprio e i mamuthones, insieme agli issohadores, dovranno raggiungerli tutti per danzare intorno a essi.
Le origini di queste maschere e del rito a esse connesso si mescolano alla leggenda. Secondo l’archeologo dell’Accademia delle belle arti di Sassari, Marcello Madau, i mamuthones sfilavano già dal XIX secolo. Secondo altri studiosi, però, l’origine di queste maschere risalirebbe all’epoca nuragica (prima del 238 a.C.), quando rappresentavano un rito propiziatorio per favorire il raccolto nei campi, e di protezione e venerazione della natura.
Potrebbe però esserci addirittura un’origine legata ai riti dionisiaci per l’avvicendarsi delle stagioni, o una processione arcaica in onore di un dio dalle sembianze di un bue.
Altri ancora invece ipotizzano che possano rappresentare la vittoria dei pastori sardi sugli invasori saraceni fatti prigionieri e condotti in corteo per le strade.
In ogni caso, per un mondo dedito alla pastorizia e attento ai ritmi naturali, celebrare la nuova stagione con danze e riti propiziatori è qualcosa che ha a che fare con la vita e la sopravvivenza. Si danza, si prega, si canta, si accendono fuochi perché, dopo i mesi di gelo, i campi possano tornare a nuova vita.
![]()
Maschere parlanti
Se le maschere hanno origini antiche, bisogna pure che qualcuno si occupi di continuare a realizzarle per portarne avanti la tradizione.
Incontriamo Gian Paolo Marras che con il suo laboratorio «Animas de Sardinia» mescola tradizione e innovazione.
Mentre lavora con mani sapienti il legno di pero che formerà le maschere dei boes e dei merdules, racconta di come – imparando il mestiere dal padre – abbia presto capito che tutto ciò che serve sta nelle mani.
Le proporzioni fra naso, occhi e bocca, infatti, si misurano così, utilizzando il palmo.
Gian Paolo, oltre a essere un artigiano esperto, è un innovatore: ha escogitato un sistema con Qr code che, riportato sul cartellino di ogni maschera, contiene la narrazione vocale del significato della maschera stessa e dell’antico rituale del carnevale: «È necessario che le persone, acquistando una maschera, ne comprendano il valore profondo, la ritualità a essa collegata. Non si tratta solo di oggetti belli da possedere ma di veri e propri simboli di ciò che per noi sardi è la nostra cultura, da sempre legata, connessa e attenta alla natura».
![]()
Campanacci d’artista
Restiamo in Barbagia, ma arriviamo a Tonara (Nuoro), uno dei borghi più alti dell’isola, a Sud Ovest del parco del Gennargentu. Qui incontriamo Ignazio Floris e i suoi due figli, Marco e Salvatore. La loro azienda produce i meravigliosi campanacci che adornano le maschere. Pur essendo a gestione familiare, oggi si avvale di un apprendista che, diversamente dalla tradizione, non fa parte della famiglia, Luca.
Qui si fanno campane dalla mattina alla sera. I Floris, infatti, sono iscritti alla camera di commercio come «forgiatori di campane».
Marco ci spiega che, in Italia, sono forse gli ultimi a dedicarsi interamente a questa arte. In molte altre fucine, infatti, vengono realizzate non solo campane, ma anche altri oggetti.
Nella forgia di Ignazio Floris, il fuoco è dedicato esclusivamente ai campanacci, in sardo tonarese «sonaggios»: ce n’è di tutte le dimensioni e ciò che conta, ciò che davvero è impressionante, è che ognuno di essi è unico. Ignazio ci racconta di aver imparato il mestiere dal padre e che per diventare forgiatori di campane è necessario soprattutto un buon orecchio.
Sì, perché se per realizzare le maschere «si ha tutto nelle mani», come dice Gian Paolo Marras, forgiare i campanacci dipende dalla capacità di ascolto.
Ogni campanaccio ha un suo suono, e deve essere così perché il pastore, grazie a quel suono unico e particolare, potrà riconoscere i propri animali al pascolo e rintracciarli in caso di difficoltà, pericolo, o più semplicemente per comprendere dove il gregge si stia muovendo.
I campanacci Floris hanno segnato la vita di generazioni e generazioni di pastori sardi: a fine Ottocento la bottega era già attiva. Campanacci indossati dalle pecore e, durante i giorni del carnevale, prestati alle maschere.
Se oggi è possibile acquistarne per adornare la propria maschera, in passato i pastori si limitavano a «spogliare» dei campanacci i propri animali e indossarli per celebrare Sant’Antonio e i riti connessi.
Dall’animale all’uomo e viceversa: in Sardegna il rapporto con la natura è davvero trascendente in ogni sua espressione.
![]()
Pane e «prioresse»
Durante i giorni dedicati al santo, è tradizione che nessuno resti digiuno. Nei giorni precedenti, le famiglie si prodigano nella preparazione di pane e dolci tipici che verranno poi offerti a tutti coloro i quali prenderanno parte ai festeggiamenti. Il pane che viene preparato è portato in chiesa proprio il 16 gennaio e qui viene benedetto dal prete. Alla fine della celebrazione, il pane verrà distribuito non solo fra coloro i quali hanno partecipato alla messa, ma a chiunque ne chieda, maschere comprese.
Si pensa che mangiarne nutra corpo e anima e possa esaudire una grazia.
Spezzare il pane insieme, dividere il pasto, condividere il poco fra molti: azioni che hanno a che fare con il cristianesimo, certo, ma anche e soprattutto con un profondo senso di umanità che qui, nel cuore della Sardegna, in Barbagia, si esprime in una grande ospitalità.
Lontano dal preconcetto che vuole la Barbagia come un luogo impenetrabile e forse anche pericoloso (basti pensare al periodo del banditismo e a tutto ciò che lo circonda storicamente), l’interno della Sardegna rapisce il cuore con un’ospitalità rara e preziosa, come quella della signora Maria Antonia, da oltre trent’anni «prioressa di S. Antonio Abate», insieme a Pina, Lidia e Anna.
Ogni giorno Maria Antonia e le altre prioresse, si occupano della chiesa e della cattedrale, aprendole per le celebrazioni, tenendole in ordine e prodigandosi perché il 16 gennaio tutto sia pronto per la grande festa.
Nonostante i tanti doveri, però, trovano il tempo di invitare chiunque passi dalla chiesa a bere un caffè e assaggiare un dolce, perché in Barbagia, che sia Sant’Antonio o un giorno qualunque, nessuno deve sentirsi abbandonato. Lontano dalle coste, lontano anche dal periodo estivo che vede un picco di turismo concentrato sulle meravigliose spiagge di questa isola, c’è un cuore antico vivo e pulsante, un territorio aperto e ospitale da conoscere in ogni momento dell’anno.
Valentina Tamborra
Nota. Questo reportage è stato reso possibile grazie, anche a:
- Sardegna Film Commission https://www.sardegnafilmcommission.it
- con l’aiuto di Claudia Sedda e Regione autonoma della Sardegna. https://www.regione.sardegna.it/regione/
| https://animasdesardinia.com
| http://www.merdules.it/it/
| https://mamuthones.it
![]()