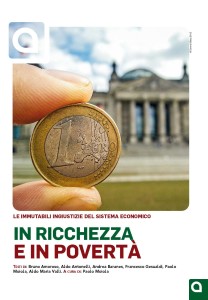Brasile: l’aquila sul tetto
Padre Pietro Parcelli ha lasciato il Brasile nel 2014 dopo lunghi anni di servizio missionario. Per gli amici la parola «lasciato» è un eufemismo, perché di fatto il suo cuore è ancora là, più precisamente a Salvador, capitale dello stato di Bahia, dove, nella zona di Novos Alagados, anni fa ha aiutato a nascere il progetto «Kilombo do kioiô». Qui condivide alcuni ricordi di un viaggio compiuto nell’agosto 2015.
Quella mattina del 5 agosto, appena entrato a Kilombo, sono rimasto colpito da un uccello grande e robusto che dal tetto osservava ogni cosa con occhio sicuro e senza timore. Ho subito pensato che fosse un uccello rapace proveniente dal bosco vicino, parte del parco di San Bartolomeo, uno dei pochi resti della famosa «Mata Atlantica» (la foresta atlantica di cui si parla su MC 4/2016, pag. 22, ndr). Denys, la direttrice del Kilombo, che mi stava vicina, ha detto: «Vedi, è un’aquila». «Un’aquila? Da dove viene? – ho domandato io – È rara un’aquila da queste parti». «Sì, è un’aquila che viene dalla Mata Atlantica».
Dopo diversi mesi, l’immagine dell’aquila mi torna alla mente come una specie di simbolo che rappresenta in modo particolare gli ultimi 15 anni della mia vita.
Il cammino del Kilombo
È stato nel 1999 che sono sbarcato nella favela di Novos Alagados, nel territorio della parrocchia di São Brás, come un «estranho no ninho», un «uccello fuori dal nido». Accompagnato da un gruppo di giovani parrocchiani visitavo le famiglie. In mezzo alle palafitte, ponti di legno, viuzze, ho visto la fame. Nello sguardo timido delle matriarche, molte abbandonate dai mariti, scorgevo il pianto nascosto suscitato dalla notte che veniva senza aver niente da dare da mangiare ai bambini.
La povertà, la mancanza di strutture sanitarie e la fame mi hanno fatto alzare in volo, come l’aquila della Mata Atlantica, in cerca di soluzioni. E nel piccolo salone in fondo alla chiesa di Aparecida, in riva al mare, abbiamo cominciato a riunire il primo gruppo di mamme. Potevamo fare poco, ma quel poco doveva essere immediato e concreto: consegnavamo mensilmente una consistente cesta di alimenti e, allo stesso tempo, alimentavamo la fede delle famiglie invitandole alla celebrazione domenicale e a una riunione settimanale. È stato così che la Consolata ci ha mostrato che potevamo fare la differenza nella vita di quelle persone, con l’aiuto di amici e benefattori. Col sostegno a distanza di molte generose famiglie italiane abbiamo cominciato ad aiutare uno, due, anche fino a cinque dei figli di quelle mamme che non avevano mezzi per saziare le loro creature.
Siamo andati avanti così con entusiasmo. Ma il problema era enorme e il 2000 fu particolarmente duro. C’era il dubbio di non avere le ali adatte per un volo così alto.
Spiccare il volo
Il 2001 ha invece portato nuova energia. Il progetto cominciava a spiccare il volo: nasceva in un piccolo spazio il «Kilombo do kioiô».
I kilombos erano le comunità in cui si rifugiavano gli schiavi africani che fuggivano dai loro padroni quando il Brasile era dominio portoghese. Il kioiô è una pianta tipica della regione, usata nella medicina e nella cucina locale. In fondo al giardino della casa che avevano comprato per il progetto, c’era proprio una pianta di kioiô. Ecco battezzato il rifugio dove realizzare la nostra missione: offrire un destino differente a chi vive schiavo della fame, dell’abbandono, dell’ignoranza e della mancanza di prospettive.
La cesta di alimenti che offrivamo a molte famiglie era per loro una consolazione, e questo l’abbiamo potuto constatare in diversi momenti. Una mattina ero in macchina con due giovani, dopo aver consegnato la cesta a una mamma ammalata. A un certo punto, quattro giovani armati di pistola ci hanno fermati gridando di scendere dalla macchina. Sentivo le urla delle persone: «È il padre missionario, lasciatelo stare, è il missionario». I giovani che erano con me, pieni di spavento, mi hanno detto di uscire dall’auto e di buttare la borsa a terra. «Che c’è là dentro?», mi ha urlato uno degli assalitori. «Ci sono le cose per la Messa», ho risposto. Dopo aver dato un calcio alla borsa si sono dileguati.
Insegnare a volare
Quando il governo brasiliano ha iniziato il progetto «Fame zero», abbiamo capito che era arrivato il tempo di cambiare: non più distribuire cibo, ma insegnare a procurarsene. È nato così il gruppo di alimentazione che oggi conta quarantacinque mamme. Esse vengono nel Kilombo per imparare a cucinare e a fare pane, a confezionare torte dolci e salate. Il ricavato della vendita dei prodotti aiuta a mantenere le attività del Kilombo. È un’iniziativa che insegna un mestiere queste donne che guadagnano anche un po’ di soldini per mantenere la famiglia. Le spese delle materie prime e del centro sono in parte coperte da un contributo delle mamme, che ogni mese versano parte dei loro guadagni, e dalla generosità di benefattori e istituzioni che ci aiutano a portare avanti il lento cammino di formazione umana e professionale che coniuga rendimento e dignità.
Sotto le ali
Quasi tutte le donne con cui lavoriamo abitano in zone dominate dal traffico della droga. Da loro è venuta la richiesta di fare qualcosa per togliere i figli dalla strada. È così che nel 2011 abbiamo spiccato un altro volo, senza poter prevedere dove saremmo arrivati. È nato il doposcuola del Kilombo. Rispetto alla scuola statale, qui ogni attività è preceduta dalla preghiera e si svolge in un clima più dinamico e alternativo, stimolando la creatività. La preghiera è sempre rivolta alla patrona del Kilombo: Nossa Senhora Consolata.
La missione del doposcuola è di migliorare le conoscenze acquisite dai ragazzi nella scuola statale, perché il livello educativo nella zona è molto basso. È facile incontrare bambini che a dieci anni non sanno leggere né scrivere. E per evitare che la fame fosse un ostacolo alla resa nell’aula scolastica, abbiamo cominciato a offrire una merenda abbondante.
Il Kilombo segue direttamente 66 bambini divisi in cinque classi. Al mattino sono 32 ragazzi dagli otto ai tredici anni, divisi in due classi. Al pomeriggio sono 34 dai sette ai quattordici anni, distribuiti in tre classi. Ogni classe è accompagnata da un’insegnante e una vice. Le attività sono molto diversificate: mensilmente i bambini hanno lezioni di salute dentaria; sono visitati regolarmente da narratori di fiabe e storielle, importanti per i bambini; ricevono formazione su alimentazione, igiene e salute; sono addestrati al primo soccorso da volontari dell’Università Federale della Bahia; mentre gli insegnanti partecipano a corsi di aggioamento finanziati dalla Fondazione Roberto Marinho, sostenuta della Rede Globo, il più grande gruppo di radio e televisione del Brasile.
La capoeira
La capoeira è praticata con entusiasmo nel Kilombo. È un’arte marziale con un sistema di attacco e difesa di carattere individuale, molto simile a una danza. Bambini, adolescenti e giovani sono aiutati dalla pratica di questo sport a sfuggire alla droga e alla criminalità.
Durante la mia visita dello scorso agosto, guidato dal suono del berimbau, strumento a corda che è utilizzato per segnare il ritmo della danza, ho camminato con i ragazzi fino al parco S. Bartolomeo, un’area ricca di ricordi della cultura afrobrasiliana, localizzata a 500 metri dal Kilombo. Siamo arrivati alla cascata di Oxum (Oxum è un orixa, cioè una delle divinità del Candomblé, religione afro brasiliana), e là è iniziata la ruota della capoeira. Il canto degli uccelli si è sintonizzato con le battute dei tamburi, mentre i movimenti acceleravano in una sincronia perfetta. Per loro il cielo non sembra avere limiti.
Anche le nonne volano
Nel 2014 è arrivata una nuova ispirazione: coinvolgere nelle attività del Kilombo anche le nonne della comunità. Si è cominciato con una settimana di attività nel mese di luglio, mese dedicato alle nonne qui in Brasile. Il risultato è stato così entusiasmante che, nonostante la difficile situazione economica, abbiamo deciso di aprire le porte alle donne anziane. Sono quindici signore con più di 50 anni di età, che sono invitate a partecipare al progetto di alimentazione del Kilombo. È un tempo di terapia e socializzazione, attività molto importanti nella situazione di abbandono in cui vivono. Così abbiamo spiccato un altro volo.
Durante la mia visita della scorsa estate, in una casetta vicino al Kilombo, ho conosciuto Luzia, una giovane di 22 anni, cieca, con deficienza mentale e un solo polmone. Sua madre, donna Val, aveva preso la varicella quando era incinta della bambina. Nonostante il consiglio medico di abortire, ella aveva voluto aprire le ali e accogliere Luzia. Lo sforzo di accudire la figlia è immenso, ma l’amore vince ogni barriera. Val prepara la merenda per i bambini del Kilombo. A volte arriva un po’ in ritardo, ma nulla le toglie il sorriso e la sua volontà di vincere.
In un’altra visita sono andato a casa di Marta, una delle mamme del Kilombo. Il figlio Jomarley di dieci anni, con paralisi celebrale, è stato abbandonato dal padre. Marta si fa in quattro per dar da mangiare a Jomarley e Taiana di dodici anni.
I rapaci
Tutte queste attività, prima di realizzarle, sembravano un sogno davanti alla realtà in cui si trovava il Kilombo. E ancora di più oggi, davanti alla crisi del Brasile di questi ultimi mesi. Una nonna del progetto mi ha detto: «Prima con un real (moneta brasiliana) compravi sei panini, ora due». Ma nonostante i rapaci della crisi e dell’inflazione, vogliamo continuare a sognare nuovi voli.
Padre Pietro Parcelli, missionario della Consolata,
in collaborazione con Diniz Vieira, giornalista,
e Adenilza Cruz, direttrice e cofondatrice del Kilombo do kioiô.