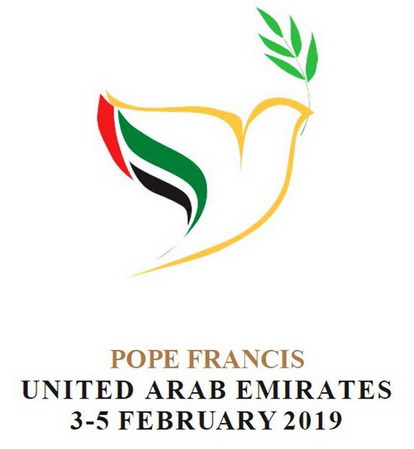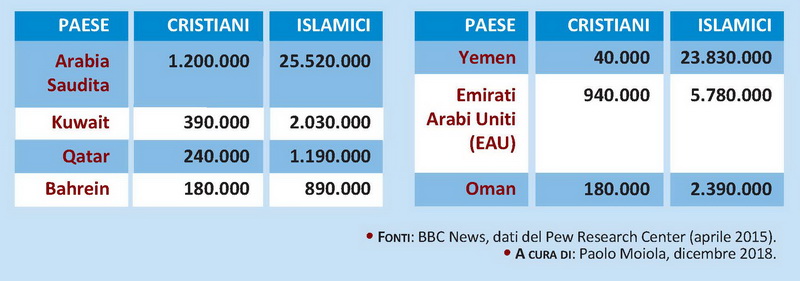Reportage da Kirkuk: I sopravvissuti (alla follia dell’Isis)
L’Isis ha portato distruzione, morte e follia non soltanto a Mosul. Siamo andati nella città petrolifera di Kirkuk, a lungo contesa dalle varie fazioni in lotta, per incontrare i sopravvissuti della guerra. Molti altri vivono nei campi profughi (a volte da anni) in attesa di capire la loro sorte.
testo e foto di Angelo Calianno
Sono passati quasi 5 anni dalle invasioni e dai massacri dell’Isis in Iraq. Dal 2017 la presenza degli uomini del Daesh è stata notevolmente ridimensionata fino a ridursi a poche frange che combattono ancora in Siria. Alcune tra le città precedentemente occupate – come Sinjar, Mosul, Kirkuk – sono state riconquistate, anche se sono andate semidistrutte durante le battaglie per riperderne il controllo.
Dove sono oggi tutti quegli uomini e donne che hanno combattuto contro l’Isis? Dove sono e cosa fanno oggi le persone sopravvissute a maltrattamenti, abusi e violenze? Ci sono ancora cellule dormienti dell’Isis? Dove sono gli accusati di collusione con i terroristi dello Stato islamico?
Tra Erbil, Mosul e Kirkuk incontro alcune delle persone che hanno vissuto quei giorni, che hanno perso molti dei propri cari durante gli scontri e gli attentati di questi ultimi, tremendi anni.
![]()
Il petrolio (come sempre)
Uno dei più grandi obiettivi del Daesh durante la sua prima comparsa è stata proprio Kirkuk.
Questa è oggi una città di circa 600 mila abitanti di diversi credi religiosi, tra cui sunniti, sciiti e cristiani. L’importanza della città risiede nel suo sottosuolo, uno dei più ricchi e antichi giacimenti di petrolio del Medioriente. Una stima dello scorso novembre ha calcolato che, se si estraesse tutto il petrolio greggio da quest’area, la sua quantità ammonterebbe a oltre 9 miliardi di barili: questo dice molto sul motivo per il quale sia stata così contesa.
I terroristi del califfato sono arrivati a Kirkuk e nella sua provincia nel 2014. La regione è stata strenuamente difesa dalle milizie curde dei peshmerga che l’hanno contesa all’Isis fino al 2017. Anche lo stato semiautonomo del Kurdistan avrebbe voluto, in qualche modo, annettersi i giacimenti di petrolio ai suoi territori. Nel 2017, le milizie sciite del governo iracheno però sono entrate in città con i carri armati a riprenderne il controllo.
Si è sfiorato un altro conflitto interno tra curdi iracheni e iracheni, diversi civili sono stati feriti e tantissimi curdi, inclusi i peshmerga, hanno ripiegato verso la capitale Erbil, lasciando definitivamente Kirkuk nelle mani di Baghdad.
A Kirkuk
Arrivo nella zona di Kirkuk in auto con Ahmed Salah, un militante peshmerga che ha combattuto un po’ ovunque sul fronte anti Isis. Alcuni dei suoi zii e cugini sono morti proprio in questa zona, durante i primi scontri contro gli uomini dello Stato islamico.
Per arrivare qui da Erbil abbiamo attraversato tre check-point, uno peshmerga e due delle forze di sicurezza irachene. «Da questi villaggi e queste campagne – mi racconta -, molta gente si è unita al Daesh. Vedi quella casa? Oggi è tenuta sotto controllo 24 ore al giorno: uno dei ragazzi che ci abitava con la sua famiglia era un terrorista, oggi è in carcere. Ha molti fratelli e si teme che alcuni di loro possano far parte delle cellule dormienti».
![]() Pensi ci siano molte persone che segretamente ancora supportano l’Isis?, gli chiedo. «Io penso di sì, lo pensa anche l’intelligence, vedi quel ragazzo ad esempio?».
Pensi ci siano molte persone che segretamente ancora supportano l’Isis?, gli chiedo. «Io penso di sì, lo pensa anche l’intelligence, vedi quel ragazzo ad esempio?».
Mi dice indicando un ragazzo vestito con abiti tradizionali, barba lunga e con visibili problemi di ritardo mentale.
«Il Daesh arruolava molte persone con poca istruzione, gente che aveva problemi mentali o problemi economici. Li indottrinavano con la religione islamica. Io conosco quel ragazzo e la sua famiglia: non si sarebbe mai vestito così prima. È stato arruolato anche lui, poi per il suo chiaro stato psicologico è stato lasciato in pace e riaffidato alla famiglia che comunque è sotto controllo».
Tu hai combattuto un po’ ovunque – dico al mio interlocutore -. C’è stato un episodio che più di altri ti ha segnato? «Ce ne sono stati tanti, uno dei più brutti è stato quando ho trovato mio cugino e mio zio uccisi qui vicino. Tuttora non ne sappiamo il motivo, ma durante l’invasione del Daesh si moriva per niente. Forse però l’immagine che non mi toglierò mai dalla mente è un’altra…».
![]()
Ahmed Salah tira fuori il cellulare per farmi vedere alcune fotografie, ritraggono un pickup bianco con quattro cadaveri senza vestiti al suo interno: «Qui eravamo tra Mosul e Sinjar. Avevamo scavato delle trincee per ostacolare qualsiasi attacco potesse arrivare con i mezzi terrestri. Una mattina, all’alba, vediamo questo pickup venire a tutta velocità verso di noi. Non si vedeva nulla per la nebbia e il parabrezza era tutto sporco di terra e polvere».
«Abbiamo aperto il fuoco contro il veicolo che poi si è infossato nella trincea. Quando abbiamo aperto le portiere del mezzo abbiamo trovato loro: erano quattro ragazzini nudi e legati. Sull’acceleratore era stata messa una pietra. Erano sicuramente stati rapiti, avevano subito abusi e poi erano stati lanciati contro di noi. Non siamo mai nemmeno riusciti a fare il riconoscimento dei cadaveri per sapere chi fossero, ma forse per i parenti, in quei giorni, è stato meglio non sapere la fine che avevano fatto i loro figli».
Ahmed Salah mi saluta e si incammina verso casa, ma dopo qualche secondo torna indietro per dirmi qualcos’altro: «Vorrei aggiungere un’altra cosa, un dubbio che per noi è sempre stato importante. All’inizio, durante gli scontri con il Daesh, venivamo continuamente bombardati. I colpi di mortaio si susseguivano notte e giorno, senza tregua. Poi le esplosioni cessavano non appena gli americani mettevano piede nel nostro campo. La stessa cosa accadeva quando dalle nostre postazioni gli americani cercavano di colpire i terroristi, non centravano mai l’obiettivo al primo colpo, ma sempre al terzo o al quarto. Queste coincidenze sono accadute più di una volta e a tutti i peshmerga hanno sempre creato molto sospetto».
![]()
Nel nome di Allah
A Kirkuk incontro altri due ragazzi che sono sfuggiti per un soffio alle spedizioni punitive dell’Isis. Essendo cristiani erano uno i primi bersagli da persegure. Il modo in cui sono riusciti a scappare è davvero particolare: «Siamo scappati perché uno dei nostri amici era con il Daesh. Prima di arrivare a Kirkuk ci ha telefonato per avvisarci, così siamo riusciti a fuggire con le nostre famiglie».
Chiedo loro: conoscevate molte persone che si sono unite al Daesh? Se sì, perché lo hanno fatto secondo voi? «Ne conoscevamo diverse, con due in particolare lavoravamo trasportando ortaggi e frutta nei mercati. Sai, all’inizio, quando ne parlavano e facevano le prime riunioni nelle moschee, non sembrava una cosa così grande. Nessuno pensava che saremmo arrivati a questo punto, alla guerra, alle violenze. I miei amici si sono uniti al Daesh perché a loro sembrava una cosa giusta. Erano sunniti. Il governo sciita di Baghdad aveva impoverito le loro famiglie, vedevano la corruzione ovunque. Il Daesh aveva promesso che ci sarebbero stati soldi divisi più equamente nel nome di Allah. Io penso che quando si sono resi conto di quello che sarebbe successo, fosse troppo tardi per tirarsene fuori. Sono riusciti però a salvare noi».
Avete avuto più notizie di loro? «No, penso siano morti. Non sono più tornati a casa e le loro famiglie comunque sono sorvegliate dall’esercito, nel caso dovessero tornare o altri terroristi si facessero vedere».
Gli Yazidi del campo profughi
Gli uomini dell’Isis hanno perpetrato violenze ovunque, ma c’è un gruppo su cui si sono particolarmente accaniti, i credenti di una fede religiosa che i terroristi hanno praticamente decimato. Sono gli Yazidi, ritenuti dal Daesh, per il loro singolare credo religioso, adoratori del diavolo.
Uno degli stermini più atroci che l’Iraq abbia mai vissuto si è consumato a Sinjar. Il 4 agosto 2014 gli uomini del Daesh hanno ucciso 5mila persone, mentre in 7mila sono stati rapiti, la maggior parte donne per diventare «schiave del sesso», e bambini, poi mandati nelle scuole di rieducazione per diventare militanti, erano tutti di fede yazida.
![]() Mirza è una di quelle persone riuscite a fuggire dal massacro. Ha 39 anni, anche se dimostra molto più della sua età. Lo incontro in una tenda nel campo di rifugiati a Shari, nella provincia di Dohuk. L’Iraq ha decine di campi profughi destinati ai cosiddetti «rifugiati interni», quelle persone che hanno perso le proprie case e terre durante il conflitto contro l’Isis. In questo campo sono quasi 5mila. Vivono accatastati in tende consumate dalle intemperie.
Mirza è una di quelle persone riuscite a fuggire dal massacro. Ha 39 anni, anche se dimostra molto più della sua età. Lo incontro in una tenda nel campo di rifugiati a Shari, nella provincia di Dohuk. L’Iraq ha decine di campi profughi destinati ai cosiddetti «rifugiati interni», quelle persone che hanno perso le proprie case e terre durante il conflitto contro l’Isis. In questo campo sono quasi 5mila. Vivono accatastati in tende consumate dalle intemperie.
Mirza ha combattuto nell’esercito iracheno per 11 anni, per questo, quando l’Isis è arrivato a Sinjar, il suo nome era in cima alla lista delle persone da eliminare. Da 4 anni Mirza vive qui con la sua famiglia. In una delle tende a lui destinate ha aperto un piccolo laboratorio dove ripara apparecchi elettrici. Nel campo tutto funziona solo con i generatori a gasolio. Lo intervisto mentre si riscalda davanti a una stufetta a legna. Fuori ci sono tre gradi e la pioggia battente ha ricoperto le strade del campo di fango.
Mirza, raccontami di come hai fatto a fuggire da Sinjar? In quanti siete scappati? «Prima del 4 agosto 2014, già da giorni sapevamo che il Daesh sarebbe arrivato. Avevo dei conoscenti che si trovavano vicino al loro campo, furono loro ad avvisarci di scappare. Ci dissero che altrimenti sarebbe potuta finire molto male per noi. Con mio fratello prendemmo tutta la nostra famiglia: i nostri figli, mogli, fratelli e sorelle, eravamo in 30, la notte prima che arrivassero gli uomini del Daesh ci nascondemmo in montagna».
Come avete fatto a sopravvivere? Siete più tornati a Sinjar?, gli chiedo. «Ogni notte scendevo nei villaggi a valle per prendere da mangiare, dalle montagne abbiamo poi passato illegalmente il confine con la Siria dove siamo rimasti per tre mesi, poi anche lì la situazione cominciò a peggiorare. Allora sono riuscito a trovare uno smuggler che ci ha portato di nuovo in Iraq e poi in Kurdistan. Abbiamo speso tutto quello che avevamo per il viaggio, 1.000 dollari. Sono in questo campo da allora».
Conoscevi alcune delle persone che si sono arruolate con l’Isis? A molti faccio la stessa domanda, come hanno potuto farlo secondo te? Molte delle persone, prima che arrivasse Daesh, vivevano in pace e non avevano mai fatto del male a nessuno.
«Io penso che dipenda moltissimo dalla loro istruzione ed educazione, da dove vengono, dalle loro famiglie, per molti all’inizio sembrava una cosa buona, nessuno quando si sono arruolati aveva parlato di sterminare gli Yazidi, uccidere i propri amici perché di religione diversa. La propaganda era più religiosa e mirata contro l’invasione occidentale, contro le multinazionali che volevano usare la nostra terra, contro la corruzione. Ogni giorno però la situazione diventava più grave fino ad arrivare a quello che sappiamo oggi. Ci hanno sterminati», mi dice commuovendosi.
«Io conoscevo alcune delle persone che hanno attaccato Sinjar. Molto probabilmente oggi sono morte. Io non ce l’ho con loro. So che sono stati manipolati e che gli hanno riempito la testa di sciocchezze. Però nessuno ci ha difeso, ora con la mia famiglia viviamo qui, senza lavoro, senza futuro. Quest’anno non ci hanno nemmeno consegnato il gasolio per il riscaldamento e da giorni non fa altro che piovere. Io vorrei tornare un giorno a Sinjar, ma oggi Sinjar non esiste più».
Mirza mi racconta che nel campo ci sono anche diverse ragazze che sono state rapite da Daesh e poi segregate a Mosul per essere «schiave sessuali»: «Conosco le famiglie di tutti qui, alcune di queste ragazze, da allora, da quando sono riuscite a scappare, non parlano più, non riesco a immaginare quanto possa essere doloroso solo ricordare quello che è successo».
![]()
Bassem, cristiano di Mosul
Spostandomi a Mosul mi ritrovo in una città in rovina. In questi vicoli, oggi devastati dai bombardamenti americani, sono morti insieme agli uomini dello Stato islamico anche migliaia di civili. In alcune di queste case, mi dice la gente per strada, l’Isis teneva segregate sia ragazze che ragazzi per abusare sessualmente di loro. Altri luoghi invece, come chiese e scuole, venivano usati come carceri o stanze per le esecuzioni.
Davanti alla chiesa armena di Etchmiadzin, sventrata dalle bombe americane, incontro Bassem.
Vive in uno stanzino qui accanto, poca roba ammassata sotto un edificio pericolante, lo incontro mentre beve whisky da una bottiglia di plastica con due suoi amici. Molti non musulmani comprano a poco prezzo distillati fatti in casa: per tanti di loro, soprattutto dopo la distruzione di Mosul, è l’unica via di fuga dalla realtà.
Bassem, perché hai deciso di vivere in questo centro storico ormai distrutto?, gli chiedo. «Ho sempre vissuto qui. Non me ne sono andato quando è arrivato Daesh, non me ne sono andato quando gli americani bombardavano e non me ne vado adesso. Poi li vedi quelli?».
Mi dice indicando alcuni ragazzi con un vecchio veicolo a tre ruote: «Girano di edificio in edificio per rubare tutto quello che trovano, soprattutto metalli come il rame. In questa chiesa ci sono ancora candelabri, lapidi, targhe di ottone. Io sono qui per proteggerla».
![]()
Bassem toglie il lucchetto della catena che chiude la porta della chiesa. Entrando, tra calcinacci e vetri rotti, solleva il maglione per mostrarmi delle cicatrici sulla schiena: «Un giorno mi hanno portato qui perché hanno trovato a casa mia una parabola per la televisione e dell’alcol. Mi hanno preso a bastonate sulla schiena e lasciato per terra. Non sono riuscito a muovermi per settimane. Ridevano mentre lo facevano e mi sputavano addosso».
Bassem mi mostra altri angoli della chiesa e racconta ancora dei giorni dei bombardamenti. Lo fa con un sorriso abbozzato, con il sollievo di essere sopravvissuto, ma senza molta speranza di vedere una ricostruzione. Dopo aver riconquistato la maggior parte delle città irachene, è cominciata la ricerca dei dispersi, migliaia sono le persone di cui non si ha più traccia.
Tra novembre 2018 e gennaio 2019 sono state trovate oltre 200 fosse comuni contenenti migliaia di cadaveri giustiziati dall’Isis. Al momento sono state scoperte nelle province di Ninive (la maggior parte attorno alla città di Mosul), Kirkuk, Salahuddin e Anba.
Secondo le prime stime dell’Onu, le vittime trovate sarebbero 12mila. Si è cominciato un lento e paziente riconoscimento dei cadaveri che potrebbe portare in futuro a dei processi per crimini contro l’umanità. Tutti gli intervistati mi hanno parlato delle vittime ancora da ritrovare. Nella stessa Mosul, ad esempio, tantissimi corpi si trovano ancora sotto le macerie della città, impossibili da estrarre se non ci sarà una ricostruzione.
![]()
Dopo l’Isis: giustizia sommaria, sospetti, paura
Il segno dell’Isis non è stato lasciato solo addosso alle sue vittime. Proprio in questi giorni Human Rights Watch ha pubblicato un dossier che parla di arresti indiscriminati e torture da parte dell’intelligence irachena e di quella curda, ai danni di chi – in qualche modo – ha interagito con gli uomini del Daesh.
Ragazzi che lavoravano nei ristoranti dove gli uomini del califfato andavano a mangiare, musulmani sunniti che praticano un islam più radicale, famiglie di ragazzi arruolati nelle file dell’Isis. Moltissimi vengono arrestati, interrogati, spesso con violenza, e una volta rilasciati, tutta la loro comunità li marchia come terroristi. Tra di loro ci sono molti minorenni, Human Rights Watch, nel suo dossier, riporta che fino a dicembre 2018 il numero di minori detenuti superava i 1.500, di cui 185 condannati con l’accusa di terrorismo. Recentemente, 19 di loro hanno dichiarato di essere stati percossi con tubi di plastica e torturati con scosse elettriche, fino ad essere costretti a confessare di aver fatto parte dell’Isis. Tutto pur di far cessare le torture.
Il terrorismo in queste terre non ha portato solo morte e distruzione ma ha lasciato una scia di paura: la paura di un’altra guerra e che nuovi gruppi di terroristi possano apparire da un giorno all’altro. Questa paura ha fatto chiudere spesso un occhio alle autorità sui metodi usati nelle indagini antiterrorismo, e ha portato ad un sovraffollamento, spesso non giustificato, delle carceri.
Il timore che l’Isis possa tornare ha inoltre insinuato il sospetto della gente nei confronti dei propri vicini di casa, a dubitare dei propri conoscenti, a volte dei propri amici.
Malgrado questo, ogni persona da me incontrata o intervistata mi ha espresso speranza. Non quella di avere una vita migliore o rivivere nelle proprie case ricostruite, ma quella di tornare a vivere in pace, senza paura che il terrore possa tornare a regnare per queste strade.
Angelo Calianno
Yazidi: Il tempio vuoto
Su una montagna, a 60 km da Mosul, sorge il sacro tempio degli Yazidi, dove una volta l’anno i fedeli si recano in pellegrinaggio.
È un freddissimo giorno di febbraio, piove da molti giorni, ci togliamo le scarpe per camminare nella parte sacra del tempio, sentendo la pietra bagnata e gelata del pavimento delle ampie corti. Uno dei sacerdoti mi mostra il pozzo sacro: «Qui – mi racconta -, è dove tutte le ragazze, dopo essere scappate o liberate dalla cattività dell’Isis, vengono per purificarsi, per essere di nuovo pulite».
Come mai è così vuoto il tempio?, chiedo. «Da quando è arrivato l’Isis il numero di chi viene al tempio è sempre minore, persino nelle nostre festività principali ho visto centinaia di persone in meno. Tutto questo è il frutto dei massacri e anche della fuga di tanti nostri fedeli all’estero».
Si è stimato che su quasi 600mila yazidi, 100mila siano fuggiti all’ estero durante i primi attacchi dello Stato islamico. Oggi 6.500 sono le persone, per lo più donne, che portano il peso e i segni della cattività, durata in alcuni casi 3 anni. Sopravvissute ai rapimenti, agli stupri sono passate da questo tempio per lavarsi via la violenza, per ricominciare una nuova vita.
A.Cal.
Archivio MC: sulla vicenda degli Yazidi la rivista ha pubblicato un dossier uscito a marzo 2017 e firmato da Simone Zoppellaro.