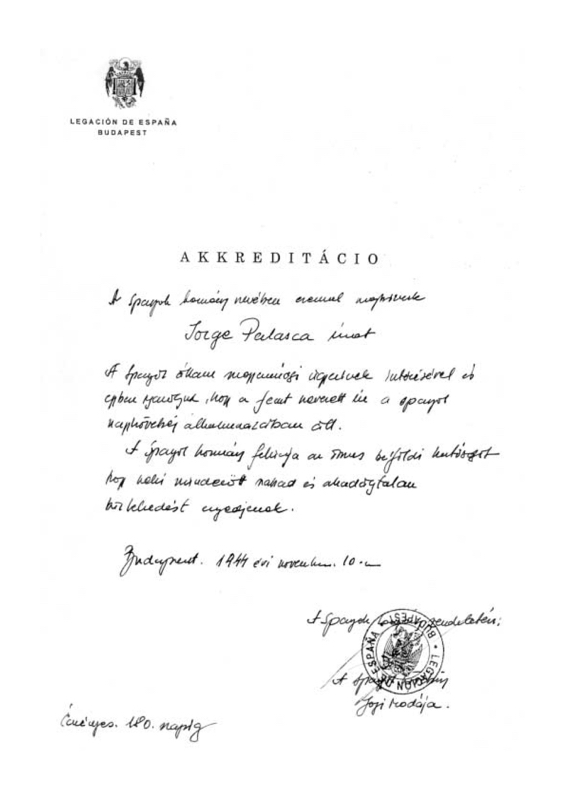Le biografie: Romero e Câmara
testo di Sante Altizio |
Due vescovi latinoamericani. Due difensori degli oppressi. Modelli per una Chiesa che compie anche oggi la sua scelta preferenziale per i poveri.
Anselmo Palini è un insegnante bresciano di scuola secondaria che ha all’attivo una serie di pubblicazioni sui temi della pace, della nonviolenza e dei diritti umani davvero notevole.
È stato tra i primi, negli anni Ottanta, a sollevare domande sul senso della presenza della produzione di armi nella provincia di Brescia. La quasi totalità delle armi leggere italiane, infatti, arriva da quell’area.
Nel 2020, la storica Editrice Ave, fondata nel 1935 da Luigi Gedda, ha ripubblicato due testi di Palini che, a distanza di una decina d’anni dal loro primo arrivo in libreria, meritavano di tornare all’attenzione del pubblico.
Si tratta di due biografie ricche, approfondite, senza sbavature: una dedicata a san Oscar Romero, il vescovo martire del Salvador, e l’altra a Hélder Câmara, il «vescovino» brasiliano, tra i massimi alfieri della «scelta preferenziale per i poveri» compiuta dalla Chiesa latinoamericana nella Conferenza di Medellín del 1968.
Il SudAmerica al centro
Con l’elezione al soglio pontificio di José Mario Bergoglio, argentino di Buenos Aires, è diventato chiaro per molti ciò che era già evidente da diversi anni agli osservatori interessati: il mondo latinoamericano è il nuovo motore della chiesa cattolica. E se mons. Bergoglio è diventato papa Francesco, il «merito» è anche di uomini come Oscar Romero e Hélder Câmara, che quel motore lo hanno alimentato.
San Romero de America
![]() La biografia che Palini dedica a Romero ha un sottotitolo forte: «Ho udito il grido del mio popolo», e una postfazione pregiata che porta la firma del cardinale Gregorio Rosa Chávez, il quale, quando l’arcivescovo di San Salvador venne assassinato, era rettore del seminario diocesano della capitale centroamericana.
La biografia che Palini dedica a Romero ha un sottotitolo forte: «Ho udito il grido del mio popolo», e una postfazione pregiata che porta la firma del cardinale Gregorio Rosa Chávez, il quale, quando l’arcivescovo di San Salvador venne assassinato, era rettore del seminario diocesano della capitale centroamericana.
Era il 24 marzo del 1980. Alle ore 18.25, mentre celebrava la messa, appena terminata l’omelia, mons. Oscar Arnulfo Romero venne raggiunto da un colpo di arma da fuoco in pieno petto. Si accasciò sull’altare e morì.
La biografia di Palini traccia il percorso che portò un uomo di Chiesa con una formazione teologica tutt’altro che avanzata, e nessuna voglia di diventare una celebrità, alla scelta di stare dalla parte dei deboli di fronte alla crudele repressione della dittatura militare.
Mons. Romero spiazzò tutti, forse anche se stesso, e da «vescovo malleabile» diventò la variabile impazzita che catalizzò la speranza di chi non ne aveva più. Una variabile che sarebbe stata eliminata.
Nel 1980 la Guerra Fredda si combatteva anche in America Latina, e lasciava una scia di sangue apparentemente inarrestabile.
«Le sue omelie – scrive Palini – erano seguite dagli inviati della stampa internazionale per il significato che, nel contesto mondiale, aveva la lotta che si combatteva in questa minuscola nazione, e per la presenza di una Chiesa […] evangelicamente schierata a fianco del proprio popolo e, appunto per questo, violentemente colpita […] dagli squadroni della morte».
Maurizio Chierici, un grande inviato italiano (già collaboratore di MC, ndr), che conobbe e intervistò più volte Romero, scrive nella prefazione: «Un paesino da niente (El Salvador, ndr) trasformato nel poligono dove le società benestanti costruivano il prototipo necessario per non perdere il benessere; sperimentavano la paura come arma invisibile dalla quale i popoli non riescono a difendersi».
Hélder Pessoa Câmara
L’assassinio di Romero, non solo non riuscì a far tacere la sua voce, ma diventò un grido di richiesta di giustizia per un continente intero. E tra coloro che seppero far nascere una nuova speranza dalla morte di Romero ci fu sicuramente Hélder Pessoa Câmara, uno dei vescovi brasiliani più amati e coraggiosi della storia recente.
Classe 1909, morto all’età di novant’anni, dal 2017 è, grazie a una legge dello stato, patrono brasiliano dei diritti umani.
Anselmo Palini, per la biografia di dom Hélder, come sottotitolo ha scelto una sua celebre frase, quasi un manifesto: «Il clamore dei poveri è la voce di Dio».
Nella prefazione, affidata a mons. Luigi Bettazzi, che lo conobbe al Concilio Vaticano II, si legge: «Tempo fa non sarebbe stato necessario introdurre un libro su Hélder Câmara […]. Oggi, a oltre vent’anni dalla morte, il suo ricordo tende a offuscarsi».
L’autore ricostruisce con cura tutti i passaggi che hanno segnato la crescita religiosa di Hélder Câmara. Il capitolo iniziale si intitola: «Gli anni dell’integralismo», ed è subito un’immersione nel suo cammino attraverso le lettere e gli scritti lasciati dal vescovo brasiliano.
C’è un passaggio, a pag. 32, che merita di essere riportato: «Avevo ventidue anni, sognavo anche allora di cambiare il mondo e lo vedevo diviso tra destra e sinistra, cioè tra fascismo e comunismo. […] Scelsi il fascismo. Si chiama Azione integralista, in Brasile. […] E il loro motto era Dio-Patria-Famiglia: un motto che a me andava benissimo. Come giudico ciò? Con il mio semplicismo giovanile […] non c’erano molti libri da leggere, né molti uomini sani da ascoltare». Solo una persona matura può osservare con tanta franchezza il proprio passato.
Seguono due capitoli corposi: «Gli anni del cambiamento» e «Gli anni della profezia».

Câmara per i poveri
![]() Come successo per Romero, quando la realtà bussò alla sua porta, non fu facile per lui fingere di non aver sentito. Il Brasile degli anni delle dittature militari, della povertà diffusa, del razzismo, della devastante ingiustizia sociale, iniziava a far sentire la sua voce disperata. Il giovane sacerdote brasiliano crebbe, e crebbe in lui anche una nuova consapevolezza.
Come successo per Romero, quando la realtà bussò alla sua porta, non fu facile per lui fingere di non aver sentito. Il Brasile degli anni delle dittature militari, della povertà diffusa, del razzismo, della devastante ingiustizia sociale, iniziava a far sentire la sua voce disperata. Il giovane sacerdote brasiliano crebbe, e crebbe in lui anche una nuova consapevolezza.
Negli anni Cinquanta, Câmara arrivò a Rio de Janeiro come vescovo ausiliario, poi partecipò al Concilio e, in seguito, alla Conferenza di Medellín.
Le sue prese di posizione erano sempre più nette contro la violenza e la prepotenza del potere. E poi nacquero decine e decine di gruppi di base, sindacati, cooperative che vennero fondati per organizzare il tessuto sociale, sempre partendo dal basso, dagli ultimi.
Câmara mistico
Dom Hélder aveva doti da mistico: «Tutte le notti si svegliava per un’ora di preghiere e di orientamento della giornata», ricorda mons. Bettazzi; doti da teologo e da vero oppositore politico: cosa che alla dittatura non piacque per nulla.
«La fede, basata sulla Parola di Dio, toglie la maschera alle ideologie dei dominatori. Gesù assume l’identità degli oppressi e vuole essere amato e servito in loro».
Il merito di Anselmo Palini è quello di permetterci di ripercorrere le storie di Oscar Romero e Hélder Câmara con la consapevolezza che, se anche un po’ della loro memoria si è offuscata, i frutti della loro testimonianza ci sono ancora tutti e sono arrivati sino a San Pietro.
Sante Altizio