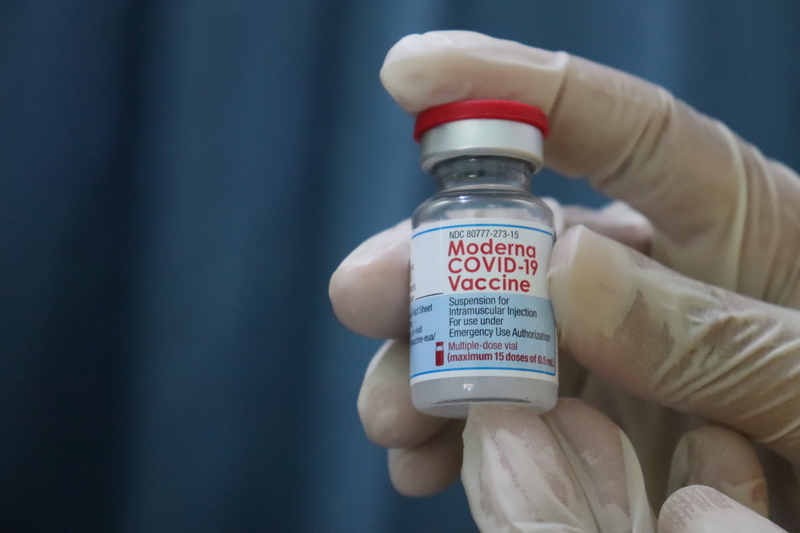Sostenibilità neocoloniale. Minerali e transizione ecologica

Sommario
- I minerali del Sud globale
- Multinazionali estrattive
- Sopravvivere da minatori
- Chi non può resta indietro
I minerali del Sud globale
La corsa del Nord ricco per prendersi le risorse altrui.
Il mondo in balia dei cambiamenti climatici necessita di quantità sempre maggiori di minerali critici per la transizione ecologica. Questi sono spesso presenti nei Paesi poveri. Le logiche neocoloniali dell’economia spingono questi ultimi a perdere il controllo sulle loro risorse. Si apre così la strada a progetti di sfruttamento indiscriminato delle grandi multinazionali.
Dagli anni Cinquanta del Novecento, il cambiamento climatico e i suoi effetti sono diventati sempre più evidenti e, soprattutto, irreversibili.
Come conseguenza delle crescenti emissioni di gas climalteranti (tra cui spicca l’anidride carbonica), negli ultimi 150 anni la temperatura terrestre è cresciuta in modo graduale, ma inesorabile.
Secondo il Climate change 2023 dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) – un gruppo scientifico fondato nel 1988 per studiare i cambiamenti climatici nel mondo -, attualmente ci sono 1,1°C in più rispetto al periodo preindustriale (convenzionalmente prima del 1851).
Nel mentre, gli eventi meteorologici estremi – diretta conseguenza dell’incremento delle temperature – sono diventati sempre più frequenti.

Summit internazionali sul clima
Società civile e classe politica di tutto il mondo hanno iniziato ad assumere reale consapevolezza del cambiamento climatico e dei suoi effetti nel 1972, quando il Massachusetts institute of technology (Mit) pubblicò il famoso rapporto «I limiti dello sviluppo». Un documento nel quale gli scienziati denunciavano come la crescita della popolazione e dell’economia mondiale – senza le adeguate misure di tutela dell’ambiente – rischiassero di portare il pianeta al collasso entro la metà del Ventunesimo secolo.
Da quel momento, c’è stato un susseguirsi sempre più frenetico di conferenze internazionali su ambiente e clima senza mai andare oltre le parole.
Si è dovuto attendere a lungo per assistere ai primi tentativi di adottare delle misure concrete per mitigare e contrastare il cambiamento climatico e i suoi effetti. E finalmente si è arrivati al 1992, quando il Summit sulla terra di Rio de Janeiro ha iniziato a cambiare l’approccio.
La conferenza brasiliana ha sancito l’entrata in vigore della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), il principale trattato internazionale sul clima.
Il documento – pur non essendo legalmente vincolante – impegnava i firmatari a ridurre le emissioni di gas serra e le interferenze umane nei confronti dell’ambiente.
Dal 1994 poi, i Paesi che avevano ratificato la Convenzione hanno iniziato a incontrarsi annualmente nella Conferenza delle parti (Cop), che ancora oggi rappresenta l’occasione per monitorare lo stato di avanzamento degli impegni presi e per adottarne di nuovi, questa volta obbligatori.
Durante la Cop3 in Giappone nel 1997, è stato concluso il Protocollo di Kyoto che stabiliva la necessità, entro il 2012, di ridurre le emissioni di gas serra del 7% rispetto ai livelli del 1990.
Nel 2015, invece, nel corso della Cop21, sono stati firmati i famosi Accordi di Parigi che fissavano la soglia limite dell’incremento della temperatura terrestre «ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali», oltre a esigere che il picco di emissioni di gas climalteranti venisse raggiunto entro il 2050.
Con il passare degli anni, la comunità internazionale ha impresso una graduale spinta verso l’adozione di politiche risolutive nei confronti del cambiamento climatico. Le strategie messe in atto dai diversi Stati, però, sono ancora ampiamente insufficienti. Infatti, la realizzazione degli obiettivi di Parigi resta lontana: secondo l’Ipcc, con gli impegni assunti finora dai firmatari, entro il 2100 la temperatura terrestre aumenterebbe comunque di 2,7°C rispetto ai livelli preindustriali.
I minerali del Sud globale
Anche se più lentamente di come richiederebbe il pianeta, il mondo si sta dirigendo verso la transizione ecologica. Un’evoluzione complessa che, per essere realizzata appieno, comporta un ripensamento dell’intero sistema economico e sociale mondiale al fine di sviluppare processi sempre più sostenibili.
Pannelli solari, computer, auto elettriche e pale eoliche sono solo alcuni dei dispositivi al centro del cambiamento. Non a caso, la loro domanda è in rapida ascesa, soprattutto in Occidente.
Produrli, però, richiede ampi giacimenti di minerali critici, concentrati in un numero abbastanza limitato di Paesi, soprattutto del Sud globale.
È così che il tantalio estratto in Congo Rd è diventato essenziale per i condensatori di computer e cellulari in tutto il mondo.
Il «Triangolo del litio» (l’area che comprende i deserti salati di Argentina, Bolivia e Cile) è sempre più cruciale nella catena di produzione globale di auto elettriche.
Il nichel indonesiano è invece centrale per migliorare qualità e durata delle batterie.
Strategici sono anche le terre rare abbondanti in Vietnam, il rame diffuso in Sud America e Africa subsahariana, il cobalto proveniente da Repubblica democratica del Congo e Zambia.
![]()
Il neocolonialismo delle risorse
Lo scenario appena descritto mostra il profondo intreccio che lega Nord e Sud globale. In particolare, come quest’ultimo e le sue risorse siano il mezzo con cui il primo tenta di esaltare il proprio impegno nel contrasto al cambiamento climatico e i risultati raggiunti in termini di transizione ecologica e decarbonizzazione.
Mostra anche, e soprattutto, la corsa all’accaparramento dei minerali del Sud globale da parte di Stati stranieri e aziende multinazionali. Un processo dai chiari connotati neocoloniali.
D’altronde, nel Sud globale, il colonialismo non è mai scomparso. Semplicemente, ha assunto una nuova veste. Il controllo che ancora oggi l’Occidente esercita su molte delle sue ex colonie non è più di natura politica, ma economica.
Fin dalle indipendenze, numerose aziende europee sono rimaste nel Sud globale, giustificandosi con la necessità di supportare il consolidamento delle nascenti economie indipendenti. In realtà, ciò ha permesso agli europei di insinuarsi a fondo nell’economia di Stati fragili, prendendone il controllo e appropriandosi di molte delle loro risorse.
Le condizioni di sfruttamento che le multinazionali si assicurano sui giacimenti sono estremamente favorevoli (ad esempio le tasse molto basse), e le modalità per ottenerle (spesso la corruzione di funzionari statali), alquanto discutibili.
Il più delle volte, le popolazioni locali non sono consultate e, anzi, sovente vengono espropriate in modo unilaterale delle proprie terre. Mentre la tutela dell’ambiente naturale e della salute delle persone è completamente assente.
Aurora Guainazzi
![]()
Contro le miniere in Europa
Giacimenti di minerali critici sono presenti anche in Occidente.
Sebbene siano in quantità minore rispetto a quelli del Sud globale, stanno assumendo una rilevanza sempre maggiore in un contesto mondiale nel quale Stati Uniti e Unione europea hanno iniziato a puntare all’autosufficienza.
![]() Sia gli Usa che l’Ue, infatti, guardano allo sviluppo di giacimenti interni e alla creazione di industrie di trasformazione proprie come a una strategia per dipendere sempre meno dalla Cina.
Sia gli Usa che l’Ue, infatti, guardano allo sviluppo di giacimenti interni e alla creazione di industrie di trasformazione proprie come a una strategia per dipendere sempre meno dalla Cina.
Pechino d’altronde controlla quasi interamente la catena di lavorazione di minerali cruciali come nichel, cobalto, litio e terre rare.
Aprire miniere in Occidente, però, è decisamente più complesso che aprirle nei paesi del Sud globale.
I tempi burocratici sono lunghi (in media, in Unione europea, sono necessari quindici anni per ottenere tutte le autorizzazioni), le regolamentazioni ambientali stringenti, le tutele da garantire ai lavoratori molto maggiori, e l’opposizione della società civile locale frequente.
Proprio quest’ultima, negli ultimi anni, ha avuto un ruolo centrale in molti Paesi europei nell’ostacolare o, addirittura, nell’impedire l’apertura di siti estrattivi.
Nella regione spagnola dell’Estremadura, cospicue riserve di litio si situano a soli due chilometri di distanza dalla città di Cáceres, sito Unesco e set del film Game of Thrones (cfr. Daniela Del Bene, Miniere «green», MC ago-sett 2021).
Fino agli anni Settanta, nell’area era attiva una miniera di stagno con effetti dannosi su ambiente e salute. Non stupisce, quindi, che l’attuale progetto, la miniera di litio di San José Valdeflórez, veda l’opposizione di politica e società civile.
«Infinity lithium», l’impresa australiana che guida le operazioni, ha promesso investimenti iniziali per 280 milioni di euro e la creazione di più di 200 posti di lavoro. L’azienda sostiene che la miniera possa produrre il litio necessario per dieci milioni di veicoli elettrici e prevede un’attività di trent’anni. Ma, nel maggio 2021, il comune di Cáceres ha approvato una mozione che ha blindato la zona dal punto di vista ambientale, oltre ad aver negato un permesso operativo alla multinazionale.
Già nella primavera del 2017 la società civile si era attivata con la nascita del gruppo di cittadini Plataforma salvemos la montaña per difendere l’ambiente naturale circostante Cáceres e impedire la creazione di una miniera con inevitabili effetti dannosi su ambiente e salute.
Dopo la conclusione degli studi di fattibilità nel 2019, era stato stabilito che l’estrazione sarebbe iniziata entro venti mesi, ma – al momento – la miniera di San José Valdeflórez non è ancora entrata in funzione.
Cáceres non è l’unico caso europeo dove la popolazione ha manifestato contro le attività estrattive. In Portogallo, le proteste dei cittadini di Montalegre stanno bloccando l’apertura di sei miniere di litio.
Scene simili si sono viste in Serbia: quando nel 2022 il governo ha tentato di dare il via libera a quella che sarebbe diventata la miniera di litio più grande d’Europa, la popolazione è insorta, costringendo le autorità a fermare il progetto (cfr. Daniela Del Bene, Il litio della Serbia. Un rio rosso sangue, MC ago-sett 2023).
Questi sono solo alcuni esempi – emblematici – di manifestazioni contro le attività estrattive nel continente europeo. In alcuni casi, le proteste hanno impedito l’avvio delle attività, in altri le stanno rallentando.
L’altra faccia della medaglia, però, è che – in un mondo dove i minerali per la transizione ecologica sono sempre più urgenti – un numero crescente di multinazionali si rivolge ai giacimenti del Sud globale. Di fatto, l’alternativa più «semplice» e da cui l’Occidente cerca di trarre il massimo guadagno al minor costo possibile.
A.G.
![]()
Multinazionali estrattive
Le concessioni minerarie. Ambiente e popolazioni impoveriti.
Interi territori devastati, a volte in zone protette con biodiversità uniche. Comunità sgomberate o avvelenate. Le enormi concessioni minerarie che molti Paesi del Sud globale offrono ad aziende transnazionali del Nord non sono quasi mai un affare per gli abitanti del posto, eppure crescono di numero ovunque.
Le grandi aziende multinazionali sono spesso le principali protagoniste della corsa ai minerali critici presenti nei paesi del Sud globale. Il più delle volte sono occidentali – Usa, Canada, Regno unito, Svizzera, Australia -, ma non mancano quelle cinesi (cfr. box pag. 38).
I loro progetti estrattivi sono enormi – sia per l’estensione del territorio coinvolto, sia per i volumi di materie prime estratte – e non si curano dei danni causati a popolazione e ambiente. L’unico obiettivo è massimizzare i profitti, soddisfacendo la galoppante domanda occidentale.
Violazioni ambientali e sociali
Corruzione, frodi e cavilli legislativi sono spesso utilizzati dalle multinazionali per aggiudicarsi vaste concessioni nei Paesi del Sud globale.
Capita che le imprese ottengano permessi di esplorazione e sfruttamento in aree protette o ad alto rischio ambientale.
È successo nelle Filippine, nell’isola di Sibuyan, soprannominata «Galapagos d’Asia», che dal 1996 è un parco naturale la cui biodiversità e bellezza sono riconosciute e apprezzate in tutto il mondo.
Lì, l’impresa Altai Philippines mining corporation, succursale locale della canadese Altai resources inc, si è aggiudicata una concessione di nichel proprio all’interno dell’area protetta con danni ambientali irreversibili per una biodiversità unica.
Le attività estrattive e di lavorazione, infatti, causano una considerevole distruzione ambientale.
Lo sversamento di rifiuti tossici nei fiumi, la dispersione di metalli pesanti nell’aria, nel suolo e nell’acqua, sono azioni che minano la biodiversità, causano malattie tra la popolazione e ne mettono a repentaglio le fonti di sussistenza.
Nel gennaio 2022, un report dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha definito la città peruviana di Cerro Pasco una delle quattro «zone di sacrificio» dell’America Latina. Il documento denunciava «un’enorme cava a cielo aperto adiacente a una comunità impoverita ed esposta a elevati livelli di metalli pesanti». Già nel 2009, l’Ong Source international aveva rilevato quantità di arsenico, mercurio e cadmio ben al di sopra dei limiti stabiliti dal governo peruviano e dagli standard internazionali. Metalli che erano presenti non solo nell’acqua e nel suolo, ma anche nel cibo e negli spazi pubblici frequentati dai bambini.
Nonostante le evidenze, però, nessuna misura concreta e realmente efficace è stata ancora presa.
Le popolazioni indigene generalmente sono le più colpite dall’avvio delle attività estrattive. In molti casi sono costrette ad allontanarsi dalle proprie terre e spesso non vengono preventivamente informate e consultate sull’apertura delle miniere. In Indonesia, ad esempio, l’impresa francocinese Weda bay nickel non ha informato il popolo seminomade degli O Hongana Manyawa dei potenziali impatti negativi dell’estrazione del minerale, né l’ha consultato prima dell’apertura della miniera nel suo territorio.
E questi sono solo alcuni degli innumerevoli esempi di devastazione ambientale e sociale causata dalle attività estrattive messe in opera in modo incontrollato da multinazionali di diversa bandiera nei paesi a basso reddito.

Foto de Roberto Candia para AMSA 2023
Nessun guadagno
Se non prendiamo in considerazione le élite politiche ed economiche, i Paesi e le popolazioni locali ottengono ben poco da questo processo di sfruttamento. Quasi tutte le ricchezze sono drenate: i contratti garantiscono alle aziende condizioni estremamente favorevoli, tali da massimizzare i profitti e ridurre all’essenziale quanto lasciato nel paese di estrazione.
Ne sono il segno le poche royalty (quote di prodotto lordo) e le basse aliquote sugli utili netti che le imprese versano agli Stati concedenti.
Nel 2021, ad esempio, l’impresa Minera Panamá, sussidiaria panamense della canadese First quantum minerals, ha pagato solo 61 milioni di dollari di royalty sulla produzione di oltre 86mila tonnellate di rame. Solo con una recente revisione degli accordi (in vigore dal 2023), il governo panamense è riuscito a innalzare le aliquote dal 2% al 12% dei profitti della miniera (quindi ora corrispondenti a circa 375 milioni di dollari).
Altre aziende invece optano per l’evasione fiscale. Dichiarano guadagni molto più bassi del reale (o addirittura perdite) per versare meno imposte di quanto dovrebbero. «War on want», un’Ong inglese per la tutela dei diritti umani, ha denunciato che tra il 2010 e il 2011 solo due delle cinque compagnie minerarie attive in Zambia avevano dichiarato guadagni positivi. Ne è risultata una perdita di entrate fiscali per tre miliardi di dollari l’anno, il 12,5% del Pil annuo del Paese.
Infine, quel poco che resta nel Sud globale, spesso finisce nelle tasche di politici corrotti, invece di essere investito in politiche di welfare e crescita economica. Non è un caso che le due aree più ricche di minerali in tutto il mondo siano anche la più diseguale – il Centro e Sud America – e la più povera – l’Africa subsahariana.

In opposizione alle miniere
Sebbene nei Paesi del Sud sia ben più difficile, rispetto all’Occidente, impedire l’apertura di siti minerari – soprattutto in contesti nei quali la corruzione è dilagante -, non mancano esempi di mobilitazione della società civile locale. Proteste che in alcuni casi hanno avuto successo, arrivando a impedire lo sfruttamento dei giacimenti o a costringere le multinazionali a risarcire le popolazioni colpite dagli impatti ambientali e sociali.
In Madagascar, il sito di Ampasindava è considerato uno dei maggiori giacimenti di terre rare fuori dalla Cina. Ma finora la mobilitazione degli abitanti dell’area e delle associazioni per la tutela dell’ambiente – preoccupati da deforestazione, dispersione di metalli pesanti e rilascio di rifiuti tossici – è stata tale da impedire l’inizio delle operazioni estrattive.
In Sudafrica, invece, dopo un lungo processo giudiziario e complessi negoziati, la Corte suprema di Johannesburg ha stabilito che i minatori locali colpiti da silicosi e tubercolosi avevano diritto a ricevere indennizzi. Un obbligo gravante su diverse aziende – African rainbow minerals, Anglo American sa, AngloGold ashanti, Gold fields, Harmony e Sibanye stillwater – tenute a compensare migliaia di lavoratori e famiglie di minatori che, tra il 1965 e il 2018, hanno manifestato queste malattie.
Aurora Guainazzi

Aziende cinesi nel Sud globale
A fianco degli investimenti occidentali, nel Sud globale sono particolarmente diffusi anche quelli cinesi. La Cina, infatti, al di là delle terre rare, non dispone di significativi giacimenti di altri minerali critici. Tuttavia, grazie allo sviluppo di accordi tra le proprie aziende e i governi di diversi Paesi, Pechino riesce a mettere le mani su ingenti risorse che poi le sue imprese trasformano.
Ugualmente dannosi a livello ambientale e sociale, i progetti estrattivi cinesi si differenziano da quelli occidentali per la retorica.
Nei confronti del Sud globale, la Cina, infatti, ha sempre enfatizzato la ricerca di una collaborazione alla pari senza l’imposizione di condizioni di natura politica ed economica.
Dopotutto, Pechino stessa si definisce parte del Sud globale e aspira alla leadership del blocco.
Le compagnie cinesi – in cambio di concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti – promettono investimenti per lo sviluppo economico e sociale degli Stati concedenti, oltre che fruttuosi legami commerciali. In realtà, i Paesi del Sud globale ricevono ben poco in proporzione ai benefici che la Cina ottiene dalle risorse di cui si appropria. Ad esempio, nella provincia congolese del Katanga, le aziende cinesi si sono aggiudicate lo sfruttamento di giacimenti di rame e cobalto. Di tutti gli investimenti infrastrutturali promessi in cambio, però, ben poco è stato realmente realizzato (cfr. MC marzo 2024).
Ma, in Paesi stremati dalla spirale del debito e dove la democrazia fatica a farsi strada, la retorica cinese su una collaborazione alla pari senza l’imposizione di condizionalità politiche ed economiche fa presa.
A.G.
![]()
Catene produttive locali nel Sud
Nell’attuale sistema economico internazionale, il Sud globale è spesso visto come semplice fornitore di materie prime, le quali vengono poi lavorate in altri contesti, soprattutto in Cina. In questo modo, però, i guadagni e le opportunità lavorative legati alla raffinazione dei minerali in loco sono ben pochi.
Proprio con l’obiettivo di accrescere le entrate statali e creare nuovi posti di lavoro, molti Paesi si stanno muovendo verso la creazione di filiere produttive locali, in grado di lavorare le risorse direttamente sul territorio di estrazione.
Dall’Africa, al Centro e Sud America, passando per il Sud Est asiatico, questa è una tendenza diffusa, sebbene con intensità e stati di avanzamento differenti a seconda delle eredità storiche e delle criticità locali (come conflitti e limiti infrastrutturali).
Nella «Copperbelt», la cintura del rame che corre tra Repubblica democratica del Congo e Zambia, si trovano considerevoli giacimenti di cobalto. Perciò, l’African finance corporation, un’istituzione finanziaria multilaterale, ha siglato un memorandum d’intesa con l’azienda zambiana Kobaloni energy.
Investimenti per 100 milioni di dollari permetteranno di costruire in Zambia la prima raffineria africana di cobalto entro il 2025.
Si tratterà di una delle pochissime strutture di questo genere al di fuori della Cina – che attualmente controlla il 75% della lavorazione del minerale -. Essa permetterà di produrre componenti essenziali per le batterie al litio.
Il fatto che a investire non sia un’azienda straniera ma un’impresa africana non deve stupire: nel continente è sempre più forte la volontà di difendere le proprie risorse dallo sfruttamento delle multinazionali per trarne maggiori guadagni.
Non a caso, gli Stati africani stanno collaborando in seno all’Unione africana per delineare una strategia unitaria per uno sfruttamento vantaggioso dei propri minerali critici.
In Sud America invece, Cile e Perù, oltre a essere i due maggiori produttori mondiali di rame, sono anche leader continentali nella sua raffinazione. Dati alla mano, però, si tratta di capacità limitate: solo l’11% del totale del rame estratto nei due Paesi viene realmente lavorato sul posto. La maggior parte è esportata e processata in altri Paesi, tra i quali spicca, ancora una volta, la Cina.
A fine 2022, un rapporto della Commissione cilena sul rame, infatti, denunciava che «il Paese dispone di fonditrici vecchie, poco competitive e costose».
Migliorare le strutture per la lavorazione permetterebbe di ottimizzare i processi e ridurre gli sprechi, accrescendo le entrate nelle casse statali, e creerebbe nuove opportunità lavorative.
Il Burkina Faso invece sta guardando ancora più in là. La giunta militare al potere a Ouagadougou ha infatti annunciato la costruzione, alla periferia della capitale, del primo impianto nel Paese per il recupero e il riciclo di residui. In questo modo, i metalli, contenuti negli scarti derivanti dall’estrazione dell’oro, saranno lavorati internamente e non mandati all’estero.
Anche il riciclo sta diventando una componente importante della filiera dei minerali critici: dato che l’attuale trend di crescita dell’estrazione non sarà in grado di soddisfare l’incremento – ancora maggiore – della domanda, riciclare gli scarti o le componenti minerarie di dispositivi non più funzionanti è diventata una strada attraente.
A.G.

Sopravvivere da minatori
L’estrazione artigianale dei minerali critici.
In molti Paesi del Sud globale l’estrazione artigianale delle materie prime utili alla transizione ecologica è molto diffusa, con pesanti conseguenze ambientali e sociali. Nonostante i rischi elevati e i frequenti incidenti mortali, sono milioni le persone che scavano ed estraggono. Tra loro, anche molti bambini.
Al pari dei progetti delle multinazionali, anche l’estrazione artigianale è in continua espansione. Il prezzo abbastanza elevato dei minerali, e la loro richiesta consistente, fanno sì che molti abitanti dei paesi poveri decidano di lavorare nel settore minerario. Per quanto pericoloso e poco remunerativo sia, spesso però l’estrazione artigianale è il modo più semplice per assicurarsi la sopravvivenza quotidiana.
Nel 2020, in tutto il mondo, secondo la Banca mondiale, c’erano circa 45 milioni di minatori artigianali (oltre ad altri 120 milioni di persone che dipendevano indirettamente dal settore).
Impatti sociali e ambientali
I siti di estrazione informale, dove i minatori lavorano senza permessi governativi, sono sempre più diffusi. Così come aumentano le miniere illegali, spesso aperte sulle concessioni di grandi aziende che, per svariati motivi come insicurezza o mancanza di infrastrutture, sono incapaci di sfruttare il giacimento.
I minatori artigianali non si servono di particolari tecnologie o macchinari, non dispongono di protezioni e non godono di tutele.
Racconta Viateur, cooperante congolese e analista della regione dei Grandi Laghi, area dove l’estrazione artigianale è particolarmente diffusa: «Nella miniera di Rubaya nel Nord Kivu, almeno cento minatori sono morti asfissiati dopo che una frana li aveva bloccati a una profondità di cento metri.
Le frane sono frequenti a causa dei dispositivi di sicurezza di cattiva qualità: la maggior parte delle gallerie sono sorrette da pali di legno che non sono in grado di sostenere il peso del terreno e dell’acqua nei periodi piovosi». E ancora: «La contaminazione delle acque sotterranee causa malattie legate ai metalli pesanti come disturbi del sangue e tumori». Ma anche «le malattie croniche – come polmonite, dolori articolari e mal di testa – sono diffuse: i minatori sono esposti all’assorbimento di particelle e gas. Anche i bambini sono colpiti perché partecipano allo smistamento dei minerali in superficie».
Nelle aree di estrazione artigianale, infatti, il lavoro minorile è molto diffuso: nelle sole miniere congolesi di coltan nel 2021 lavoravano almeno 40mila bambini e adolescenti. Oltre che nello smistamento dei minerali, i bambini sono impiegati anche nell’estrazione nelle gallerie più profonde e strette, dove gli adulti non riescono ad andare.
Man mano che l’attività estrattiva in un territorio si consolida, «la produzione agricola diventa sempre più difficile a causa dei residui minerari riportati in superficie che inibiscono la crescita delle piante. Questo provoca fame e malnutrizione».
Parole che valgono per la Repubblica democratica del Congo così come per tanti altri contesti dove l’estrazione artigianale – così come quella industriale delle grandi multinazionali – porta con sé una serie di conseguenze sociali e ambientali notevoli: dalla devastazione dell’ambiente, alla diffusione di malattie tra la popolazione, ai frequentissimi incidenti sul lavoro.

Per la sopravvivenza quotidiana
L’estrazione artigianale è trainata dal mercato internazionale e dalla crescente domanda di minerali critici per la produzione dei dispositivi al centro della transizione ecologica.
L’obiettivo prioritario per le popolazioni che vivono in condizioni di povertà e diseguaglianza è quello di assicurarsi la sopravvivenza quotidiana.
In mancanza di fonti di reddito alternative, soprattutto in zone remote e lontane dai centri urbani, è facile che molti decidano di dedicarsi all’estrazione mineraria. «In queste aree – ricorda Viateur – le opportunità di studio e ascesa individuale e collettiva sono limitate per l’assenza di scuole di qualità e centri di formazione al lavoro». E l’attività mineraria, particolarmente redditizia in questa fase storica, diventa una scelta facile: «A differenza dei prodotti agricoli e forestali, le risorse minerarie – come oro, diamanti e coltan – hanno un prezzo di mercato molto elevato e il trasporto su grandi distanze è facile».
Aurora Guainazzi

Sudafrica. Un piano difficile da realizzare
Nel corso della Cop26 a Glasgow, il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha presentato il Just energy transition investment plan (Jet-Ip), il piano quinquennale per la transizione ecologica del Sudafrica. Stando ai dati dell’Agenzia internazionale per l’energia, infatti, nel 2020 solo il 7% dell’energia sudafricana proveniva da fonti rinnovabili, mentre l’85% proveniva da quattordici vecchie centrali a carbone, soggette a frequenti problemi di manutenzione e blackout. Il Paese era responsabile di un terzo delle emissioni totali dell’Africa subsahariana.
Il Jet-Ip, dunque, prevede interventi per decarbonizzare economia e società attraverso lo sviluppo di una mobilità sostenibile e l’incremento delle energie verdi. Smantellare le centrali a carbone è un punto centrale: Eskom, l’azienda energetica statale, prevede che metà degli impianti cesserà di funzionare entro il 2034. Al contempo, verrà espansa e rafforzata la produzione di energie rinnovabili e idrogeno verde (nella cui esportazione il Sudafrica vuole diventare leader mondiale grazie a investimenti nelle infrastrutture portuali).
Realizzare questo piano e – più in generale – la transizione ecologica in Sudafrica, però, non vuol dire solo introdurre e utilizzare nuove tecnologie, ma anche un cambiamento profondo del sistema economico e sociale.
Il Paese è il settimo produttore mondiale di carbone e il quarto esportatore. Oltre 120mila persone lavorano nella sua estrazione o nella gestione delle centrali. Lo smantellamento degli impianti, quindi, avrà effetti sociali poco considerati da un piano che prevede semplicemente la riallocazione dei lavoratori in altri settori. Un problema non da poco in un Paese dove la disoccupazione – pari al 32%, la più elevata dell’Africa subsahariana – è da decenni un problema strutturale.
Infine, c’è il nodo dei costi, una questione emersa fin da subito a Glasgow. Il Jet-Ip prevede investimenti per 84 miliardi di dollari su cinque anni.
Durante la Cop26, il Sudafrica si è accordato con Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione europea per 8,5 miliardi di dollari di finanziamenti. Ma perché diventassero realtà ci è voluto un anno di negoziati.
Al momento, manca ancora il 44% dei fondi. Il governo auspica di ottenerli grazie a finanziamenti di Stati stranieri, banche di sviluppo multilaterali, settore privato e filantropi. Però, la maggior parte delle risorse sono fornite sotto forma di prestiti, su cui gravano considerevoli tassi di interesse, piuttosto che in termini di sovvenzioni.
Un peso notevole per le finanze di un Paese già in profonda difficoltà economica.
A.G.

Chi non può resta indietro
La transizione ecologica dal punto di vista del Sud
I maggiori responsabili del cambiamento climatico sono i Paesi del Nord, mentre quelli del Sud ne subiscono gli effetti peggiori. Il principio secondo cui «paga chi inquina», però, non è applicato, e a decidere tempi, costi e fattibilità della transizione nel Sud rimane l’Occidente.
Nonostante il cambiamento climatico coinvolga tutto il mondo e – anzi – i suoi effetti peggiori si manifestino nel Sud globale, è l’Occidente a guidare la transizione ecologica. Sono i suoi decisori politici a determinare tempi, costi e fattibilità di questo processo per tutta la Terra. Chi riesce, si adegua. Chi non ce la fa è lasciato indietro e ne paga le conseguenze.
Eredità storiche
Storicamente, la responsabilità maggiore del cambiamento climatico – in termini di emissioni di gas serra – grava sulle spalle del mondo occidentale. Il carbone prima e il petrolio poi, infatti, sono stati i cardini dell’industrializzazione e della crescita economica del Nord globale.
Piano piano poi, si sono aggiunti alcuni Paesi del Sud globale. Ma non prima degli anni Novanta. Per circa 150 anni, quindi, è stato solo l’Occidente a produrre i gas climalteranti. Oggi, questa responsabilità è condivisa con alcuni Paesi come Cina e India, ma molti altri – di fatto la maggioranza – inquinano ancora ben poco. Mentre subiscono gli effetti peggiori del cambiamento climatico.
Proprio in virtù di questa differenza storica nelle responsabilità, a Rio de Janeiro nel 1992 è stato formulato il principio delle «responsabilità comuni ma differenziate». In poche parole: chi inquina di più, paga di più. Il principio si radicava nella consapevolezza che lottare contro il cambiamento climatico era un obiettivo comune a tutta la comunità internazionale, ma riconosceva anche che era necessario differenziare il peso sui diversi Paesi a seconda del loro contributo storico all’inquinamento planetario.
Infatti, durante la Cop3 di Kyoto del 1997, sono stati stabiliti obblighi differenti nella riduzione delle emissioni a seconda che i Paesi fossero classificati come «sviluppati» o «in via di sviluppo».
A Parigi nel 2015, però, questa distinzione è venuta meno e sono state introdotte regole comuni per tutti. I contributi, determinati a livello nazionale (piani quinquennali nei quali i paesi firmatari degli accordi delineano le proprie strategie di lungo periodo in termini di transizione ecologica e decarbonizzazione), sono diventati il cardine delle politiche di lotta al cambiamento climatico.
Anche i Paesi del Sud globale si sono impegnati a presentare e aggiornare questi documenti. Ma, data l’assenza di fondi e mezzi, non deve stupire se tra ciò che questi Paesi scrivono nei piani e ciò che sono realmente in grado di realizzare c’è un abisso. Ancor di più, se si considera che a Parigi era stato stabilito che il Nord del mondo dovesse fornire risorse tecnologiche e finanziarie per sostenere la transizione del Sud. Un onere che finora, però, è stato ampiamente disatteso.
![]()
Questione di soldi e approccio
Nel tentativo di dare seguito a questo obbligo, negli anni, l’Occidente ha provato a introdurre strumenti per sostenere i piani del Sud globale, ma i fondi destinati finora, oltre a essere molto in ritardo rispetto a quanto deciso, sono insufficienti.
Alla Cop21 di Parigi, i Paesi più ricchi avevano promesso di destinare, a partire dal 2020, 100 miliardi di dollari l’anno in aiuti climatici al Sud.
Solo nel 2022 poi, alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, è stato individuato uno strumento per canalizzare questo genere di risorse: il Fondo perdite e danni.
Un anno dopo, il meccanismo non era ancora operativo. Si è dovuta attendere la Cop28 di Dubai per raggiungere l’accordo su un finanziamento iniziale di 700 milioni di dollari entro gennaio 2024: lo 0,2% di tutte le risorse necessarie.
Il fondo è una sorta di palliativo che tenta di ammortizzare i danni, di mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Ciò che, ancora oggi, manca sono risorse adeguate per la transizione ecologica del Sud globale. Esso, infatti, con l’esclusione della Cina, secondo il report Finance for climate action, necessiterebbe di due trilioni di dollari l’anno entro il 2030 per rispettare gli obiettivi di Parigi.
Oltre alle risorse contenute in questi fondi, molti paesi del Sud devono ricorrere ai prestiti stanziati dalle istituzioni finanziarie internazionali (tutte a guida occidentale) o da Paesi stranieri. Finanziamenti spesso molto onerosi: raramente i tassi di interesse sono inferiori al 3%, e in molti casi raggiungono picchi del 9%. Con il risultato di creare una spirale del debito senza fine.
Dunque, a determinare tempi, costi e fattibilità della transizione ecologica nel Sud globale è sempre l’Occidente. Di fatto, un’altra delle sue tante manifestazioni neocoloniali.
L’attivismo
Anche sul piano dell’attivismo, la transizione ecologica è spesso e volentieri presentata come un processo a guida occidentale.
Eppure, nel Sud globale fioriscono movimenti per la difesa dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico.
In occasione del Forum economico di Davos del 2020, l’agenzia di stampa statunitense «Associated press» ha tagliato l’attivista ugandese Vanessa Nakate da una foto che la raffigurava con le colleghe europee Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Isabelle Axelsson e Lukina Tille. Un anno dopo, alla Cop26 di Glasgow, la cosa si è ripetuta. Ancora una volta, Vanessa Nakate è stata eliminata da un’immagine che così mostrava solo volti bianchi.
La Cop26 è stata considerata la più escludente di sempre. Complici la pandemia da Covid-19 e l’iniqua distribuzione di vaccini nel mondo, infatti, diversi attivisti e rappresentanti della società civile del Sud globale non hanno potuto raggiungere la Scozia per partecipare ai lavori della conferenza e far sentire la propria voce.
Tra le comunità indigene colpite dagli effetti del cambiamento climatico e dell’estrazione mineraria, sono sempre più diffusi movimenti di protesta nei confronti dell’Occidente e delle sue multinazionali. Ma l’attenzione mediatica che ricevono spesso è molto limitata. Così come poca visibilità viene data alle richieste dei leader dei piccoli Paesi insulari del Pacifico, una delle aree del mondo più a rischio a causa dell’innalzamento del livello dei mari.
Dunque, rendere la transizione ecologica realmente accessibile a tutti, oltre che ascoltare le voci provenienti dal Sud globale, è fondamentale per costruire un futuro sostenibile.
Aurora Guainazzi

Hanno firmato il dossier:
Aurora Guainazzi. Si occupa di Africa subsahariana sia nell’ambito della cooperazione internazionale che dell’informazione. La sua attenzione si rivolge in particolare alle dinamiche economiche, sociali e politiche della regione africana dei Grandi Laghi.
A cura di Luca Lorusso, redattore MC.

Foto de Roberto Candia para AMSA 2023