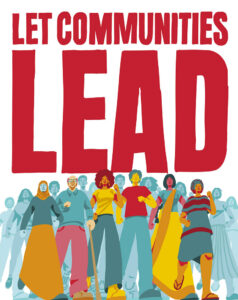Mondo. Rimesse dei migranti, un ponte tra Paesi
Nel 2023 il denaro mandato dai migranti ai loro paesi di origine nel mondo ha raggiunto la cifra record di 822 miliardi di dollari. Un aiuto importante per le famiglie. Un ponte economico e sociale tra i paesi.
Ogni anno Carmen manda tra i due e i tremila euro a sua madre a Lima. Da poco ha superato il concorso all’Asl città di Torino e ha iniziato a lavorare come Oss in ospedale, lasciando il precedente lavoro in una casa di riposo privata. Ha potuto anche fare un mutuo per acquistare il suo piccolo alloggio nella periferia Nord della città.
I suoi soldi aiutano la madre e due nipoti, figli di una sorella rimasta vedova a causa di un incidente sul lavoro del marito. Durante la pandemia ha mandato qualche centinaio di euro anche a suo fratello, in difficoltà a San Francisco, negli Usa.
Le rimesse, ovvero il denaro inviato dai migranti ai loro paesi di origine, sono un fenomeno economico e sociale cruciale, un flusso di risorse che collega il lavoro di milioni di persone migrate con lo sviluppo e il sostentamento delle loro famiglie rimaste in patria. Hanno un impatto significativo sia nei paesi di destinazione che in quelli di origine.
L’Italia, con la sua storica tradizione migratoria e un crescente numero di lavoratori stranieri, è uno dei principali paesi europei per volume di rimesse.
I dati: 822 miliardi di $
Carmen è una dei circa 200 milioni di migranti che nel mondo mandano denaro ai territori di provenienza. La Banca mondiale stima che nel 2023 le rimesse a livello globale siano ammontate a 822 miliardi di dollari (circa un terzo del Pil italiano).
Il paese che ha ricevuto la cifra più alta è stata l’India, con una cifra di 119,5 miliardi di dollari. A seguire, il Messico (66 miliardi), le Filippine (39), la Francia (36), la Cina (29). L’Italia è al 17° posto con 12,1 miliardi di rimesse ricevute da italiani all’estero.
Non stupisce che anche paesi ad alto reddito come Francia, Italia, o Germania (all’ottavo posto con 21 miliardi) ricevano grandi volumi di rimesse. La mobilità dei lavoratori europei che espatriano è molto alta e sotto gli occhi di tutti.
Tra i paesi dai quali escono i volumi maggiori di rimesse, troviamo al primo posto gli Usa, con 93 miliardi. A seguire, Arabia saudita (38), Svizzera (37), Germania (22), Cina (20). La Francia è al sesto posto con 19 miliardi di dollari, l’Italia all’undicesimo con 12,2 miliardi.
Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio nazionale sull’inclusione finanziaria dei migranti (Onifm), l’Asia si conferma nel 2024 il principale continente destinatario delle rimesse dal nostro Paese: il 40% dei flussi sono diretti verso Bangladesh, Filippine, India, Pakistan e Sri Lanka.
Interessanti variazioni sono state registrate rispetto al 2023, con incrementi significativi per paesi come Bangladesh (+17,4%) e Perù (+11%), mentre si osservano cali per altre nazioni come Pakistan (-9,6%) e Romania (-13,3%). Queste dinamiche riflettono non solo i cambiamenti demografici e migratori, ma anche l’evoluzione dei sistemi finanziari e delle politiche dei paesi di destinazione.
I costi delle rimesse per i migranti
Le rimesse rappresentano spesso una parte considerevole del reddito guadagnato dai migranti. Sono il frutto di sacrifici personali, rinunce a consumi o investimenti.
Su questa situazione già difficile, pesa anche il costo per l’invio del denaro. Nonostante gli sforzi globali per ridurlo, infatti, in Italia, secondo l’Onifm, per l’invio di 150 euro a dicembre 2024 una persona doveva pagare in media il 4,7%, con differenze significative a seconda dei paesi destinatari. Per mandare la stessa cifra in Senegal, ad esempio, il costo era del 2,6%, in Romania 3,89%, in Cina 4,89%, in Ghana 8,33%, in Brasile 9,40%.
Le piattaforme digitali sarebbero più economiche rispetto ai canali tradizionali, ma richiedono una maggiore alfabetizzazione finanziaria e digitale, e sono quindi meno usate.
L’osservatorio per l’inclusione finanziaria dei migranti, nel suo report, sottolinea che ridurre i costi di invio è una priorità sancita anche dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che mira a portarli sotto il 3%.
L’Italia ha già intrapreso iniziative, come il portale «mandasoldiacasa», per aumentare la trasparenza e promuovere la concorrenza tra gli operatori. Tuttavia, il vero potenziale risiede nello sviluppo e nella diffusione di canali digitali accessibili e nell’educazione finanziaria sia nei paesi di origine che di destinazione.
Effetti nei paesi di origine
Per i paesi destinatari, le rimesse sono una fonte essenziale di sostentamento e sviluppo. Questi fondi contribuiscono a migliorare le condizioni di vita, finanziare l’educazione, l’accesso alla salute e promuovere iniziative imprenditoriali.
Tuttavia, vi sono anche aspetti negativi: ad esempio il rischio di creare una dipendenza eccessiva dalle rimesse, cosa che può limitare lo sviluppo di economie autosufficienti. Inoltre, le variazioni dei flussi che da un anno a un altro possono verificarsi, rischiano di portare conseguenze profonde su comunità già vulnerabili.
Ponti tra comunità
Le rimesse non sono semplicemente trasferimenti di denaro, ma ponti economici e sociali che uniscono famiglie e comunità. Supportare i migranti per il loro invio sicuro ed economico significa non solo migliorare la loro qualità di vita, ma anche contribuire allo sviluppo sostenibile globale.
Luca Lorusso