Il 7 giugno 2023, in piazza San Pietro a Roma, all’udienza di papa Francesco sono presenti i membri dei Capitoli generali dei Missionari e delle Missionarie della Consolata. In quel giorno sono esposte davanti al Papa e a tutti i pellegrini le reliquie di santa Teresa di Gesù Bambino. E papa Francesco la presenta come modello di missionarietà a tutta la Chiesa. Lei che in missione non ci era mai stata, – ha sottolineato il Papa – è stata proclamata patrona delle missioni. Perché?
Risponde il Papa stesso: «Nel suo “diario” Teresa racconta che essere missionaria era il suo desiderio e che voleva esserlo non solo per qualche anno, ma per tutta la vita, anzi fino alla fine del mondo. Teresa fu “sorella spirituale” di diversi missionari: dal monastero li accompagnava con le sue lettere, con la preghiera e offrendo per loro continui sacrifici. Senza apparire, intercedeva per le missioni, come un motore che, nascosto, dà a un veicolo la forza per andare avanti…».
«I missionari, infatti – aggiunge papa Francesco -, di cui Teresa è patrona, non sono solo quelli che fanno tanta strada, imparano lingue nuove, fanno opere di bene e sono bravi ad annunciare; no, missionario è anche chiunque vive, dove si trova, come strumento dell’amore di Dio; è chi fa di tutto perché, attraverso la sua testimonianza, la sua preghiera, la sua intercessione, Gesù passi».
In questa felice circostanza i Missionari e le Missionarie della Consolata presenti all’udienza certamente si sono ricordati dell’insegnamento del loro fondatore che in varie occasioni proponeva la Santa di Lisieux come modello di vita per la loro vocazione missionaria. Ancora prima della beatificazione di Teresa avvenuta il 29 aprile 1923, l’Allamano volle indicarla come «protettrice dell’anno» per i missionari e le missionarie. Di lei amava mettere in evidenza che non aveva fatto «nulla di grande ma tutto piccolo» e che «si era fatta santa nelle piccole cose con volontà di ferro».
L’anno seguente, Giuseppe Allamano volle che i Missionari e le Missionarie celebrassero un solenne triduo di preghiera e di riflessione per ricordare la beatificazione della Carmelitana di Lisieux e prepararsi alla sua canonizzazione.
Il timbro spirituale e missionario della Santa di Lisieux, papa Francesco lo propone anche oggi a tutta la Chiesa: non si può essere cristiani autentici senza vibrare di zelo per l’annuncio di Cristo Gesù a tutti, con la preghiera, nella valorizzazione degli impegni quotidiani, accogliendo come moneta preziosa le croci che non mancano mai nella vita di ogni persona.
padre Piero Trabucco
Spiritualità al femminile
Formato dalla mamma, Marianna Cafasso, e dalla maestra, Benedetta Savio, donne di fede solida e squisita carità, Giuseppe Allamano ha trasfuso nelle fondazioni dei Missionari e delle Missionarie della Consolata una spiritualità impregnata delle caratteristiche e dei valori di cui è ricca la donna.
Il volto della spiritualità
La spiritualità femminile è molto diversa dalla spiritualità femminista. Essa si riferisce al volto della spiritualità divina che si relaziona con il corpo, con la natura e con i cicli della creazione. Il concetto di spiritualità femminile non riguarda il genere, ma piuttosto l’energia spirituale creativa e vivificante che dà forma a ciò che ci interessa e in cui mettiamo la nostra energia.
Marianna Cafasso
 La spiritualità femminile di Giuseppe Allamano cresceva in lui come lui cresceva in sua madre; in qualche modo è parte di una esperienza vissuta a partire dalla sua infanzia. Parlando della spiritualità femminile dell’Allamano, due figure principali vengono in evidenza: sua madre Maria Anna Cafasso e la sua maestra Benedetta Savio.
La spiritualità femminile di Giuseppe Allamano cresceva in lui come lui cresceva in sua madre; in qualche modo è parte di una esperienza vissuta a partire dalla sua infanzia. Parlando della spiritualità femminile dell’Allamano, due figure principali vengono in evidenza: sua madre Maria Anna Cafasso e la sua maestra Benedetta Savio.
Sappiamo che il padre dell’Allamano morì quan-do lui aveva meno di tre anni. Marianna si trovò quindi vedova, con cinque figli piccoli e affrontò la situazione con la risolutezza caratteristica dei tempi facendosi carico del lavoro, come racconta l’Allamano stesso parlando di lei: «Con il nostro modesto patrimonio, riuscì a mandare a scuola tre di noi, e ancora aumentò i nostri beni di circa 1.200 lire (ca. 6mila €) e poi non si dimenticava dei bisogni degli altri, poveri del luogo altrimenti trascurati, e interveniva con pronta efficienza».
La nipote Pia Clotilde ha detto: «Lei lavorava molto, e faceva lavorare molto gli altri. Aveva abbastanza roba per vestire un ballo (espressione tipicamente piemontese, nda) e così quando qualche povera donna aveva un figlio, preparava per lei gran parte del corredino. I poveri e i malati li aiutava nei loro molti bisogni».
Benedetta Savio
 La maestra elementare di Giuseppe Allamano divideva il suo tempo tra i bambini dell’asilo, la sua famiglia e una intensa vita di pietà. Le testimonianze del suo gioioso fervore nella preghiera, anche in età avanzata e nella malattia, hanno molto in comune con quelle che descrivono esempi più famosi di santità.
La maestra elementare di Giuseppe Allamano divideva il suo tempo tra i bambini dell’asilo, la sua famiglia e una intensa vita di pietà. Le testimonianze del suo gioioso fervore nella preghiera, anche in età avanzata e nella malattia, hanno molto in comune con quelle che descrivono esempi più famosi di santità.
L’Allamano è stato molto influenzato da queste due figure femminili: la loro tenerezza, la loro generosità, la loro laboriosità e santità. Tutto ciò ha segnato l’inizio della sua spiritualità femminile in cui la donna ha uno spazio centrale non solo nella sua vita, ma nella vita della Chiesa e dell’intera società. Lo spirito di duro lavoro, la generosità e la precisione che l’Allamano aveva li vediamo perfettamente presenti in tutta la sua vita e con essi affrontava le sfide di ogni giorno.
La trasmissione dei valori materni
Nei suoi scritti spirituali, l’Allamano desidera tutte queste virtù per i suoi missionari e tra queste la generosità, il lavoro duro, lo spirito di preghiera e la carità verso Dio e verso il prossimo: «Nostro Signore vuole la generosità», «Chi non si adatta ai lavori manuali non ha lo spirito missionario»; «Non bisogna aver paura di sporcarsi le mani»; «Dovremmo essere felici di morire nel campo del nostro lavoro». Secondo lo stile che era proprio di sua madre, inviava frequenti aiuti ai poveri.
Nei suoi scritti, inoltre, vediamo un uso frequente di espressioni materne e femminili. La prima casa dei missionari è chiamata, ad esempio, la Casa Madre, «di conseguenza, amate questa casa come una vera madre, essa vi ha accolto tra le sue braccia e vi nutre e vi prepara all’apostolato». Paragona, quindi, la famiglia religiosa da lui fondata a una madre affettuosa e tenera, la cui attenzione è rivolta ai suoi figli: «Questa casa è la tua Gerusalemme»; «Questa casa è stata costruita per la tua formazione»; «In questa casa, Dio fornisce molte grazie solo per te, per la tua santificazione, grazie che non dà ad altri fuori di questa casa».
La madre dei missionari
L’apice della spiritualità femminile dell’Allamano la troviamo in tre aspetti principali: l’intitolazione dell’Istituto alla santissima Madre Consolata, il coinvolgimento di molte donne nella sua opera missionaria di evangelizzazione e la fondazione delle Suore missionarie della Consolata. Come molti altri fondatori, l’Allamano avrebbe potuto scegliere un titolo diverso per le sue comunità missionarie e invece decise di intitolare i suoi Istituti alla Madonna che poi chiama «fondatrice», la Consolata, sottolineando così anche il ruolo che lei ebbe nella storia della Chiesa e della salvezza dell’umanità. Riteneva che Maria fosse davvero una madre per noi e che noi fossimo cari figli per lei.
Nella terza spedizione, arrivata il 13 maggio 1903, ci fu una novità inaspettata: insieme ai sei missionari partivano anche otto suore del Cottolengo, le prime donne chiamate all’opera delle missioni della Consolata. Seguirono poi le Missionarie della Consolata che l’Allamano fondò nel 1910 dietro espresso invito del papa Pio X «È il papa Pio X che vi ha volute, è lui che mi ha dato la vocazione di fare delle missionarie», e queste missionarie le chiamava giocosamente «papali». Papa Francesco, in occasione del tredicesimo Capitolo generale le ha giustamente chiamate il «ramo femminile dell’Istituto».
Il ruolo della donna nell’evangelizzazione
La spiritualità femminile dell’Allamano riunisce i due rami dell’Istituto, i Missionari e le Missionarie della Consolata, come una sola famiglia, dedicata al servizio della Chiesa e di tutto il genere umano con la fiamma ardente della carità verso Dio e il prossimo. Questa spiritualità riconosce il ruolo della donna nella missione evangelizzatrice della Chiesa, nella società e nella famiglia.
Rafforza anche il nostro impegno a promuovere la dignità e il ruolo della donna nella società; ce lo ha ricordato anche papa Francesco durante il tredicesimo Capitolo generale: «Un’attenzione speciale è data all’impegno di promuovere la dignità delle donne e i valori della famiglia» e permette di apprezzare il valore delle donne consacrate che, sull’esempio di Maria, si aprono con ubbidienza e fedeltà al dono dell’amore di Dio.
padre Charles Orero
Tenerezza paterna di Giuseppe Allamano
Un giovane sacerdote missionario e un laico missionario della Consolata, in occasione della festa del beato Allamano (16 febbraio) hanno condiviso un aspetto peculiare della personalità del padre fondatore: la sua tenerezza paterna.
Testimonianza di padre Piero Demaria
 L’Allamano aveva a cuore il bene dei suoi figli e figlie. Due episodi mostrano la sua tenerezza paterna verso di loro.
L’Allamano aveva a cuore il bene dei suoi figli e figlie. Due episodi mostrano la sua tenerezza paterna verso di loro.
Il primo si riferisce a fratel Benedetto Falda, partito col secondo gruppo di missionari per il Kenya nel 1903. Era un tipo molto attivo e creativo e, trovandosi nella missione di Tuthu, attraversava un momento di tristezza e nostalgia.
L’Allamano scrivendogli non lo ha esortato a farsi coraggio e a darsi da fare, ma ha pensato a come aiutarlo per farlo star meglio ed essere contento. Si è ricordato che fratel Benedetto suonava il mandolino, lo faceva nelle feste e anche nelle balere e allora ha cercato per tutta Torino un mandolino e glielo ha fatto spedire con una delle navi che portavano aiuti ai missionari in Kenya, scrivendogli: «Prendi questo mandolino, suona e canta e starai meglio».
L’Allamano aveva veramente a cuore che i suoi missionari e missionarie stessero bene e fossero contenti del loro lavoro. Prima ancora dell’efficenza era interessato alla gioia delle persone.
Un altro episodio riguarda una suora che stava male: il fondatore era andato a trovarla e le aveva chiesto che cosa le avrebbe fatto piacere. La suora gli aveva risposto che avrebbe mangiato volentieri un grappolo d’uva. Non era ancora la stagione, ma l’Allamano non le ha detto che non ce n’era. Ha cercato invece l’uva per tutta la città e, trovatala, l’ha portata alla suora soddisfacendo il suo desiderio.
I due episodi mostrano che, più che il grappolo o il mandolino in sé, ciò che ha fatto stare meglio queste due persone è stato vedere come il fondatore le avesse a cuore, spendesse il suo tempo per loro, appunto, come farebbe un padre pieno di tenerezza per i suoi figli.
Testimonianza di Mauro Brucalassi missionario laico della Consolata
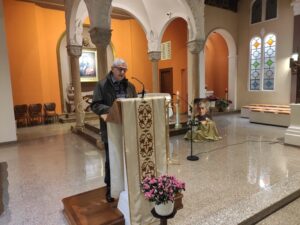 L’incontro con l’Allamano ha in un certo senso orientato la mia vita. Cosa c’entra quel pretino umile e un po’ malaticcio con la mia vita? C’è un prima e c’è un dopo questo incontro. Un prima, quando le vicissitudini della vita (positive e negative) le consideravo dovute al caso, alle circostanze, tutt’al più al destino; e c’è un dopo, quando tutto è dovuto a un disegno che Dio ha per ognuno di noi al quale difficilmente si può sfuggire, ecco il messaggio.
L’incontro con l’Allamano ha in un certo senso orientato la mia vita. Cosa c’entra quel pretino umile e un po’ malaticcio con la mia vita? C’è un prima e c’è un dopo questo incontro. Un prima, quando le vicissitudini della vita (positive e negative) le consideravo dovute al caso, alle circostanze, tutt’al più al destino; e c’è un dopo, quando tutto è dovuto a un disegno che Dio ha per ognuno di noi al quale difficilmente si può sfuggire, ecco il messaggio.
Ho conosciuto l’Allamano 24 anni fa facendo parte del nascente gruppo Lmc (Laici missionari della Consolata) di Grugliasco guidato dalle suore della Consolata che hanno voluto condividere il carisma di consolazione anche con persone non consacrate. Confesso che mi ci sono voluti mesi di formazione per aprirmi a questa nuova realtà.
Nel partecipare a questi incontri, oltre agli insegnamenti sul carisma che ci venivano forniti, ho avuto occasione di leggere alcuni libri sul beato Allamano scritti da padri e da suore della Consolata. Alcuni di loro l’avevano conosciuto personalmente e le loro memorie mi hanno appassionato. I loro scritti, infatti, non si limitavano a descrivere la vita, le azioni, i suggerimenti del fondatore ma c’era qualcosa in più, si evidenziava un affetto filiale nei suoi confronti.
Inoltre, ho avuto modo di leggere alcune lettere che l’Allamano scriveva ai suoi «figli e figlie» in missione e devo dire che erano, e restano, messaggi colmi di affetto, di tenerezza e di amore profondo. Anche quando rimproverava coloro che avevano commesso qualche errore, lo faceva sempre con delicatezza senza mai eccedere nell’ammonire.
Questo modo di agire mi ha colpito in modo significativo, ho trovato nell’Allamano un’umanità straordinaria, un uomo concreto con una devozione smisurata nei confronti della Vergine Consolata.
Era un uomo che non dava risposte preconfezionate come solitamente si sentono dare, ma ciò che diceva proveniva dal cuore. È stato un vero testimone del Vangelo.
I suoi insegnamenti potevano, e possono sembrare difficili da mettere in atto, basti pensare alla frase: «Prima santi e poi missionari», con quel «Essere santi» che sembra di difficile attuazione. Ma subito dopo spiegava in che modo attuare il concetto: «Fare lo straordinario nell’ordinario», in altre parole, fare quello che si deve fare giornalmente nel migliore dei modi possibile.
Come laico missionario dalla Consolata non mi prefiggo di andare in missione ad gentes, tuttavia sono impegnato nel volontariato prestando servizio nella mia parrocchia, ma soprattutto nel Centro di ascolto «Pier Giorgio Frassati» di Collegno e Grugliasco dove ho modo di incontrare persone in difficoltà, sole, giovani e anziani che chiedono aiuto, ed è qui dove posso mettere in atto, con i miei limiti e le mie fragilità, gli insegnamenti dell’Allamano. Lui diceva che: «Non tutti possono andare alle missioni, per svariati motivi, ma tutti siamo apostoli nelle nostre case, nei nostri paesi. Tutti siamo chiamati e dobbiamo essere apostoli e, ciascuno nella sua sfera di azione, far conoscere e amare Gesù»: questo è ciò che mi propongo di fare.
a cura di Sergio Frassetto
![]()