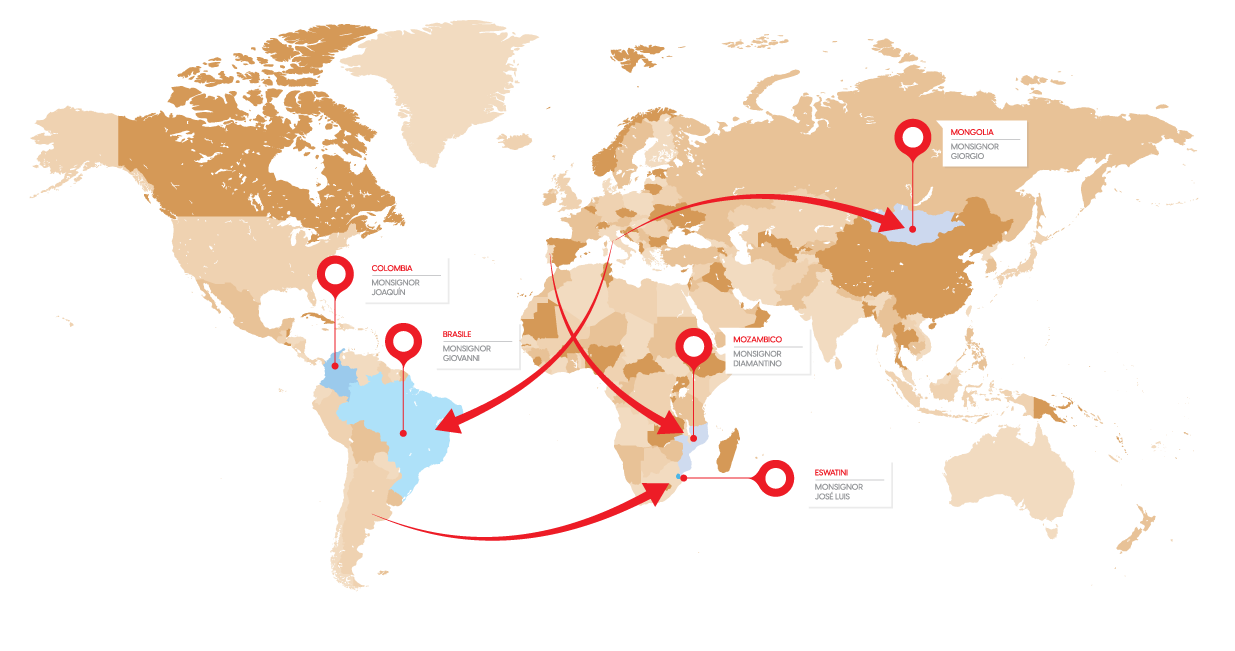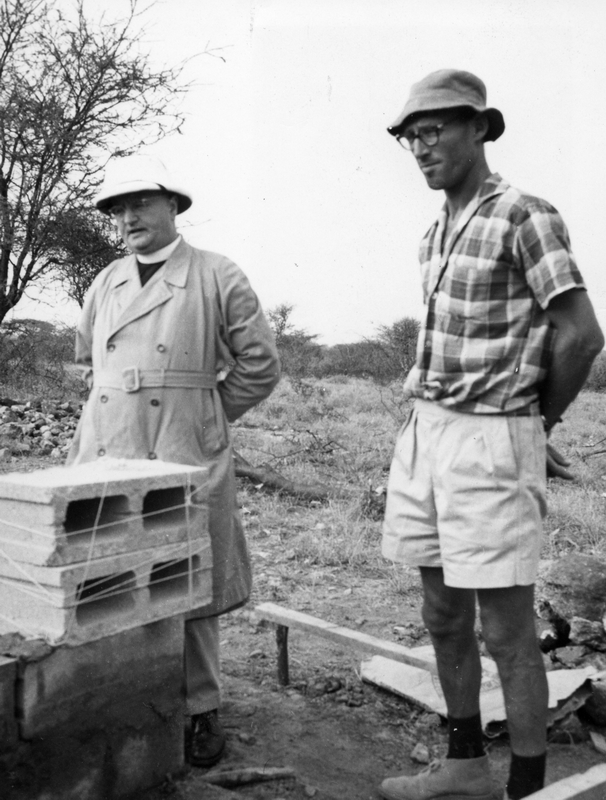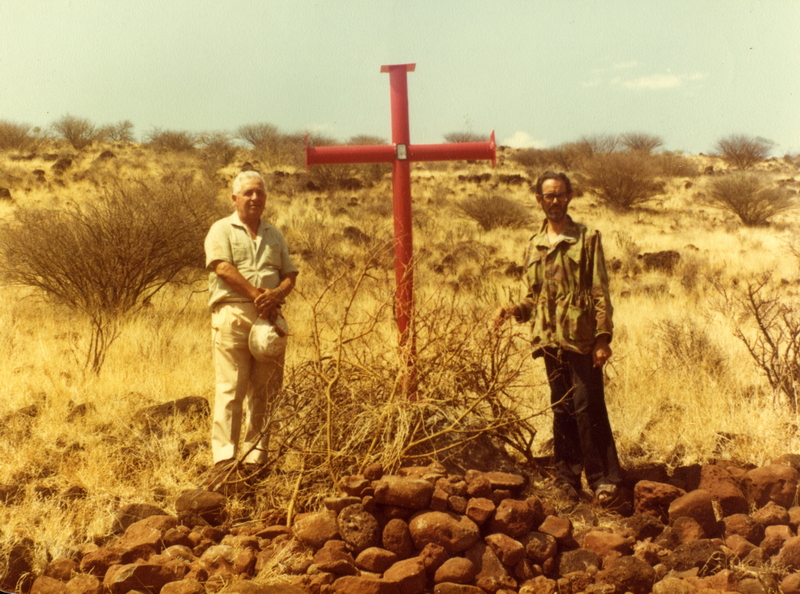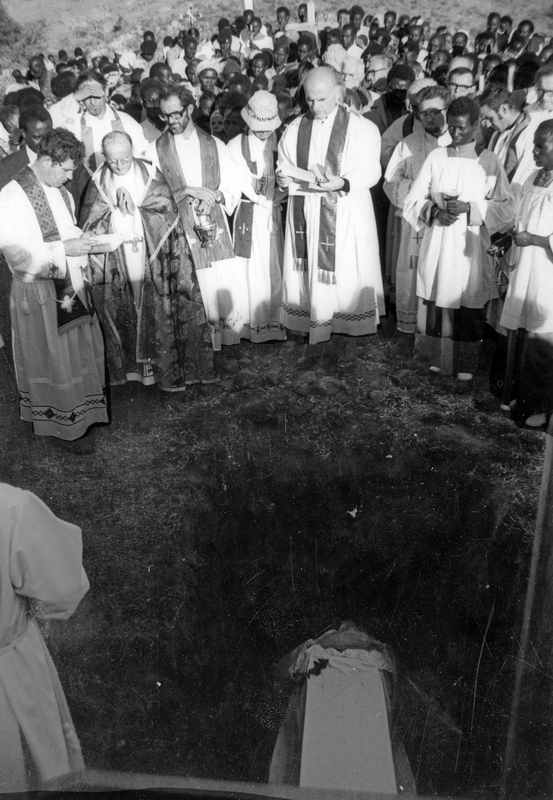IMC Venezuela 50: la missione alla foce dell’Orinoco
I missionari e le missionarie della Consolata iniziano, insieme, la missione a Nabasanuka il giorno della Consolata del 2006. Dopo otto anni da quando hanno lasciato la Guajíra, affidano a lei l’opera di evangelizzazione di un altro popolo indigeno, quello dei Warao.
 Sommario di tutto il dossier «Venezuela 50»
Sommario di tutto il dossier «Venezuela 50»
1970-2020: i 50 anni dei Missionari della Consolata in Venezuela
-
-
- Popoli indigeni, afro e periferie
- La scelta degli indigeni della Guajíra
- Tra gli afrodiscendenti di Barlovento
- Periferie urbane: nei «barrios» di Caracas
- La missione alla foce dell’Orinoco con i Warao
- L’animazione missionaria della Chiesa venezuelana
-
La missione alla foce dell’Orinoco
Nabasanuka, porto dei Warao
La curiara (canoa) solca veloce le acque del fiume che, pigro, scorre tra ali di maestosa foresta tropicale mentre uccelli, come usciti dalla tavolozza di qualche pittore naïf, intonano il loro concerto mattutino osservando incuriositi il passaggio di alcuni naviganti, «turisti per caso».
Siamo nello stato Delta Amacuro, un paradiso di acque, animali e piante creato dalla foce dell’Orinoco, il fiume più grande del Venezuela che, avvicinandosi all’Atlantico, per una lunghezza di 200 km, crea in una fitta ragnatela di canali, lagune e zone palustri che si intrecciano tra loro.
La barca, partita col buio, sette ore fa dalla città di Tucupita, sta per giungere alla meta: Nabasanuka, la casa del popolo warao.
Diciotto anni dopo la Guajíra
È il 20 febbraio 2006, quattro giorni dopo la festa del beato Giuseppe Allamano. I missionari e le missionarie della Consolata iniziano il loro lavoro apostolico a Nabasanuka, affidandosi al fondatore e alla Consolata, chiedendo di poter essere presenza di consolazione in mezzo ai Warao.
Prende forma così un sogno coltivato a lungo dai missionari in Venezuela. Dopo aver lasciato la Guajíra nel 1998, essi non hanno mai rinunciato alla speranza di tornare a lavorare tra gli indigeni per esprimere pienamente e al meglio il loro carisma missionario.
È stato proprio inseguendo questo sogno che, nel duemila, durante la V Conferenza della Delegazione, essi hanno deciso di iniziare una nuova presenza fra i popoli indigeni, possibilmente in collaborazione con le missionarie della Consolata. L’anno successivo, i Consigli generali dei due istituti hanno approvato la decisione che nel 2004 è poi sfociata nella scelta del vicariato di Tucupita, degli indigeni warao.
Nel 2005 due équipe di padri e suore, hanno raggiunto la missione di Nabasanuka in tempi diversi e, durante varie settimane, hanno realizzato un primo approccio con l’ambiente e la popolazione locale. L’obiettivo era di conoscere la realtà e di fare l’esperienza del vivere in équipe: era, infatti, la prima volta che padri e suore lavoravano insieme vivendo sotto lo stesso tetto.
![]()
Missionari e missionarie insieme
Il 20 febbraio 2006 i padri Josiah K’Okal e Vilson Jochem giungono a Nabasanuka e iniziano una presenza stabile. Tuttavia, come è stato programmato, l’inizio ufficiale della loro missione insieme alle missionarie della Consolata nel vicariato di Tucupita avviene il 20 giugno 2006, festa della Consolata. La messa solenne è presieduta dal Vicario apostolico, mons. Felipe González, accompagnato da tutti i Missionari della Consolata e dai Cappuccini. Durante la celebrazione sono presentati alla comunità i missionari e le loro consorelle, le suore Carla Pianca, Luigina Goffi, Rosemary Kabbis e Ivana Cavallo che da oggi condivideranno la vita dei Warao a Nabasanuka.
Coinvolgere i laici
L’alto numero di comunità, le notevoli distanze e la difficoltà delle vie di comunicazione, rende impossibile visitarle con frequenza. Per questo, nel loro programma pastorale, i missionari decidono di dare la priorità alla formazione di animatori e di catechisti capaci di coltivare la vita cristiana nei loro villaggi anche in assenza del missionario. L’iniziativa parte fin da subito nelle comunità di Nabasanuka, Bononia e Araguabasi: si radunano una quarantina tra uomini e donne che, in futuro, rappresenteranno i pilastri dell’evangelizzazione nella parrocchia.
Per venire incontro ai costi dei viaggi, la missione crea un piccolo fondo che, grazie alla Provvidenza, non si esaurirà per molto.

Il Vangelo si incultura
Nell’ottobre del 2007 si tiene un’assemblea allargata degli agenti di pastorale, laici e religiosi, che lavorano nelle diverse comunità del vicariato nel quale, tra l’altro, si è deciso di creare una équipe di Pastorale indigena con l’obiettivo di costruire una chiesa inculturata, con un’identità propria, dove l’esperienza di fede sia espressione del mondo warao, della sua cultura e lingua, delle sue tradizioni e valori.
Da questo obiettivo nasce un piano di pastorale suddiviso in otto ambiti principali: la religiosità, la spiritualità e l’inculturazione; la promozione della cultura warao e l’assunzione dei valori presenti in essa; la lotta contro la povertà e l’impegno per uno sviluppo solidale; la democrazia partecipativa; la difesa della terra e dell’ambiente; lo sviluppo umano tramite la salute e l’educazione; l’appartenenza e l’integrazione nazionale e internazionale; la promozione e la difesa dei diritti umani.
Nel 2008, i missionari e le missionarie, alla luce di questo piano, e rispondendo alle attese della comunità, redigono il loro primo progetto apostolico nel quale l’evangelizzazione viene definita come «inculturazione del Vangelo a partire dalla spiritualità e religiosità tradizionale dei Warao, preservando, promuovendo e difendendo la loro identità culturale e i loro diritti come nativi del Delta Amacuro».
Percorrendo questa strada, i missionari scoprono nel mondo spirituale warao molti semi del Vangelo che attendono solo di giungere a maturazione. Bella, per esempio, è l’espressione che gli indigeni usano per indicare il Regno di Dio: «Dioso a Janoko», che letteralmente vuol dire «la casa di Dio». Non c’è immagine migliore per definire l’opera dei missionari: fare di questo popolo una casa dove ci si accoglie e si collabora fraternamente.
![]()
Promozione umana
Percorrendo i canali del delta, fermandosi a ogni attracco di barche, entrando in questa o quella palafitta, i missionari possono constatare che, al di là della facciata da cartolina, vi è una realtà di povertà e di abbandono, di fame e di malattie endemiche che lasciano sgomenti: bambini denutriti, ragazzi non scolarizzati, anziani abbandonati a se stessi e senza cure mediche.
In tutta la regione (15mila km2, un territorio più grande del Trentino Alto Adige) c’è un solo dispensario, con un medico residente che, volontariamente, si prende cura di questa gente.
Per quanto riguarda l’educazione, in tutto il territorio ci sono due scuole secondarie. Ciò significa che la stragrande maggioranza dei giovani termina solo il ciclo della scuola elementare. Inoltre, l’insegnamento non eccelle per serietà e rendimento, a causa della mancanza di maestri professionalmente qualificati.
Questa situazione spinge i missionari a impegnarsi come insegnanti nel liceo di Nabasanuka dove confluiscono studenti provenienti da una quindicina di comunità. Un impegno in più nel già gravoso lavoro di evangelizzazione, ma anche un’opportunità per conoscere i giovani e accompagnarli nella loro crescita umana, culturale e religiosa.
Va ricordato che il popolo warao è sempre stato nomade, migrando da un luogo all’altro in cerca di migliori condizioni di vita. Per fermare la migrazione e migliorare la qualità della vita delle persone, l’équipe missionaria porta avanti progetti in ambito sanitario come giornate mediche nelle comunità, distribuzione di medicine e forniture sanitarie, e un programma di assistenza medica e alimentare per chi convive con Aids e tubercolosi. «Molti, purtroppo, sono morti aspettando un mezzo di trasporto», esclama un missionario. Ecco perché la missione cerca anche di aiutare con ambulanze fluviali e terrestri per trasferire i malati in città.
Altri progetti riguardano il settore dell’istruzione con borse di studio per studenti, il «Computer Center» (una sala computer a uso comunitario), con l’equipaggiamento necessario per studiare via internet, e la fornitura di materiale scolastico (quaderni, matite, divise).
La generosità fa sbizzarrire la fantasia. Così nascono progetti di micro auto sostenibilità per accedere all’energia solare, per l’acquisto di reti e accessori utili per la pesca, sementi per piantare, tessuti per i corsi di taglio e cucito per le donne.
Sergio Frassetto
![]()
I Warao
Warao è un termine che significa «Gente di canoa» e indica un popolo indigeno che conta circa 50mila persone. I Warao costituiscono il secondo gruppo etnico più numeroso in Venezuela dopo i Wayú.
Vivono su palafitte costruite ai margini dei fiumi, formando piccoli villaggi di famiglie unite fra loro da forti legami di collaborazione e solidarietà. Il più anziano del gruppo, chiamato «aidamo», svolge la funzione di autorità della comunità.
I Warao si dedicano alla pesca e alla caccia di sussistenza. Dove è possibile, in piccole radure (conuchi) coltivano l’ocumo, una pianta erbacea che produce tubercoli commestibili che rappresentano il «pane» del Warao. Esercitano un artigianato vario e di grande qualità: amache, ceste, utensili, ecc.
Giungendo a Nabasanuka come ospiti e pellegrini, i missionari hanno potuto sperimentare la sorprendente ricchezza umana e sociale di questo popolo. Infatti, sono stati accolti non come stranieri, ma come «daje» (fratello maggiore) o «daka» (fratello minore).
La parrocchia di Nabasanuka, dedicata a Maria «Divina Pastora de Araguaimujo», sorge nel centro abitato principale nel quale vivono circa 800 persone.
Il resto della popolazione è suddiviso in una sessantina di piccole comunità, alcune già evangelizzate, altre con una vita cristiana embrionale, altre che attendono ancora il primo annuncio del Vangelo.
La prima sfida che i missionari hanno affrontato con i Warao, è stata l’apprendimento della lingua indigena, allo scopo di intessere relazioni e di conoscere la cultura. Nello stesso tempo, hanno cominciato a visitare le comunità raggiungendole sulle curiaras via acqua.
Uno dei problemi più grossi della zona sono proprio le comunicazioni e i trasporti: il posto più vicino nel quale rifornirsi di benzina è Tucupita, a sette ore di curiara. Per raggiungerlo con barche vecchie e malandate, succede di rimanere in panne nelle acque dell’Orinoco.
Da qualche anno è stata acquistata una nuova barca, regalata da amici e battezzata La Consolata. Ora i missionari girano per le terre dei Warao con più speditezza. (S.F.)
![]()
Una giornata tra i Warao
Padre Andrés García Fernández, spagnolo, ha al suo attivo un’invidiabile esperienza missionaria. Ha lavorato tre anni in Costa d’Avorio fra gli immigrati, cinque in Spagna, nel campo dell’animazione missionaria, tredici in Congo RD fra i pigmei e dal 2019 è tra i Warao del Delta Amacuro.
Arrivando in Venezuela tra i Warao, la sfida è stata quella di entrare nell’anima di questo popolo, conoscerne la cultura, la lingua, l’organizzazione, e scoprirne la relazione con la natura e la trascendenza. Cercare di capire dove Dio lo conduce, e accompagnarlo in questo processo.
La classe politica sta litigando, lotta per il potere, cercando di abbattere l’avversario. Mentre va avanti questa lotta, quelli che soffrono sono i poveri, la gente umile.
I popoli indigeni stanno soffrendo molto per quello che viene chiamato «El Amo» (l’Arco minerario dell’Orinoco), le cui ricchezze del sottosuolo (oro, coltan e altro) sono appetite dal governo attuale, dalla guerriglia colombiana (le Farc e altri gruppi) e anche dall’opposizione.
La selva viene depredata e distrutta con tutte le conseguenze che la devastazione ambientale comporta per coloro che la abitano. Nel delta l’acqua arriva di colore quasi nero. Nel periodo di crescita del fiume arriva tutto il mercurio con cui si lava l’oro, il cianuro e altri veleni. I pesci galleggiano morti, l’acqua ha l’aspetto della spuma e noi la beviamo e ci laviamo con essa. E le malattie proliferano sotto forma di piaghe, diarrea, febbre, soprattutto nei bambini.
La gente soffre per mancanza di potere d’acquisto: il governo non paga con denaro effettivo, ma dà un numero che indica una somma, ma se non c’è elettricità per tutta una settimana, come capita spesso, non si può ritirare dalla banca il proprio «numero» per andare comprare quello che serve. La gente soffre per mancanza dei servizi essenziali, degli alimenti di base, delle medicine. E il fatto di aver chiuso la porta agli aiuti che vengono dall’estero peggiora la situazione. La gente si dispera.
Quando ho chiesto a un Warao scappato in Brasile: «Perché te ne sei andato dal Venezuela?», mi ha risposto: «Mi è morto il primo figlio, è morto il secondo e non ho voluto che morisse anche il terzo».
![]()
Giorno dopo giorno
Ciononostante, la missione è appassionante, e condividere il trascorrere dei giorni con la gente è bello. Chiedo a Dio di non abituarmi mai a questa realtà. Vivendo nel seno della foresta pluviale, è bello alzarsi al mattino e vedere tutta la ricchezza della natura: quei fiumi, quegli alberi, quei paesaggi, i bambini, il modo di vivere della gente, la cultura.
In genere cerco di alzarmi alle quattro del mattino per pregare, perché, a partire dalle sei, quando celebriamo la messa, fino alle 8 o 10 di sera non riesco più a sedermi.
Dopo la preghiera preparo un po’ di colazione, a volte per due giorni in modo che mi duri di più, e poi faccio il bucato e riordino la casa.
Dopo l’eucaristia inizia a venire la gente con le proprie necessità: c’è chi viene a chiedere una medicina, chi cerca cibo o altro.
Con un gruppo di collaboratori organizziamo gli incontri per i giovani, il programma di alfabetizzazione dei bambini e quello per la formazione delle donne.
Una volta preparato il materiale, usciamo con la lancia e navighiamo per i vari canali alla volta delle comunità. Nella nostra parrocchia ce ne sono una sessantina che cerchiamo di visitare ogni mese. Lascio un gruppetto di collaboratori nella prima, un altro gruppetto nella seconda e, mentre essi svolgono l’attività programmata, io vado alla seguente. Quando ho finito la formazione e l’eucaristia, faccio il percorso inverso: torno alla seconda comunità dove il gruppetto ha già terminato la formazione, celebro l’eucaristia e poi, insieme, torniamo alla prima.
In questo modo cerchiamo di visitarne due o tre ogni giorno. Le accompagniamo e le formiamo
in questo modo.
Trascorro poi il pomeriggio in casa, giocando con i bambini, ricevendo la gente, visitando gli infermi e parlando con i giovani che chiedono una speranza (cosa facciamo, dove andiamo, dove possiamo trovare lavoro?).
I Warao non esistono senza il delta
Ci sono anche i maestri che hanno bisogno di imparare come insegnare. La maggioranza di loro ha frequentato solo la scuola secondaria e non ha avuto altra preparazione. Devono imparare a fare un programma pedagogico, a trasmettere i contenuti, ecc.
È appassionante anche seminare speranza e aiutare le persone a organizzarsi, a sognare, e a sognare un ritorno di tutti quei Warao che se ne sono andati, sognare di tornare a essere il popolo che erano, ma più organizzato, con più coscienza di quello che sono.
Questo discorso vale per il delta dell’Orinoco, ma anche per tutta l’umanità.
Io, spesso, dico loro: «Il delta con tutta la sua biodiversità non esisterebbe senza i Warao, senza la vostra maniera di essere e di vivere». Anche i Warao senza il delta, pur sopravvivendo, non vivrebbero più come Warao. Hanno bisogno del loro ambiente per continuare a essere come sono stati finora.
![]()
Dio dietro ogni cosa
Una cosa bella è vedere come il Warao chiede permesso all’albero per tagliarlo e fare la sua
curiara, vedere come chiede permesso alla natura per tagliare alcuni alberi per fare il suo orto dove produrre l’ocumo, o come chiedono permesso all’acqua quando vanno a pescare o a navigare.
È importante scoprire come per essi c’è una vita, c’è un dio della vita, che sta dietro a tutta la natura e che sostiene l’esistenza di ciascuno, di ogni essere e di ogni persona.
Allora la mia quotidianità è scoprire e accompagnare tutto questo, non solo condividendo il poco che ho, ma anche i loro sogni, le difficoltà, gli ideali e il ritmo di Dio nelle loro anime.
Verso le ore 20 mi chiudo in casa, solo con nostro Signore, ricapitolando la giornata, rendendo grazie e programmando il giorno dopo. In questo modo il giorno trascorre pieno di gente e scoprendo in essa la presenza di Dio.
Andrés García Fernández
![]()
Dalle sponde del fiume alla città
Con gli indigeni a Tucupita
Alla ricerca di migliori condizioni di vita, chi può o chi è costretto dalla povertà, abbandona la sponda del fiume e raggiunge la città. Sradicati dalla comunità, i Warao si ritrovano soli in un ambiente ostile che non sa offrire loro altro che marginalità e povertà ancora più profonda di quella lasciata nella terra nativa.
La «transumanza» è una caratteristica dei popoli indigeni. Da sempre i Warao la praticano realizzando una stretta interconnessione con Tucupita e altre città dentro e fuori i confini del Venezuela. Nel corso degli anni, ampi strati di popolazione indigena si sono trasferiti nel capoluogo della regione in cerca di migliori condizioni di vita. Tuttavia, vivendo la marginalità, dispersi nella grande città e senza punti di riferimento sicuri come la famiglia e il clan, facilmente perdono la loro identità e i loro valori.
Allo scopo di accompagnare anche i Warao migranti nel loro cammino umano e spirituale, i missionari, fin dal loro arrivo a Nabasanuka, concepiscono una loro presenza nella città di Tucupita.
![]()
Pastorale indigena urbana
Il progetto di stabilire una presenza a Tucupita si realizza nel marzo 2009, quando padre Zachariah Kariuki, missionario della Consolata keniano, si trasferisce nella città e assume la responsabilità del lavoro pastorale con i Warao emigrati lì, facendo base nella parrocchia di san Giuseppe.
A Tucupita i missionari diventano così fattore di incontro e comunione per gli indigeni, contribuendo, con diverse iniziative, a promuovere in essi il senso di appartenenza, tassello fondamentale per una presa di coscienza della propria identità e dignità.
Uno dei progetti sviluppati è quello dei due corsi di taglio, cucito e sartoria per 50 donne all’anno. Il corso fornisce loro le conoscenze necessarie a realizzare manufatti sartoriali per le loro famiglie e per la vendita, e quindi generare reddito.
Risiedendo a Tucupita, i Missionari della Consolata possono anche offrire un servizio diretto in favore del vicariato Delta Amacuro. Così, padre Zachariah (che nel 2018 tornerà in Kenya e verrà sostituito da padre Silvanus Ngugi) svolge le funzioni di vicario generale del vescovo, direttore delle Pontificie opere missionarie e responsabile, dal 2016, della nuova vicaria denominata «Dani Consolata» dedicata al servizio degli indigeni.
Avere una parrocchia in Tucupita, poi, rappresenta un vero e proprio punto di approdo per chi arriva dalla missione dopo sette ore di curiara. Qui i missionari possono mangiare, riposare e appoggiarsi per le mille faccende da sbrigare prima di ripartire per Nabasanuka.
E così, a Tucupita come a Nabasanuka, nel cemento della città come nelle acque dell’Orinoco, i Missionari della Consolata, nonostante il loro numero ristretto a causa della difficoltà a ottenere dal governo i permessi, lavorano uniti alla costruzione del Regno di Dio tra i Warao.
Sergio Frassetto
![]()
Verso il Brasile
Le tragiche condizioni socio economiche del Venezuela hanno costretto milioni di cittadini a emigrare nei paesi vicini. Tra loro, migliaia sono Warao. I missionari continuano a seguirli anche in Brasile.
Sommerso da una profonda crisi politica, economica e sociale, il Venezuela sta vivendo una situazione drammatica. La popolazione soffre per la carenza di cibo, medicine, trasporti, alloggi, lavoro, servizi di base come ospedali, scuole, acqua, elettricità. Le condizioni di vita peggiorano ogni giorno, mettendo a rischio molte vite.
Si stima che oltre il 50% della popolazione viva in condizioni di estrema povertà, al punto che alla fine del 2020, una famiglia di cinque persone avrebbe dovuto guadagnare 98 salari minimi per acquistare beni di prima necessità. Questa situazione ha causato enormi migrazioni nei paesi vicini, in particolare in Colombia e Brasile.
Secondo le statistiche ufficiali, sono oltre 5 milioni i venezuelani che hanno lasciato il regime di Maduro in cerca di migliori condizioni di vita.
![]()
I Warao a Pacaraima e Boa Vista
Anche molti indigeni warao del Delta Amacuro sono stati costretti a lasciare il paese. Si sono stabiliti inizialmente a Pacaraima, una città dello stato brasiliano di Roraima appena oltre il confine con il Venezuela, ma molti si sono poi spinti all’interno dello stato di Roraima, in città come Boa Vista, e in altri stati, come a Manaus, in Amazonas.
Sopravvivono con le donazioni di enti privati e di beneficenza. Molti hanno portato con sé prodotti di artigianato dal Venezuela e lavorano come venditori ambulanti. Alcuni vorrebbero restare a vivere in Brasile e vanno alla ricerca di lavoro, ma senza successo, anche perché privi di documenti di identità.
La situazione di precarietà aumenta la loro vulnerabilità, i rischi di sfruttamento, l’uso di droghe, la fame e le malattie.
 Missionari itineranti
Missionari itineranti
Per i Missionari della Consolata in Venezuela, il futuro di queste comunità indigene è motivo di grande preoccupazione. La Direzione generale dell’Istituto, venendo incontro a questa situazione, a maggio del 2018, ha approvato la creazione di un’équipe missionaria itinerante per accompagnare proprio gli immigrati e rifugiati venezuelani a Pacaraima e Boa Vista.
Il team è composto da tre missionari, uno dei quali lavora con i Warao a Tucupita.
Le sfide da affrontare giorno per giorno riguardano tutti i settori: documentazione, salute, sicurezza, trasporti, educazione, lavoro e integrazione. Oltre a queste sfide e all’assistenza religiosa, i missionari si dedicano in modo speciale all’alimentazione dei bambini fra i quali si riscontrano molti casi di denutrizione. A loro vengono offerti due pasti a settimana accompagnati da formazione umana, culturale e igienica. (S.F.)