Cari Missionari
Gli Evangelici e il sostegno a Trump e C.
In Italia gli evangelici ci sono, c’è cascata
anche la bravissima badante peruviana che ha assistito mia madre e poi un’altra
amica di famiglia. Ma, a quanto sembra, sono molto diffusi e potenti nelle
Americhe, e si ficcano in politica con un entusiasmo che sarebbe piaciuto a Pio
XII, sostenendo la peggio destra in Usa, Brasile e suppongo anche altrove in
Sudamerica. Forse ci starebbe un altro servizio (mi sembra che ve ne siate già
occupati, ma la situazione si è aggravata).
Claudio Bellavita
08/10/2018
Il termine «Evangelici» ha un significato molto vasto, forse qui è usato solo per indicare le frange più fondamentaliste e nuove della galassia protestante. Il loro influsso non è certo limitato agli Stati Uniti (vedi MC 1-2/2017) o al Brasile. Sarà nostro impegno approfondire questo tema.
Il Diritto di restare a casa propria
Caro padre,
mi rifaccio vivo […] dopo la lunga lettera che fu pubblicata solo in parte per mancanza di spazio (e anche questa è tagliata per lo stesso motivo, ndr). Nella chiesa del paese dove mi trovavo fu distribuito il foglietto di settembre dell’Apostolato della Preghiera sul quale era riportata anche l’intenzione di preghiera del papa: «Perché i giovani del continente africano abbiano accesso all’educazione e al lavoro nel proprio paese».
È
una delle cose che intendevo sostenere nella mia lunga lettera dicendo che era
un concetto insegnatomi dai missionari ma dirlo oggi, o meglio dirlo un anno fa
suonava come una cosa xenofoba, populista, intollerante, sovversiva, non
solidale, contro i diritti umani e – ed è ciò che mi irrita di più –
anticristiana. Ma se prego perché i giovani africani abbiano accesso
all’istruzione e al lavoro a casa loro sto pregando per eliminare l’esigenza
che li spinge a muoversi in massa per venire da noi. È tutto logico e
cristiano. Entrambe le cose sono ormai ridotte ad opinioni e neanche
particolarmente valide.
[…] Rimanendo all’immigrazione penso che
nonostante tutto, molti non siano ancora convinti che il fenomeno migratorio
Africa-Europa, così come lo vediamo, non è per nulla spontaneo, come non lo è
quello nuovo dall’Honduras verso gli Usa (guarda caso ci sono le elezioni di
medio termine in Usa…) e credo che una buona parte della causa di ciò sia nei
mass media (diciamo almeno l’80% dei grandi media) che sembrano li apposta per
«formare» l’opinione pubblica invece che informarla. Sono più attori della
politica invece che osservatori.
Ancora rifacendomi a cose già dette, se Missioni Consolata fa giornalismo allora ha una gran responsabilità e c’è un gran bisogno di informare in modo ben ragionato i lettori. Se volete anche formare le pecorelle che credono di essere rimaste all’ovile ne sarò molto felice ma che sia formazione cristiana «sicura», basata non sulle ventate dell’attualità ma sulla Verità e ciò che la Chiesa ha sempre insegnato a ragion veduta.
Un saluto.
Andrea Sari
29/10/2018
Caro Sig. Andrea,
non me ne voglia se ho dimezzato la sua lettera.
Sul fatto che «i giovani africani abbiano accesso a educazione e lavoro nel proprio paese» non c’è niente di anticristiano. Il diritto a rimanere a casa propria (ma anche ad averne una) è fondamentale per ogni uomo. Tutta la storia biblica gira attorno alla «terra» promessa da Dio al suo popolo.
Noi missionari, da sempre, abbiamo investito tanto (e continuiamo a farlo) per aiutare i più poveri del mondo a vivere meglio a casa propria.
Quanto all’informazione: è nostro impegno – con i nostri poveri mezzi – offrire articoli documentati e ragionati, senza seguire lo stile sensazionalista e litigioso di moda oggi nel rispetto dell’intelligenza dei nostri lettori.
Chevron Texaco
Forse ho inteso male ma la Chevron Texaco, in vent’anni o giù di lì, è riuscita a scaricare in 450 chilometri quadrati di Amazzonia equadoregna circa 60 chilometri cubi di petrolio (acqua tossica da lavori di estrazione, ndr), provocando danni enormi.
Condannata dai giudici di Quito (Corte Costituzionale ecuadoriana, ndr) a risarcire gli indios e i campesinos con una somma di oltre 9 miliardi di dollari, la multinazionale è riuscita a farla franca grazie alla Corte europea (Corte permanente di arbitrato dell’Aja, realtà completamente indipendente dalla Unione europea, ndr), che avrebbe (uso il condizionale perché anche in questo caso potrei aver inteso male) ordinato all’Ecuador di annullare la sentenza di condanna, in quanto trattasi di un giudizio che viola i «diritti della Chevron Texaco» (perché l’Ecuador è accusato di aver violato un articolo del «Trattato Bilaterale sugli investimenti» [Bilateral Investment Treaty] esistente tra Ecuador e Stati Uniti dal 1993 e quindi di essere corresponsabile con la multinazionale, ndr).https://lospiegone.com/2018/07/28/ecuador-vs-chevron-texaco-ambiente-sentenza/
Una cosa però sono sicuro di averla ben chiara in mente: giudici così, che assolvono multinazionali così, non mi rappresentano e non rappresentano né le radici cristiane, né le altre radici dell’Europa, né lo spirito e le idee di chi vive in Europa oggi e, di conseguenza, non so come facciano a occupare il posto che occupano. […] Non so se inorridire di più di fronte alle immagini di quel Tg2 Dossier o per le sentenze pro Chevron Texaco. […] Distinti saluti
Letizia Valnigri
25/10/2018
Il nostro Paolo Moiola ha scritto più volte sull’argomento. Emblematico l’articolo pubblicato in MC 7/2016 «La maledizione del petrolio».
Santità
Caro padre Gigi,
oggi ho iniziato la giornata, festa di tutti i Santi, leggendo l’editoriale «Cuori aperti» del tutto appropriato alla circostanza. Mentre lo leggevo tanti pensieri hanno affollato la mia mente e tanta tristezza ha invaso il mio cuore, prendendo in considerazione l’attuale contesto culturale in cui viviamo, soprattutto pensando allo sfregio che subisce il messaggio evangelico sia da chi se ne serve strumentalmente senza una vera adesione personale e sia da chi, a dispetto del ruolo e dell’incarico, esercita, all’interno della comunità ecclesiale, un’azione demolitrice e denigratrice. La festa odierna, in ogni caso, mi/ci ricorda che la santità è da un lato un dono gratuito ma dall’altro richiede il rinnovo della personale adesione ad essere «beati» secondo la logica di Gesù e non «spettatori o giudici». […]
Buona festa dei Santi!
Milva Capoia
Collegno, 01/11/2018
La caduta del cielo
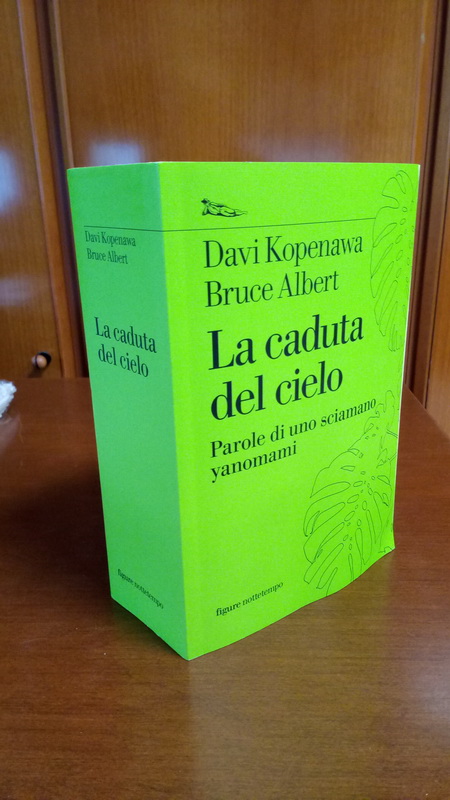
Oggi mi sento come in un giorno di festa: ho
appena ricevuto in regalo la versione italiana de «La caduta del cielo». L’ho
ricevuta dalle mani di Davi Kopenawa Yanomami, l’autore, che me l’ha dedicata
con queste parole: «Per Hokosi (nome indigeno di Carlo Zacquini, ndr),
una freccia per toccare il cuore della società non indigena».
Il libro, scritto con (l’antropologo) Bruce
Albert, è un’opera che, tra le tante cose, stimola riflessioni, apre porte per
la comprensione delle scienze sociali, della filosofia, delle religioni, dei
mondi mitici e della natura. Più di mezzo secolo fa ebbi la fortuna di iniziare
la mia «avventura» con il popolo Yanomami. A lungo, il cruccio più grande, il
tormento, l’afflizione lancinante fu di non essere all’altezza della sfida per
comunicare, diffondere, rendere virali le scoperte che stavo facendo, la
necessità che sentivo di divulgarle, di far conoscere ad altri il mondo magico,
la filosofia, la religione, non per mero sensazionalismo, ma semplicemente per
suscitare un po’ di rispetto, se non di ammirazione per quel popolo. Per un
popolo, tra i tanti in Amazzonia, che sembrava destinato a scomparire,
lasciando poche tracce delle sue ricchezze, ben più importanti di quel po’ di
oro che si estrae (illegalmente) dalle loro terre, a un costo che il Brasile e
la stessa umanità mai riusciranno a pagare.

Nel 1971, l’incontro fortuito con Claudia Andujar
(una fotogiornalista) mi diede un’opportunità unica di collaborare alla ricerca
«immaginifica» dell’anima di questo popolo. L’occasione fu per me un invito a
nozze. Così, mentre da un lato cercavo di scoprire il mondo fantastico nascosto
dietro quei corpi «nudi», dall’altro mi sentivo felice di poter offrire a quella
donna quel poco che stavo imparando. I tempi lunghi e solitari nella foresta mi
aiutavano a trasmettere nozioni e sensazioni. E, successivamente, insieme alla
stessa Claudia e alla sua eccelsa arte fotografica, di scoprirne altre.
Le tragedie che seguirono non mi permisero di
approfondire oltre le mie conoscenze della cultura Yanomami e mi forzarono a
percorrere altri sentieri per cercare di arginare il massacro. Le immagini di
Claudia ebbero, tra i tanti meriti, quello di trovare percorsi nuovi che furono
determinanti nella lotta contro lo sterminio degli Yanomami. Eppure, nonostante
le fotografie, nonostante il poderoso libro di Davi, il massacro e la lotta
continuano ancora oggi. E le autorità, che avrebbero l’obbligo di arginarlo,
stanno affondando in un mare di corruzione e vergogna.
Fratel Carlo Zacquini
Boa Vista (Roraima), 13/11/2018
Dalla valle Susa
Gentile Direttore,
le scriviamo dalla Valle Susa. Siamo un gruppo di donne e uomini impegnati a vario titolo in diverse parrocchie della diocesi e da alcuni anni seguiamo l’evolversi del progetto Torino-Lione riunendoci nel Gruppo Cattolici per la Vita della Valle. Vorremmo condividere con lei e i lettori della rivista alcune riflessioni e considerazioni che abbiamo sviluppato su questo tema, alla luce della dottrina sociale della Chiesa e della Parola di Dio che interpella i credenti sulle situazioni concrete della vita.
Riteniamo
che l’espressione usata nel Vangelo di Matteo 16,3, «Leggere i segni dei
tempi», e circolata con convinzione negli anni postconciliari, sia un compito
sempre attuale e particolarmente incalzante nella nostra epoca. Epoca che il
chimico premio Nobel Paul J. Crutzen ha definito «Antropocene» per indicare
l’impatto senza precedenti dell’azione umana sull’ambiente terrestre. La
definizione è largamente condivisa dagli scienziati più avveduti e anche il
Magistero della Chiesa ci offre molti spunti al riguardo, ne citiamo un paio:
«L’antropocentrismo
moderno, paradossalmente, ha finito per collocare la ragione tecnica al di
sopra della realtà, perché questo essere umano non sente più la natura né come
norma valida, né come vivente rifugio… La mancanza di preoccupazione per
misurare i danni alla natura e l’impatto ambientale delle decisioni è solo il
riflesso evidente di un disinteresse a riconoscere il messaggio che la natura
porta inscritto nelle sue stesse strutture», (Laudato Si’, 115-117, papa
Francesco).
«Invece
di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della creazione,
l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della
natura», (Centesimus annus, 37, papa Giovanni Paolo II).
Il processo di antropizzazione della Terra (la de-
forestazione, l’urbanizzazione incontrollata, l’estrattivismo, la
cementificazione del territorio, l’invasione dei rifiuti…)
esercita un’alterazione sempre maggiore degli ecosistemi dando origine a
fenomeni preoccupanti quali il riscaldamento del clima, lo scioglimento dei
ghiacciai, la desertificazione…
Il filosofo e teologo cattolico Raimon Panikkar
utilizzava il termine «Ecosofia» per indicare la saggezza di chi sa «ascoltare
la Terra» e agire di conseguenza; per lui la crisi ecologica attuale è
questione di vita o di morte per l’umanità e ciò la rende un fenomeno
religioso.
Le Chiese cristiane si mobilitano per
sensibilizzare i fedeli sulla necessità di riflettere, pregare e promuovere
iniziative per la salvaguardia dell’ambiente. Nel 1989 il patriarca ecumenico di Costantinopoli Dimitrios I proclamò
il 1° settembre «Giornata mondiale di preghiera per la creazione», nel 2001
aderirono all’iniziativa le principali chiese cristiane europee, con papa
Francesco nel 2015 vi aderì anche la Chiesa Cattolica. Ora i cristiani di tutto
il mondo sono invitati alla «Preghiera per la creazione» nel periodo liturgico
che va dal 1° settembre al 4 ottobre.
Il
movimento No Tav, composito nelle sue espressioni culturali, non contrasta solo
il progetto, ma si riconosce come coscienza critica dell’attuale modello di
sviluppo che pervicacemente mette il pianeta alle corde, mentre «non c’è
sviluppo in un popolo che volta le spalle alla terra» (papa Francesco tra i
Mapuche, Cile 17/01/2018).
Si
potrebbe dire che la Valle di Susa si distingue per mettere a confronto due
opzioni esistenziali: quella del culto economico della «crescita infinita», di
cui le «Grandi Opere» sono paradigma; e quella di un approccio filosofico in
cui l’uomo vuole uscire dalla condanna di una visione esclusivamente economica
della vita e comprenda che la Terra nel suo insieme è un organo vivente che ha
bisogno di cura e attenzione.
Con l’opposizione alla Torino-Lione la valle è stata inserita tra i teatri dei 2931 conflitti ambientali del pianeta censiti nel 2016 (con il contributo dell’Unione europea attraverso l’European Research Council) dal sito www.ejolt.orghttp://www.ejolt.org
Le
lotte ambientali sono ormai di dimensione planetaria e mobilitano una
moltitudine di persone. In alcuni paesi l’epilogo raggiunge esiti drammatici:
l’Ong Global Witness il 2 febbraio di quest’anno ha dato notizia che nel
2017 sono stati assassinati 217 attivisti/e, a livello mondiale, per essersi
opposti a governi e aziende predatori delle loro terre. Le motivazioni che le
innescano, seppure con intensità differenti, sono ovunque molto simili:
progetti calati dall’alto con seguito di cantieri invasivi e devastanti,
imposizioni senza serio contraddittorio, indifferenza verso le istanze delle
amministrazioni locali, controllo militare della vita quotidiana sul
territorio, forti limitazioni e restringimenti delle libertà personali dei
residenti, iniziative giudiziarie nei confronti dei soggetti più
rappresentativi tra gli oppositori.
Il
progetto Torino-Lione ricalca puntualmente le stesse dinamiche; un osservatore
inesperto potrebbe scambiare il cantiere di Chiomonte, insediato nel 2011 per
la perforazione di un tunnel geognostico, per una base militare.
[…] La forza del movimento No Tav risiede nella coscienza di impegnarsi per una causa comune e smascherare quegli inganni che si nascondono dietro le «grandi opere» inutili, imposte con l’uso della forza e inclini alla presunzione di assumere il controllo sulla natura.
Fraterni saluti
Cattoxvalle@gmail.com
(seguono undici firme), 23/11/2018
Cari amici,
la nostra rivista non è indifferente alle battaglie in difesa dell’ambiente, e alla situazione della Valle Susa ha dedicato due inchieste già nel dicembre 2005 e gennaio 2006. «Si era ben lontani dal clima attuale, inquinato purtroppo da infiltrazioni para politiche, eversive e di dubbia provenienza», come ha scritto padre Ugo Pozzoli, ex direttore di MC, su questa rivista, nell’ottobre 2014 in un articolo dedicato all’impegno dei missionari per l’ambiente.
Non vogliamo entrare nei dettagli del dibattito del pro e contro la Tav, perché – pur interessati – non ne abbiamo la competenza. Il nostro augurio è che davvero prevalgano verità e bene comune e non gli interessi di questo o quel partito o di questa o quella lobby economica. Questa è la nostra responsabilità come credenti. Per questo vi siamo vicini nel vostro impegno civile basato sull’ascolto della Parola, il confronto con i documenti della Chiesa e l’amore per la «nostra madre Terra», per fare sì che la «lotta» non venga sequestrata dagli opportunisti, dai faziosi o dai violenti.








