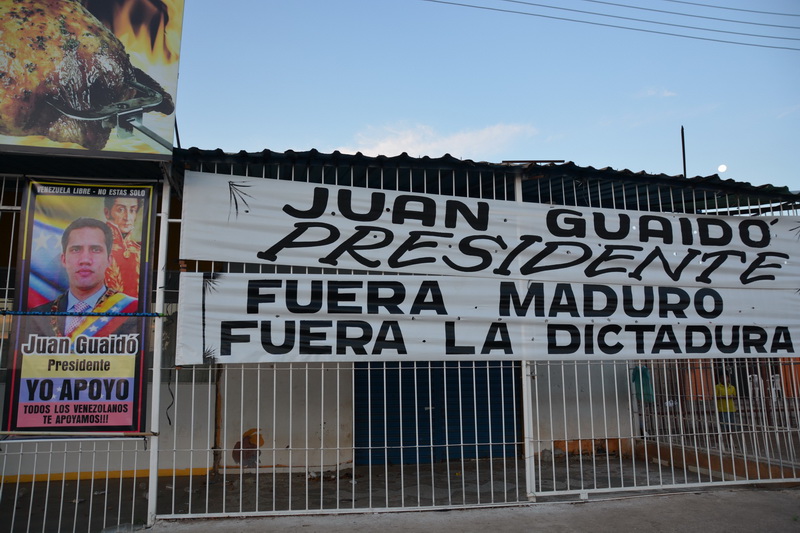Testo e foto di Marco Bello |
Il Niger è un paese di origine ma soprattutto di transito di migranti. Molti sono quelli che passano di qui per tentare la traversata del Sahara. Succede che non ci riescano, oppure che vengano respinti e riportati alla frontiera. Il flusso dei «ritornati» è in aumento. La chiesa cattolica del Niger si è organizzata per dare loro un’assistenza più «umana» possibile.
Niamey. La capitale sabbiosa del Niger sta cambiando volto. Nella sua zona centrale sono ben visibili alcuni grandi cantieri. Enormi edifici in costruzione, hotel e palazzi governativi di un’altezza mai vista qui, e poi il terzo ponte sul fiume Niger.
Guardando bene vediamo molti cinesi al lavoro sotto i caschetti gialli, e in alcuni cantieri sventolano bandiere turche. Sono questi i due sponsor ufficiali della speculazione edilizia a Niamey.
Ma in altre zone della capitale ci sono ancora quartieri con le case di mattoni in fango e paglia essiccati (banko), quasi «edifici storici», si direbbe da noi. Case da villaggio si dice in Niger.
Ci spingiamo nella periferia Est. In questa zona relativamente recente ci sono case basse e qualche edificio più alto, di banche o compagnie telefoniche. Noi cerchiamo i locali della parrocchia San Gabriel Garbado, della chiesa cattolica, minoritaria nel paese a grande maggioranza musulmana. A San Gabriel, l’arcidiocesi di Niamey – una delle due del paese, l’altra è la diocesi di Maradi – ha concentrato le attività di accoglienza e ascolto per i migranti.
Entriamo nella bassa costruzione in colore ocra, quasi mimetica, e nel cortile interno incontriamo Laurent Tindano, l’animatore principale della pastorale migranti. Laurent è un migrante lui stesso, perché burkinabè, ma vive qui da decenni e si sente nigerino a tutti gli effetti.

Un centro di ascolto
«Questo è un piccolo centro di accoglienza. Con pochi mezzi facciamo un accompagnamento dei migranti.
Ci occupiamo di coloro che stanno ritornando, dopo aver attraversato il deserto e tentato di passare il mare, senza successo, e ora vorrebbero rientrare nei loro paesi. Arrivano a Niamey sfiniti, privati di qualsiasi mezzo, smarriti e traumatizzati dell’esperienza durissima. Noi li accogliamo, ma non facciamo un lavoro amministrativo.
Parliamo con loro, li riceviamo come fratelli, non come stranieri, dando loro valore umano. Lasciamo tutto il tempo per parlare e cerchiamo di creare un rapporto di fiducia. Così ci raccontano il loro vissuto.
Li compatiamo nella loro sofferenza.
Quando un essere umano sente che lo capite, vi dà fiducia, e accetta di aprirvi il suo cuore e vi dirà molte cose. È diverso dal fargli delle domande per compilare un formulario».
Al centro di Garbado viene dato ai migranti anche un piccolo aiuto materiale «per facilitare il loro passaggio»: qualche soldo, una coperta, un kit igienico. Una volta la settimana un medico volontario visita le persone di passaggio. E, grazie alla convenzione con una farmacia e una clinica, si riescono a dare farmaci e far visitare i casi più gravi.

Un fenomeno nuovo
Laurent ci racconta che tutto è iniziato intorno all’anno 2011: «Con gli avvenimenti della Libia, del Mali e della Costa d’Avorio, alcuni sbandati arrivavano a Niamey e cercavano una parrocchia, perché è noto che dove c’è la chiesa è probabile ricevere un aiuto. Il fenomeno era nuovo e creammo dei comitati in ogni parrocchia. Ma poi ci rendemmo conto che c’erano migranti che facevano il giro. Si decise di concentrare l’attività a Garbado, che è in un luogo logisticamente vicino alle stazioni degli autobus di lunga percorrenza».
Gli chiediamo perché l’accoglienza è in prevalenza a chi torna dal tentativo di traversata. «Quelli che partono verso il deserto di solito sono in forma e hanno ancora il morale alto e mezzi economici. Hanno meno bisogno di noi. Inoltre noi siamo per la libertà di circolazione. Se ci chiedono informazioni sulla strada, diamo loro almeno qualche indicazione sui pericoli della traversata».
Seduto su una panca, poco più in là, sotto la tettoia di lamiera che ora ripara dal sole implacabile e per (soli) tre mesi all’anno dalla pioggia torrenziale, sta Micheal Johnson. Liberiano, di 37 anni, Michael è un vero globe trotter dell’Africa. Ma non per turismo.

Michael il «globe trotter»
Durante gli anni ‘90 in Liberia infuria una cruenta guerra civile (dall’89 al 2003 con una pausa nel ‘97-‘98). Come molti suoi connazionali Michael fugge e si ritrova in Costa d’Avorio, in un campo profughi. Nel paese lavora per dieci anni. Parla molto bene anche il francese. «Finita la guerra sono tornato nel mio paese, ma ho visto che la situazione era pessima. Volevo qualcosa di meglio dalla vita. Allora sono ripartito».
Michael passa da Guinea, Senegal, Mali, Burkina Faso e poi Niger. Da qui arriva in Ciad e si dirige verso il Sudan. «A questo punto è stato molto difficile. Ad Abéché ho trovato molti altri migranti che facevano il mio stesso viaggio. Siamo partiti insieme con un camion, ma passata la frontiera, verso le tre di notte, ci hanno assalito i ribelli Janjawid». Michael si trova nel Darfur. I ribelli sparano ai pneumatici del camion, fanno scendere tutti e puntano un’arma alla testa dell’autista. «Ci hanno fatti sdraiare nel deserto, hanno iniziato a torturarci e ci hanno preso tutto». Poi compare una pattuglia di caschi blu della missione di pace Onu, Unamid, che, sparando in aria, mette in fuga i Janjawid. Michael e gli altri sono salvi.
I caschi blu recuperano i malcapitati e li portano alla città di Al Fasher. «Hanno visto che non avevo nulla e mi hanno pagato il biglietto dell’autobus per Khartum. Il mio obiettivo era andare in Arabia Saudita».
A Khartum Michael non conosce nessuno, però da viaggiatore ormai esperto, si infiltra nel campus universitario, dove si riesce a vivere con poco e si trova sempre qualcuno che ti aiuta. «Sapevo dell’esistenza dell’università Jama Africa. Ci sono rimasto qualche tempo, intanto ho cercato un lavoro perché avevo finito i soldi». Appena ha abbastanza soldi Michael si rimette in viaggio e è arriva a Port Sudan, città sul Mar Rosso.

Ultimo passaggio
«C’erano delle barche che attraversavano il mare per andare in Arabia Saudita. Le barche erano sovraccariche. Ho visto gente di Etiopia, Eritrea, Nigeria, Camerun, Mali, Liberia. Ho pagato 1.500 dollari e mi hanno portato in un luogo nel deserto, dove molti altri erano in attesa. Ho così scoperto che c’erano molti migranti clandestini. Ci hanno detto di non farci vedere in città. Dovevamo aspettare di essere 150 per riempire una barca e i trafficanti sarebbero venuti a cercarci. Nel frattempo ci portavano cibo e acqua acquistata in città. Sono rimasto in quel luogo circa un mese».
Poi finalmente una mattina all’una, all’improvviso i trafficanti vanno a cercarli per partire. Ma Michael non ha fortuna. Una motovedetta della guardia costiera saudita blocca la sua nave. Non li fa attraccare e li rimanda in Sudan. Da allora Michael diventa come un pacchetto, espulso dai diversi paesi che ha attraversato. Lo portano a Nguigmi, in Niger al confine con il Ciad.
Ma lui non si arrende. «Allora mi sono detto, passerò dall’Algeria per andare in Francia». Dopo aver lavorato riesce ad attraversare il Sahara e arrivare a Oran, città algerina sulla costa. Qui trova un lavoro per mettere insieme un po’ di soldi ma «una sera, uscito dal lavoro, mi ferma una pattuglia della polizia. Io non avevo i documenti. Mi hanno portato all’ufficio immigrazione. Chiesi che cosa avevo fatto, ma mi dissero che dovevo partire. Volevo passare da casa a prendere le mie cose, ma non lo consentirono». Rinchiuso in un locale con altri clandestini, dopo alcuni giorni Michael viene messo su un camion «quelli che portano fino a 150 persone», e trasferito verso Sud. I migranti respinti sono quindi scaricati in Niger, nei pressi della frontiera. In qualche modo arriva poi a Niamey. «Qui la situazione è peggiorata, non riesco a trovare lavoro. Ho deciso di tornare in Liberia ma non posso arrivare senza un soldo. Nel mio paese la guerra ha rovinato tutto, ha ucciso i miei genitori. Anche per questo me ne sono andato».

Famiglia migrante
Nella parrocchia di Garbado, questa mattina ci sono una decina di persone. Tutti uomini o ragazzi. Unica eccezione è una famiglia, padre, madre e bimba piccola. Accettano di parlarci.
 Biko (nome di fantasia) parla un ottimo francese. Lui e la famiglia vengono dal Ciad, in particolare da Ndjamena, anche se, ci tiene a precisare, sono originari del Sud, Doba, dove ci sono i pozzi di petrolio. Lui ha tentato più volte di studiare giurisprudenza all’università, nel vicino Camerun. Prima nel 2007, poi dieci anni dopo. In entrambi i casi ha dovuto lasciare a causa delle cattive condizioni di sicurezza.
Biko (nome di fantasia) parla un ottimo francese. Lui e la famiglia vengono dal Ciad, in particolare da Ndjamena, anche se, ci tiene a precisare, sono originari del Sud, Doba, dove ci sono i pozzi di petrolio. Lui ha tentato più volte di studiare giurisprudenza all’università, nel vicino Camerun. Prima nel 2007, poi dieci anni dopo. In entrambi i casi ha dovuto lasciare a causa delle cattive condizioni di sicurezza.
Biko è molto critico con il suo paese: «Sono nato nella guerra, cresciuto nella guerra e le conseguenze sono nefaste, non mi hanno permesso di studiare». La famiglia è composta anche da altri tre figli, ci raccontano entrambi, di 10, 6 e 4 anni. L’ultima, qui con loro, ne ha 2. «Sappiamo che è un rischio lanciarsi in una migrazione con una grande famiglia. Ma ci ha spinto il fatto che il nostro paese non è stabile. La gente vive sempre in mezzo a conflitti armati, intercomunitari, c’è la repressione dei governi, la cattiva gestione. Le ricchezze del paese non sono condivise in modo che tutti ne beneficino per vivere in pace».
La moglie, Evelyn, in un francese più impacciato, aggiunge: «Abbiamo lasciato il Ciad per cercare una vita migliore per noi e i nostri figli. Il nostro obiettivo è cercare fortuna in Marocco». E continua raccontando il loro viaggio, iniziato quasi un anno fa: «Siamo partiti da Ndjamena con un camion e siamo arrivati in Nigeria. Poi da lì è stato complicato, anche a causa della polizia. Abbiamo spesso dovuto negoziare e alla fine abbiamo pure perso i documenti». Entrati in Niger si sono diretti a Nord, fino ad Agadez, la città nigerina alle porte del Sahara, nella quale tutti i flussi dei migranti s’incontrano: da Est, da Sud e da Ovest. E dalla quale si parte per l’Algeria o la Libia. Qui, qualcuno in «uniforme» ha avuto compassione della famiglia e ha sconsigliato loro di proseguire: «Con questi bambini farai la loro tomba nel deserto», hanno detto. E poi li ha aiutati a tornare a Niamey.

Tra l’incudine e il martello
«Siamo qui da quasi otto mesi – dice Biko -, i bambini non vanno a scuola, e non abbiamo neppure una casa. Viviamo all’aperto. Quando piove ci lasciano mettere sotto una tettoia adibita a moschea, poi però dobbiamo sloggiare. Non abbiamo provato a fare i visti per il Marocco, perché non so come fare e non ho soldi. Non abbiamo più nulla».
Chiediamo alla coppia se non pensano sia meglio tornare in Ciad. Risponde Biko: «Sì, ma abbiamo paura di quello che succede nel nostro paese, in particolare il terrorismo. Inoltre mi hanno detto che se sei stato all’estero più di tre mesi, quando ritorni ti sospettano di terrorismo. Devi giustificare cosa hai fatto, altrimenti ti sospettano di essere con Boko Haram. Siamo tra l’incudine e il martello».
Il Ciad fa parte della coalizione militare con Niger, Nigeria e Camerun, che combatte i terroristi di Boko Haram (Cfr. MC ottobre 2016). La capitale Ndjamena è molto vicina al Nord Est della Nigeria, zona storica di questo gruppo che ormai interviene nei quattro paesi nei pressi del lago Ciad.
L’amaro in bocca
 Dopo aver parlato con diversi ragazzi, ascoltato le loro storie incredibili, di viaggi e di atrocità subite, prendiamo la nostra telecamera e li salutiamo. Sono contenti di aver condiviso la loro storia con noi, nonostante all’inizio ci fosse una certa diffidenza. Ce ne andiamo con l’amaro in bocca, per non potere far nulla di più che scambiare gli indirizzi mail. Biko ci scriverà una mail qualche tempo dopo. Alla fine sono rientrati in Ciad attraverso l’aiuto dell’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni). Ora stanno aspettando degli aiuti per la «reintegrazione».
Dopo aver parlato con diversi ragazzi, ascoltato le loro storie incredibili, di viaggi e di atrocità subite, prendiamo la nostra telecamera e li salutiamo. Sono contenti di aver condiviso la loro storia con noi, nonostante all’inizio ci fosse una certa diffidenza. Ce ne andiamo con l’amaro in bocca, per non potere far nulla di più che scambiare gli indirizzi mail. Biko ci scriverà una mail qualche tempo dopo. Alla fine sono rientrati in Ciad attraverso l’aiuto dell’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni). Ora stanno aspettando degli aiuti per la «reintegrazione».
Epilogo
Torino, due settimane dopo.
È sera. Sto rincasando, quando sul bordo della strada scorgo un ragazzo africano che fa l’autostop. Mi fermo e lo carico.
Mi ringrazia. Subito un odore dolciastro invade l’abitacolo. Deve essere qualche profumo che utilizza. È un ragazzo molto giovane, con lo smartphone e le cuffiette. Come tutti i giovani ascolta musica. Dopo i primi minuti di silenzio gli chiedo come si chiama e da dove viene. «Vengo dalla Sierra Leone e mi chiamo Jo».
«Freetown?», chiedo io. Il nome della capitale del suo paese lo fa sussultare: «Sì – risponde sorridente – la conosci?».
Ammetto: «Non ci sono mai stato, ma conosco dov’è. Io ho vissuto in West Africa, in Burkina Faso». Il giovane si scioglie, nel tempo di un istante si crea una sorta d’intesa. Mi racconta che è in Italia da due anni e due mesi, e lo dice con precisione. Ha fatto il viaggio del deserto e poi del Mediterraneo. Ce l’ha fatta, lui. «Mi trovo bene qui», garantisce in un italiano mediocre.
Le nostre strade si dividono e lo deposito sul marciapiede. È molto contento e non fa che ringraziare. Lo saluto e vado via veloce nella notte. Ma subito penso a Michael, Biko, Evelyn e gli altri. I suoi conterranei che meno di due settimane fa ho incontrato a Niamey. Infognati in una terra di mezzo, senza più soldi e senza speranza. Con il sogno di una vita migliore infranto e nessuna voglia di tornare a casa a mani vuote. Loro non ce l’hanno fatta.
Marco Bello
con la collaborazione di Sante Altizio

Incontro con l’arcivescovo di Niamey
Essere luce nella società
La piccola ma vivace chiesa cattolica del Niger ha due pastori: monsignor Laurent Lompo e mons. Ambroise Ouedraogo. Il rapporto con l’islam è vitale, così come la comunione con le chiese protestanti. L’insegnamento è un canale importante per diffondere i valori della pace e della tolleranza, mentre la Caritas interviene in aiuto di tutti.
Incontriamo monsignor Laurent Lompo nei suoi uffici dell’arcidiocesi di Niamey. Lo avevamo conosciuto nel 2015, fresco di nomina. Lui è il primo vescovo nigerino del Niger (MC dicembre 2015).
Da quando hanno rapito padre Pierluigi Maccalli nella sua parrocchia nei pressi del confine con il Burkina Faso, il 17 settembre scorso, le preoccupazioni sono aumentate. E le riunioni di coordinamento pure. Ha poco tempo, ma accetta di parlare con noi. Notizie del missionario non ce ne sono. O meglio, il silenzio stampa è d’obbligo, per non disturbare eventuali trattative per il rilascio.

Rispetto alla problematica migratoria, cosa fa la chiesa del Niger?
«Sia nella diocesi di Niamey che in quella di Maradi abbiamo creato delle “cellule di ascolto”, per i migranti che passano. Perché il Niger è un paese di passaggio. Molti sono rimandati indietro da Algeria e Libia, tornano qui in capitale ma vogliono ripartire. Noi facciamo la pastorale dell’ascolto. Perché sono persone ferite, e credevano che migrando qualcosa sarebbe cambiato. Ritornano e sono scoraggiati. Il primo aspetto è dunque ascoltarli e ridare loro il gusto della vita e la dignità di persone. Non è perché siamo migranti che non siamo persone. Siamo pellegrini sulla terra e ognuno è chiamato ad andare all’incontro dell’altro. Il fenomeno migratorio che aumenta nei nostri paesi è il segno che le difficoltà portano la gente a cercare qualcosa in più. Ma sarà la migrazione a dare questo di più? Dobbiamo mettere il focus sui nostri paesi e su come fare in modo tale che la vita delle persone sia decente. Affinché il viaggio sia deciso effettivamente perché vogliono partire e non perché non hanno nulla e sono costretti a spostarsi.
Dobbiamo prendere la migrazione in questo doppio senso: chiunque ha diritto di viaggiare, ma se partiamo perché siamo costretti, perché non abbiamo nulla per vivere, forse dovremmo restare, qualunque sia la condizione. La maggior parte della gente che parte non ha mezzi e non sa dove andare. Molti ritornano. È con loro che lavoriamo cercando, con i mezzi che abbiamo, di ascoltarli, aiutarli a ritornare ai loro paesi. Alcuni trovano del lavoro qui, ma in Niger c’è disoccupazione, è difficile. In ogni caso noi cerchiamo di accompagnarli, soprattutto per fare in modo che ritrovino il loro equilibrio come esseri umani».
Come Chiesa, in un paese islamico, cosa fate per il dialogo interreligioso?
«Facciamo molto per il dialogo, soprattutto a partire dalla base, non solo a livello dei grandi leader. Ovvero partiamo dalle persone comuni affinché la coabitazione tra cristiani e musulmani sia buona, si abbia conoscenza di se stessi e dell’altro e ci sia mutuo rispetto. E facciamo molto attraverso una Commissione per il dialogo interreligioso e intra religioso, che ha intensificato i lavori in questi ultimi anni. Nella commissione ci sono cristiani evangelici e cattolici, e lo facciamo in direzione dei fratelli musulmani, che sono più forti. Abbiamo bisogno di stare insieme, perché siamo tutti figli di questo paese e più ci rispettiamo, più la pace avviene nel cuore, più viene nella società nigerina.
Abbiamo fatto diversi seminari su questi temi, uno nel 2016 sul dialogo, e un altro a novembre scorso concentrandoci sulla gioventù, che è uno strato sociale fragile, e manipolabile a tutti i livelli. Diciamo che se i giovani sono integrati, capiscono la propria fede, se hanno un’apertura verso il dialogo, allora noi costruiamo la pace nel nostro paese».
Lavorate molto con i musulmani, e frequentano le vostre scuole?
«Nelle nostre scuole la maggioranza degli insegnanti è musulmana, e non abbiamo avuto mai difficoltà. Tramite l’insegnamento cerchiamo di educare a dei valori che ci permettono di rispettarci gli uni gli altri, e a valori della vita che permettano a questi bambini, finita la scuola, di avere questa apertura.
A livello della Caritas del Niger, lavoriamo molto con i musulmani e i nostri aiuti sono indirizzati a tutta la popolazione senza alcuna distinzione etnica e religiosa. Operiamo per il bene di tutti. E tutti apprezzano questo nostro lavoro ancora di più, perché non facciamo proselitismo».
C’è anche l’islam radicale che si diffonde nella regione. In Niger ci sono stati episodi di violenza anticristiana nel 2015, quando alcune chiese furono date alle fiamme. Cosa fare?

«Sentiamo che un certo islam si sta radicalizzando. La gran parte sono persone che vengono da fuori, legate a certe scuole coraniche. Ma sia da parte del governo che della chiesa, lottiamo affinché l’islam nella sua generalità non prenda la forma dell’islam radicale, per evitare che ci siano dei conflitti. Facciamo questo sforzo. Negli avvenimenti del 16 e 17 gennaio 2015, non abbiamo accusato la comunità musulmana. I responsabili erano persone manipolate. Noi lavoriamo affinché questo non accada, sia da parte dei cristiani, sia dei musulmani, perché il radicalismo si può vivere in tutte le religioni. È la comprensione estremista delle nostre religioni che chiude le porte all’apertura all’altro. La negazione dell’altro rispetto a noi: è questo che porta conflitto. Noi facciamo di tutto affinché questo non capiti, non raggiunga i diversi strati sociali. E vegliamo, nelle nostre due diocesi, che si mantenga tra i cristiani uno spirito aperto e non si generalizzi rispetto all’islam. Il radicalismo, qualsiasi sia il gruppo da cui nasce, diventa un qualcosa che interroga e inquieta».
Mons. Laurent, lei è il primo vescovo del Niger di nazionalità nigerina. Chi sono i cattolici in questo paese?
«I cattolici sono presenti in Niger dal 1932 e penso che essi abbiano contribuito molto all’educazione in questo paese. Attraverso l’insegnamento, attraverso il dialogo della vita, la vicinanza alla popolazione. E continuiamo, malgrado il nostro numero limitato, a essere luce in questa società attraverso il lavoro ben fatto, il rispetto e l’accoglienza dell’altro senza pretese di convertire. Proclamiamo la nostra fede in Gesù Cristo che è il centro della nostra vita. Noi cerchiamo di imitarlo vivendo come lui ha vissuto, stando vicini alla gente come faceva lui.
Collaboriamo molto con le altre chiese, le chiese protestanti evangeliche, da qualche anno sentiamo un certo ecumenismo. Questo è importante per noi, perché siamo minoranze in un periodo difficile, allora ci uniamo per proclamare la nostra fede, restando aperti al popolo nigerino. Facciamo questo sforzo e siamo molto contenti della collaborazione con gli evangelici.
Realizziamo diverse attività insieme. Vogliamo che la nostra unità interroghi, in modo da essere portatori della buona notizia in questo popolo».
Che rapporti avete con le chiese vicine?
«Siamo in Conferenza episcopale con il Burkina quindi collaboriamo molto con loro. Abbiamo rapporti con la chiesa della Nigeria. Ci hanno chiesto come fare per vivere ancora più vicini ai nostri fratelli musulmani. Siamo stati io e monsignor Ambroise Ouedraogo (vescovo di Maradi) nella diocesi di Jos e siamo stati meravigliati nel vedere il lavoro che fanno i vescovi. Continuiamo nella stessa linea per essere anche noi portatori di pace nel nostro paese. Collaboreremo, perché condividiamo le stesse esperienze. Abbiamo avuto contatti anche con la chiesa algerina per le questioni della migrazione. Perché loro lavorano sul tema, e il passaggio di migranti in Algeria è importante».
Marco Bello
Archivio MC – Niger
• Marco Bello, «Ci legavano con corde e catene», aprile 2018.
• Marco Bello, Niger, frontiera d’Europa, marzo 2018.
• Marco Bello, Chiesa, dialogo contro terrore, dicembre 2015.