Anche noi torniamo a parlare di migranti – sia profughi che migranti economici – dopo una drammatica estate di arrivi in Europa di decine di migliaia di persone dal vicino Oriente (Siria, in primis), dall’Africa, ma anche dall’Asia. L’Europa, divisa e litigiosa, si è letteralmente liquefatta davanti al problema. In queste pagine affrontiamo la questione con due reportage, un’analisi delle cause e un commento.
Il primo reportage è dal Cara di Mineo, la struttura in provincia di Catania, dove vengono accolti migliaia di migranti in attesa di identificazione. Il secondo viene dalla Puglia dove molti migranti sono impiegati nei lavori agricoli, quasi sempre in condizioni disumane. L’analisi di Maurizio Pallante esamina le cause delle migrazioni evidenziando un fatto mai preso in esame: è il modello economico della crescita infinita – spiega l’autore, teorico della decrescita – che produce spostamenti di popolazioni. Infine, il nostro collaboratore Gian Carlo Caselli, nella sua veste di presidente del comitato scientifico dell’«Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare», affronta il tema delle agromafie e del caporalato. Passando dal pomodoro «made in China» allo sfruttamento di donne e uomini, in particolare extracomunitari, nelle campagne italiane.

Reportage 1 / al Cara di Mineo (Catania)
Volti e storie dal vaso di Pandora
Un tempo era il villaggio residenziale dei soldati statunitensi di Sigonella, oggi è il «Centro accoglienza richiedenti asilo» (Cara). Famoso e controverso (anche per alcuni gravi fatti di cronaca), lo abbiamo visitato parlando con chi vi lavora e con chi vi è ospitato.
Catania, estate 2015. Al mattino presto ci rechiamo in una via vicino alla stazione ferroviaria, dove sono parcheggiate diverse auto con a bordo immigrati dell’Africa subsahariana. Sono tassisti abusivi che trasportano i rifugiati ospiti del Cara – Centro accoglienza richiedenti asilo – da Mineo a Catania, per le spese e altre commissioni giornaliere. Dopo aver contrattato il prezzo del passaggio, saliamo a bordo di un vecchio veicolo, pieno di persone.
Mineo dista un’ora da Catania. L’autista, Amin, un senegalese di 42 anni, ci racconta che talvolta lui e i suoi colleghi vengono fermati dalle forze dell’ordine, e multati per eccesso di passeggeri. Per il resto, nessuno dice nulla. Sono tre anni che fa questo lavoro e inizia a essere stanco: troppi rischi per via delle auto scassate, e poco guadagno. Sono in troppi a contendersi i viaggi da e verso il Cara: diciotto auto che lavorano dal mattino alla notte. I tassisti sono prevalentemente nigeriani, libici o senegalesi come Amin.
Il Cara è allestito nell’ex villaggio residenziale dei soldati statunitensi di stanza a Sigonella: un’ampia area nel «deserto» catanese, distante 10 km da Mineo, delimitata da filo spinato e controllata da esercito e polizia. Si entra e si esce solo con i permessi. Mentre aspettiamo l’autorizzazione a visitarlo, diversi ragazzi escono per raggiungere Catania o le aziende agricole attorno. La permanenza nel campo dovrebbe essere di circa sei mesi – in attesa del processo per lo status di rifugiato -, ma molti vi rimangono anche un anno o più.
Sono circa 3.000 i richiedenti asilo attualmente presenti nel Cara: arrivano dalla Nigeria, dal Gambia, dal Mali, dal Senegal, dal Ghana, dalla Costa d’Avorio, dalla Guinea Bissau, dalla Somalia, dalla Sierra Leone, dal Niger, dall’Egitto, dalla Libia, dall’Eritrea, ma anche da paesi non africani come il Pakistan e il Bangladesh. Per alcuni migranti lo status di profugo non arriverà mai, poiché, di fatto, non giungono da un paese in guerra o non possono dimostrare di essere perseguitati.
In Libia, con e dopo Gheddafi
Il campo è costituito da diverse case a schiera disposte su viali paralleli e da altre strutture adibite a mensa, moschea e chiesa, laboratori, uffici, scuola, ambulatorio, lavanderia, ecc. È organizzato con un esercito di operatori: sono 400 tra mediatori, assistenti sociali, medici, psicologi, avvocati, addetti alla mensa e alle pulizie.
Ci riceve il direttore del centro, Sebastiano Maccarrone, il quale ci spiega che molti degli ospiti, prima di arrivare in Europa, avevano lasciato il proprio paese per trovare lavoro in Libia. Molti, negli anni precedenti la «primavera libica» che ha rovesciato il regime di Muammar Gheddafi nel 2011, si erano ben inseriti a livello professionale e sociale. Con lo scoppio della rivolta, tuttavia, sono iniziati i problemi: persecuzioni a causa del colore della pelle, lavoro forzato, violenze, prigionia, stupri.
A migliaia, nel 2011, sono fuggiti verso le coste italiane, cercando salvezza dalle aggressioni sistematiche da parte di bande di militari di fazioni diverse: era l’«emergenza Nordafrica». Un’immigrazione di massa straordinaria ma prevedibile, vista la situazione di guerra civile in Libia.
All’emergenza delle persone immigrate nel paese nordafricano per scappare da guerre e persecuzioni si è affiancata, nei mesi e negli anni successivi, e fino ad oggi, un’altra forma di fuga: quella delle vittime del lavoro in schiavitù. È gente che viene costretta a pagare per andarsene o che è costretta a salire sui barconi da sfruttatori che, dopo averli utilizzati come manodopera gratuita, al momento di retribuirli, consegnano 2.000 euro agli scafisti per sbarazzarsi di loro. Molti di quelli che ora raggiungono le coste della Sicilia su gommoni scassati sono ancora lavoratori africani che fuggono dalla Libia post-Gheddafi. Altri, invece, si sono trovati a transitare nel paese nordafricano per tentare di passare in Europa. Tutti, indistintamente, sono finiti nelle mani di bande armate che li hanno catturati, picchiati, sfruttati, violentati e poi imbarcati a caro prezzo.
«Arrivano tutti dal caos libico – sottolinea il direttore del Cara Maccarrone -, perché con gli altri paesi del Nordafrica, come la Tunisia e il Marocco, abbiamo accordi bilaterali in base ai quali chi arriva da lì in Sicilia viene rimandato indietro. Il problema con la Libia è che manca un governo centrale con cui fare accordi. I migranti partono da vari porti. La vera questione è politica ed è internazionale: bisogna che i responsabili del colonialismo in Africa – principalmente Francia, Gran Bretagna e Usa – si occupino di questa drammatica situazione. L’Italia sta facendo un enorme sforzo».
Il direttore Maccarrone ci fa accompagnare nelle strutture del campo da una mediatrice, una giovane marocchina poliglotta. Sono terribili le storie che ci raccontano i rifugiati sulle condizioni di trattamento in Libia: descrizioni dettagliate di riduzione in schavitù e di violenze, possibili grazie al caos politico e sociale in cui è precipitata la Libia «post-primavera». Un paese senza un governo centrale – ne ha due, rivali, a Tobruk e Tripoli – e con milizie armate dovunque, Isis compreso.
Le donne dell’Africa subsahariana che si trovano a transitare in Libia vengono stuprate, portate nelle case dei ricchi e abusate. Ragazzi e uomini subiscono ogni sorta di violenze nelle carceri, che periodicamente vengono «ripulite» mandandoli sui barconi a morire in mare.
Jean Baptiste ha 22 anni e viene dalla Costa d’Avorio: è uno dei sopravvissuti al naufragio dell’aprile 2015 che uccise 800 persone. «Ho viaggiato da Tripoli all’Italia in un barcone. Avevo lasciato il mio paese all’inizio del 2014 per cercare un lavoro dignitoso in Libia. Lì i lavoratori immigrati li pagavano bene, ma a me è andata diversamente: sono finito in prigione, catturato per strada da milizie armate. Non so dire se fossero poliziotti, militari o bande criminali. In carcere ho sofferto per le violenze e i maltrattamenti. C’è razzismo contro gli Africani neri. Soffrono tanto in Libia. Non sono considerati come esseri umani».
Khalifa, 25 anni, è un musulmano di Gao, in Mali. È arrivato in Sicilia con Jean Baptiste, in aprile. «Ho lasciato il Mali nel 2010 e sono arrivato in Algeria, dove ho vissuto fino al 2012, quando ho raggiunto la Libia e sono riuscito a trovare un lavoro. Ero con mio fratello. Stavamo bene, lavoravamo per un datore di lavoro libico onesto. Purtroppo è stato ucciso da un gruppo armato e io ho dovuto cercare un altro lavoro. Così sono cominciati i miei problemi: il nuovo capo non mi pagava e quando ho iniziato a lamentarmi, mi ha consegnato a una banda di criminali, dei trafficanti, che mi hanno sfruttato. Sono finito in prigione, dove ero picchiato tutti i giorni. I carcerieri ci dicevano: “Non ci sono abbastanza cimiteri in Libia: vi faremo morire in mare”. Ci hanno costretti a imbarcarci su un peschereccio sgangherato, che è affondato con 800 persone a bordo. Soltanto in 28 siamo riusciti a sopravvivere. Mio fratello e tutti i miei amici sono morti annegati nel Mediterraneo». A questo punto, Khalifa interrompe la sua storia e scoppia in lacrime.
Le storie dei rifugiati sono simili tra loro: lunghi percorsi nel deserto, per arrivare in Libia o a lavorare o allo scopo di imbarcarsi per l’Europa, maltrattamenti, sfruttamento, violenze, tratta. Sono così somiglianti che sorge persino il dubbio che chi le racconta abbia mandato a memoria un copione per convincere chi li accoglie in Italia a occuparsi di loro e avviare la richiesta di asilo.
Chiediamo dunque agli psicologi, assistenti sociali e legali presenti nel centro di confermarci le storie ascoltate, e anche loro ci parlano di violenze, razzismo, stupri, mancanza di cibo e acqua, forme di lavoro schiavo e imbarchi forzati. «Sono tre anni e mezzo – ci racconta un’assistente sociale – che ascoltiamo storie terribili. Anche di lavoratori che prima stavano bene e che successivamente si sono trovati ai “lavori forzati” per un periodo e poi sono stati mandati via. Vengono sfruttati per mesi e quando non servono più li mettono in mare, verso l’Europa. È un esercizio di strapotere su migranti indifesi. Alcuni vengono liberati dal carcere per lavorare gratis. Dalla caduta del regime libico è iniziato questo caos. Detto in altre parole: Gheddafi dava garanzie nel Mediterraneo».
Dai barconi alla cronaca nera
Il Cara ha acquisito notorietà non solo perché è il più grande centro per richiedenti asilo d’Europa, ma anche per fatti di cronaca che hanno provocato orrore: a fine agosto, a Catania, sono stati trovati i cadaveri di due anziani. Poche ore dopo è stato arrestato un giovane della Costa d’Avorio, fuggito dal centro di accoglienza di Mineo. «“Il Cara di Mineo crea problemi che noi dobbiamo gestire con poco personale, facendo fronte all’emergenza”, ha commentato il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, che cornordina l’indagine sul duplice omicidio. “È stato un delitto efferato – ha aggiunto – macabro, con una scena del delitto incredibile. [….]”. L’indagine però è tutt’altro che chiusa: l’ipotesi degli inquirenti è che l’ivoriano non abbia agito da solo ma abbia avuto dei complici, altri extracomunitari che la polizia di Stato sta cercando di individuare» (Il Fatto Quotidiano, 30 agosto).
Ancora cronaca giudiziaria legata a rifugiati accolti e poi fuggiti dal Cara: a settembre, a Worms, in Germania, viene arrestato un eritreo, Mulubrahan Gurum, che gestisce i soldi del lucroso traffico umano tra la Libia e l’Europa. Con questo arresto, finalmente anche i media mainstream iniziano a parlare in modo esplicito di tratta di esseri umani, di immensi guadagni, di organizzazioni criminali internazionali con ramificazioni dalla Libia (e da altre regioni africane) all’Europa: «“Dell’importo del viaggio, tra i 2.000 e i 2.500 dollari, solo il cinque per cento viene versato in contanti in Libia. Il resto deve essere pagato estero su estero. E per la conferma del buon esito è sufficiente un sms”. Il saldo, per quello che sin qui ha potuto ricostruire l’indagine della procura di Palermo, arriva normalmente in paesi come Germania, Svezia, Norvegia e Inghilterra. E qui raccolto da cassieri che provvedono a riciclarlo. Nelle intercettazioni si fa persino generico riferimento a “banche internazionali”, a trasferimenti “da Dubai all’Europa, così evitiamo i controlli”. A cambi da dollari in euro e viceversa. E del resto quello che dice Ermias Ghermay (uno dei personaggi coinvolti nell’inchiesta della magistratura palermitana, ndr) al telefono lascia intuire di quali ordini di grandezze si parli: “Ho guadagnato così tanti soldi da vivere benissimo per 20 anni, per ogni barca che mando verso l’Italia guadagno 80 mila dollari”» (la Repubblica, 12 settembre).
Il piccolo Aylan e gli altri
Quella degli ultimi anni è un’onda migratoria anomala, fenomenica (nel senso di eccezionale rispetto ai flussi fisiologici di migranti ante Primavere arabe, cioè prima del 2011), che sposta masse di persone da un continente all’altro, che provoca migliaia di morti e frutta miliardi di dollari alle organizzazioni criminali internazionali. Parallelamente, ma non disgiuntamente, ridisegna, piano piano, un’altra Europa, con altre popolazioni.
La maggior parte dei profughi di questi ultimi anni arriva da paesi come Iraq, Libia, Siria, Palestina, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Eritrea, Etiopia, Sudan, distrutti dalle guerre occidentali (volute da Usa, Canada, Gran Bretagna, Francia, Italia, ecc.) e da quelle orientali (condotte da Turchia, Israele, Qatar, Arabia Saudita). In molti fuggono anche dallo «Stato Islamico di Iraq e Siria» (Isis), nato in seno al wahabismo saudita (alleato dell’Occidente) e da esso appoggiato e finanziato.
E ora le stesse immagini di migliaia di persone che attraversano a piedi confini e barriere nazionali o quella toccante di Aylan, il piccolo curdo di Kobane, morto sulla spiaggia turca di Budrum, vengono usate strumentalmente per creare il consenso a nuove invasioni e conflitti (contro la Siria di Assad, ad esempio) .
Rifugiati e immigrati sono oggetto di un immenso business che va dalla tratta di esseri umani reclutati nei villaggi e nelle città di diversi stati africani, all’allestimento dei viaggi sui barconi che attraversano il Mediterraneo e arrivano in Europa. Lucrano su questo traffico sia gruppi islamisti jihadisti (come accade in Libia, in Mali e in diverse altre regioni africane) sia organizzazioni criminali e mafiose locali e internazionali, e pure politici e rappresentanti di governi.
Una volta in Europa, inizia l’altrettanto redditizia gestione dell’accoglienza dell’immigrato: fondi ingenti stanziati dall’Unione Europea e destinate agli stati, e da questi, in certi casi, a amministrazioni comunali o cornoperative.
Parallelamente, c’è anche la consistente immissione nel mercato del lavoro – agricolo, commerciale, industriale – di manodopera disperata e a basso costo e lo sviluppo di nuove forme di lavoro subordinato, caratterizzato da condizioni disumane, o di semi schiavitù.
Infine, le bande criminali vedono nell’immigrato emarginato una potenziale manovalanza a buon mercato per lo spaccio, la prostituzione, ecc. Basti pensare che le mafie italiane già da tempo investono sul traffico di esseri umani, ritenuto più lucroso di quello della droga.
Nel Nord come nel Sud dell’Italia, molte campagne si riempiono di africani che, in cambio di paghe da fame, raccolgono pomodori e altra frutta che arriveranno sugli scaffali dei nostri supermercati e sui banconi dei mercati. Mentre di notte le strade delle città sono affollate di giovanissime donne nere, vittime della tratta del sesso. Forse l’ultimo gradino dello sfruttamento senza fine dei popoli colonizzati dall’Occidente.
Angela Lano*
(*) Ricercatrice presso l’Università Federale di Salvador di Bahia (Ufba); articolo inserito in un progetto di ricerca sulla Libia sostenuto dalla «Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia» (Fapesb), Brasile.

Reportage 2 / Nelle campagne della Puglia
Siamo uomini… o caporali?
È una vera baraccopoli a 15 km da Foggia. Con baracche, ristoranti e bordelli. Vi abitano decine di lavoratori dell’Africa dell’Ovest. È qui che i caporali reclutano la mano d’opera. Qui occorre ingegnarsi in mille lavori. C’è pure una radio che dà voce a progetti e speranze. Reportage dal Ghetto.L’uomo senegalese ha la barba corta. In una tinozza da bucato di plastica azzurra prepara dieci chili di pastella ogni giorno, un enorme blob di schiuma morbida e chiara. Sta seduto su uno sgabello e la prende su a cucchiaiate, poi la getta in una padella di olio bollente che la gonfia e la indora, a trenta o quaranta alla volta, fino a trasformarla nei beignet più buoni di tutta la baraccopoli. «Durano fino a 35 giorni se li tieni chiusi nel sacchettino», gongola, con l’orgoglio della massaia che svela parte dei suoi segreti: «E questo perché dentro non c’è una goccia d’acqua. Solo latte e uova». Una porzione da due, in un sacchetto di plastica trasparente usa e getta, costa cinquanta centesimi.
In un altro angolo della stessa baracca di lamiera, grande, buia e non ancora rovente come sarà da mezzogiorno al tramonto, Maimuna prepara il soffritto. Ha quarantacinque anni, la pelle liscissima, occhi scuri, tunica colorata e capelli coperti da un turbante voluminoso. Il resto dell’anno fa la badante o le pulizie a Bologna. D’estate squama il pesce e cuoce il riso nella baracca di Papa Diop, senegalese, uno dei ristoratori storici del ghetto.
Pochi metri più in là, sotto il portico di lamiera e legno, affacciato sul «viale» principale, ecco Mamadou a lavorare di mannaia, per fare a pezzi la pecora che più tardi Maimuna bollirà. D’inverno, Mamadou vende le torri pendenti ai turisti, a Pisa in piazza dei Miracoli. D’estate spacca le ossa degli ovini al gran Ghetto di Rignano Garganico.
La chiamano tutti così la baraccopoli, a soli quindici chilometri dal centro di Foggia, che dà alloggio a circa duemilacinquecento braccianti. Sono quasi tutti dell’Africa occidentale francofona, lavorano nella raccolta del pomodoro e degli altri prodotti delle campagne della zona.
I braccianti vivono in baracche di plastica e cartone. Si alzano presto la mattina, i primi anche alle tre, per aspettare i «capi neri», i caporali che fanno da intermediari con le aziende agricole della zona, organizzano le squadre di lavoro e le trasportano su vecchi furgoni scassati, quasi sempre rubati, spesso con targhe bulgare o rumene.
Le pecore e i caproni che i macellai comprano da un pastore poco distante, vivono pure loro al Ghetto, almeno gli ultimi giorni della loro vita. Stanno legati per una zampa in recinti a cielo aperto, con le pareti fatte di vecchie porte e finestre di legno, recuperate da discariche e robivecchi. Qualcuna tenta di scappare, ma nessuna, alla fine, sfugge al boia, che arriva con la coca cola in una mano e il coltellaccio nell’altra, e non rinuncia a rispondere al cellulare nemmeno quando ha davanti la pozza di sangue appena uscita dalla giugulare della bestia.
Tutto quello che si potrà, finirà mangiato. Le ossa serviranno a fare il brodo. La pelle scuoiata giacerà ammucchiata su una delle tante cataste di rifiuti che nessuno dei comuni circostanti – Foggia, Rignano Garganico, San Severo – accetta di venire a raccogliere. I residenti del ghetto finiscono per bruciarle quasi ogni giorno: al puzzo di carcassa subentra quello di diossina e si libera spazio per la spazzatura dell’indomani.

Vita in baraccopoli
Prima di essere buttato, quasi tutto è stato riutilizzato e riciclato fino all’inverosimile. Le bottiglie di plastica della minerale si riempiono decine di volte dalle grandi taniche dell’acqua potabile, che a loro volta sono riempite da una cisterna, ogni mattina (pagata dalla Regione Puglia). Le bottigliette dei detersivi o delle bibite servono anch’esse per l’acqua, quella non potabile, da usare per lavarsi. La si attinge a uno dei tre punti di raccolta installati tra le baracche, circondati sempre da fango fresco e rozze canaline di scolo per contenere gli allagamenti.
Quando qualcuno si allontana verso i campi, con in mano un flacone verde che era stato di Nelsen piatti, sta quasi certamente andando a pregare, prostrato nella polvere, dopo le abluzioni rituali. Oppure a defecare, nei campi o negli uliveti, dato che i venti wc chimici installati all’ingresso del ghetto vengono puliti, da un uomo con un furgoncino cisterna e una pompa d’acqua, soltanto ogni due giorni (sempre a carico della Regione).
Esiste da circa vent’anni, ed è cresciuta ogni stagione con nuove abitazioni di fortuna, la spettacolare baraccopoli nota a tutti come il Gran Ghetto. Non è la sola città temporanea a dare riparo ai braccianti del Sud. Senza andare lontano, altri insediamenti di fortuna ci sono a Borgo Mezzanone e Borgo Tre Titoli in Puglia, o a Boreano in Basilicata.
Nei dintorni del Gran Ghetto quasi tutti i casolari, costruiti negli anni della riforma agraria e poi abbandonati, sono abitati, durante l’estate, dai braccianti impegnati nei lavori stagionali. Delle baraccopoli, il Gran Ghetto è la più grande, certamente tra le più longeve e sviluppate. Rimane abitata e in funzione anche per una parte dell’inverno per chi, oltre alla raccolta del pomodoro, lavora alla vendemmia o a quella delle olive. E molti braccianti arrivano già dalla primavera, per le verdure di serra, gli asparagi o i peperoni.
Da un anno all’altro, la plastica delle serre si ricicla come copertura delle baracche. Chi sa costruirle è in grado di metterne in piedi una piccola nel giro di un paio di giorni. Uno scheletro di legno e le pareti di cartone. E un tessuto connettivo fatto di vecchi tubi da irrigazione, su cui piantare migliaia di chiodi che, oltre a tenere insieme la struttura, servono ad appendere sacchi e zainetti per salvarli dalla polvere. Quando non raccolgono, i braccianti battono le campagne in cerca di materiali di scarto utili alla costruzione delle baracche.
Ce ne sono da otto o dieci posti, ma anche da trenta o quaranta, di proprietà dei caporali, che nella loro offerta logistica includono anche il luogo in cui dormire. Trenta euro, un materasso per l’intera stagione, con altri sette una rete a molle.
Sul modello base di baracca ci sono decine di varianti: doppio contro-soffitto in cartone, per isolarsi dal caldo straziante, e dal freddo che arriva già nelle notti di fine estate; oppure rivestimento di vecchie lenzuola, per rendere l’interno più accogliente. Il contro-soffitto in tessuto ce l’hanno soprattutto ristoranti e bordelli, che per il comfort dei clienti coprono anche i pavimenti con teloni in plastica. I più avviati hanno perfino le piastrelle.

Ristoranti, bordelli e caporali
Una ragazza guadagna dieci euro a cliente, e ne paga dieci al giorno di affitto al proprietario del locale. Al ghetto ce ne sono decine, si vedono poco perché dormono di giorno. Quasi tutte vengono dalla Nigeria.
I clienti non sono solo del Mali, del Burkina, del Senegal, del Gambia o della Guinea, come la maggior parte dei braccianti. Arrivano spesso al ghetto auto con targa italiana, guidate da uomini di mezza età, o da gruppi di amici anche molto più giovani. Dieci euro la ragazza. Un euro la birra da 33 cl, rinfrescata nei frigo alimentati dai generatori. Non più di tre euro un piatto di riso e carne, cereali o verdura, a scelta tra tante varianti di cucina africana, nella dozzina di ristorantini che si aprono tra strade e vicoli del ghetto.
Conveniente per gli italiani, la tariffa dei ristoranti rimane un lusso per molti abitanti del ghetto, pagati quasi sempre a cottimo e spesso in ritardo rispetto a quando il lavoro viene svolto. «Sono stanco, quest’anno parto appena riesco a farmi pagare», spiega Boureima, senegalese in attesa di una decisione sulla sua richiesta di asilo.
Negli ultimi giorni, ha lavorato in un’azienda agricola al taglio delle cipolle. Il pagamento in questo caso è orario, 2 euro e 75 centesimi per un’ora di lavoro, in piedi al nastro trasportatore. «Non ti lasciano riposare, neanche fermarti un momento per bere un sorso d’acqua, e allora ho deciso di smettere: aspetto i miei soldi e poi me ne torno a Roma», afferma, stufo di giornate lavorative di dieci ore in cui si guadagnano poco più di venti euro. Ogni bracciante, infatti, deve lasciare al «caporale» almeno cinque euro al giorno, per il trasporto dal ghetto al luogo di lavoro.
Funziona così anche per chi lavora nei campi di pomodori: cinque euro è la tariffa obbligatoria per farsi caricare, alle prime ore della mattina, su uno dei furgoni che, sferragliando tra nuvole di polvere, trasportano i braccianti fino al campo, stipati in venti o trenta alla volta su panchette di legno installate al posto dei sedili.
Per la raccolta del pomodoro, il pagamento è a cottimo, in base al numero di cassoni riempiti. Per un cassone da 300 kg di pomodori, il pagamento medio è di 5 euro, ma al bracciante ne restano in genere 3,50. Il restante euro e mezzo lo trattiene il caporale.
Quanto si guadagna in un giorno dipende da tanti fattori: le condizioni del terreno, la forma fisica del lavoratore, e anche quanti saranno i camion che in quella giornata arriveranno sul campo, per caricare 88 cassoni alla volta e trasportarli fino alle industrie che li lavorano per produrre la passata e i pelati.
«Se si lavora veloce e su terreno asciutto – spiega Yacouba – si possono riempire due cassoni in mezz’ora». Ma se il terreno è troppo asciutto, come nella secca estate 2015, per i braccianti spunta la concorrenza delle macchine raccoglitrici, che sostituiscono gran parte della manodopera.
Molti abitanti del Gran Ghetto non riescono a trovare da lavorare tutti i giorni.

Lavoro al Ghetto
Chi ha idee e altre capacità inventa qualcosa da fare nella vasta, sebbene povera, economia informale del ghetto: Soulimane taglia i capelli con un rasoio elettrico, su una sedia davanti alla sua baracca. «Mi piacerebbe aprire un vero salone», afferma, e ai clienti non fa mancare l’asciugamano posato sulle spalle per non sporcarsi la maglietta. Zaka si è costruito una baracca di lamiera in cui la sera brucia grandi tronchi di legno: riscalda l’acqua, a pagamento, per chi vuole prendersi il lusso di una doccia tiepida. Un giovane maliano ha una vecchia macchina per cucire Necchi. Una volta la settimana arriva il venditore di stoffe e lui si dà da fare come sarto. Nelle sere di luna piena si consuma un po’ meno la vista.
Camara, guineano, non ha capitale per avviare un’attività. Quando non lavora, si arrangia cucinando la cena per gli altri abitanti della sua baracca, che in cambio lo invitano a mangiare gratis.
Yaya si è infortunato sul lavoro. Gli è caduto addosso un cassone vuoto, il suo piede destro è gonfio come una palla da tennis. I medici del Polibus di Emergency, che quattro pomeriggi a settimana staziona davanti al ghetto, gli hanno prescritto iniezioni quotidiane. Per il weekend, quando il Polibus non c’è, gliele fa con mano sicura Angela, cuoca ivoriana, durante l’inverno badante in Sicilia. E alla fine gli sussurra all’orecchio, in francese: «Se non hai soldi, puoi mangiare a credito al mio ristorante». Lui invece qualche soldo lo trova: 10 euro dal caporale, come risarcimento per l’infortunio, assieme alla promessa di «un lavoro più leggero, alla macchina, quando sarai guarito». Altri 37, dall’albergatore campano che durante l’anno lo ospita come richiedente asilo. «È venuto a prenderci le firme, e ci ha portato il pocket money che ci spetta per quindici giorni», spiega Yaya: «Non solo a me, anche agli altri che abitano da lui e che sono qui al ghetto per la stagione». Per ogni due euro e cinquanta di «pocket money», la cifra giornaliera spettante a un richiedente asilo, l’albergatore ne riceve almeno trenta dallo stato. Stando al racconto di Yaya, anziché dichiarare che i suoi «ospiti» in questo periodo si sono allontanati e non gli costano nulla, l’albergatore preferisce farsi un giro in Puglia ogni due settimane a raccogliere le firme.
E così eccolo Yaya, sorridente nel cappello nuovo, altro regalo dell’albergatore. Le iniezioni hanno fatto effetto e quasi non ascolta il suo amico Amadou, ivoriano, che tenta di convincerlo che dieci euro sono un risarcimento irrisorio. Quasi impossibile avere il coraggio di denunciare quando si lavora a giornata, senza contratto. I pochi contratti esistenti sono falsi, non corrispondono alle giornate effettivamente lavorate.

La «voce» del Ghetto
«Il contratto agricolo provinciale prevede un pagamento di 7 euro e 92 l’ora, e un massimo di 6 ore e mezza di lavoro al giorno», spiega Yvan Sagnet, sindacalista della Flai Cgil, al microfono di Radio Ghetto. La radio è una baracca come le altre, si distingue per l’antenna che svetta in uno dei quattro angoli, legata a un palo di legno con pezzi di vecchie camere d’aria.
È aperta dalla tarda mattina fino a sera, e davanti ci sono sempre dieci o venti ragazzi. Qualcuno ci va solo per ricaricare il cellulare gratis, senza pagare i 50 centesimi che chiedono negozietti e ristoranti. Altri si improvvisano dj. Va per la maggiore il reggae africano, le voci ivoriane di Tiken Yah Fakoli o di Alpha Blondy, di cui si favoleggia che il terzo figlio viva al ghetto, e sia perfino un caporale.
Yvan, camerunense, è alla radio per condurre un dibattito sui diritti dei lavoratori. Prima di essere sindacalista è stato pure lui bracciante, nella zona di Nardò, in provincia di Lecce. Studiava ingegneria a Torino, era sceso per la stagione, per tirare su qualche soldo, e aveva finito per coinvolgere i compagni di lavoro in uno sciopero per avere condizioni migliori di lavoro.
I dibattiti, alla radio, continuano anche in sua assenza. Ibra, Akhet, Abdul e Mamadou li conducono con passione, invitano compagni e «fratelli» a fare sentire la propria voce.
In diretta alla radio chiama Toni Ricciardi, autore di un libro che racconta la strage di Mattmark, in Svizzera, quando a vivere in un ghetto erano gli italiani e la valanga del ghiacciaio Allalin, nel 1965, ne uccise 56 (assieme ad altri 32 lavoratori svizzeri, spagnoli, austriaci e tedeschi). Chiama Giulia Anita Bari, responsabile del progetto Terragiusta di Medici per i diritti umani, che fa presidio sanitario e monitoraggio nei ghetti della Basilicata. Chiamano i migranti accampati nel presidio «No Border» di Ventimiglia. Chiamano i volontari italiani che sono già passati di qui, da questo microprogetto che per il quarto anno consecutivo porta le voci del Ghetto a comunicare tra loro, e con l’esterno.
Passano dalla radio quasi tutti i bianchi che entrano ed escono, tranne quelli interessati solo alle prostitute.
Ricercatori, musicisti, gli attivisti di «Campagne in lotta» che cercano di organizzare manifestazioni con i lavoratori. I volontari di «Io ci sto», il progetto dei missionari scalabriniani che durante l’estate porta cinquanta ragazzi a settimana a insegnare italiano e riparare biciclette, sotto l’uliveto all’ingresso del ghetto.
«Ma è da noi che deve venire la voglia di ribellarci, e non dai bianchi», ribadisce al microfono Adama, che di rivolte ne ha già fatte, al centro di accoglienza di Crotone e nelle baraccopoli di Rosarno, e i diritti se li è visti scappare dalle mani proprio quando gli sembrava di stare per afferrarli. «Non dobbiamo avere paura», gli fa eco Mamadou. «Io ho visto uccidere i miei genitori. Ho visto Agadez, ho visto il deserto, ho visto le carceri libiche. Io non ho più paura».
Giulia Bondi
Nota: i nomi degli abitanti del Ghetto sono di fantasia.

Migrazioni e decrescita
Rompere il cerchio crescita-migranti
Quello delle migrazioni internazionali, lungi dall’essere un’emergenza, è un fenomeno strutturale, è parte del Dna di un’economia mondiale finalizzata alla crescita. Oltre al necessario dibattito sull’accoglienza delle persone che viaggiano verso l’Europa, è fondamentale domandarsi cosa si possa fare per evitare che esse si vedano costrette a lasciare le loro terre, divenute per molti aspetti inospitali. Una prospettiva utile è quella della decrescita, indicata anche dal papa nella sua Enciclica Laudato si’.
I flussi di migranti che, a rischio della vita e pagando altissimi costi anche in denaro, attraversano su barconi improbabili il tratto di mare Mediterraneo tra le coste del Nord Africa e dell’Europa del Sud, suscitano nell’opinione pubblica dei paesi in cui arrivano due reazioni contrastanti: quella umanitaria dell’accoglienza in nome della fratellanza e dell’uguaglianza dei diritti di tutti gli esseri umani, e quella egoistica del rifiuto che si traduce nella richiesta di riportare i nuovi arrivati nei luoghi da cui sono partiti, o di usare la forza per impedire che partano. La prima reazione è dettata da motivazioni religiose o politiche, sostenute dalle frange più a sinistra della sinistra. La seconda è motivata dalla paura per l’insicurezza sociale che può essere innescata dall’arrivo di persone prive di risorse per vivere, che possono essere indotte dall’istinto di sopravvivenza a tentare di tutto per riuscirci. Questa paura, che secondo i sostenitori dell’accoglienza sarebbe immotivata, benché l’esperienza sembri dimostrare il contrario, viene ingigantita e strumentalizzata politicamente dai settori della destra più retriva.
A conti fatti né gli uni, né gli altri fanno un’analisi approfondita delle ragioni per cui masse crescenti di persone fuggono dai luoghi in cui sono nate per riversarsi nei paesi dell’Europa occidentale. Le analisi si fermano all’ovvia constatazione del fatto che ciò avviene perché quelle persone non riescono più a ricavare dalle loro terre il necessario per vivere, a volte anche a causa di guerre sanguinose e interminabili. D’accordo, ma perché così tante persone non riescono più a ricavare da vivere dai luoghi in cui per migliaia di anni sono vissuti i loro antenati, e perché quei luoghi sono diventati teatri di guerra? Queste domande non solo non ricevono risposta, ma non vengono neppure formulate. Eppure, se non si capiscono le cause, non si può nemmeno tentare di rimuoverle, e se ci si limita a cercare di attenuarne le conseguenze, si può addirittura correre il rischio di rafforzarle.
Le migrazioni: necessarie per la crescita
La prima considerazione da fare è la seguente: le migrazioni sono una necessità intrinseca delle economie che hanno finalizzato le attività produttive alla crescita. Lo sono state sin dall’inizio della rivoluzione industriale in Inghilterra nella seconda metà del Settecento, quando in conseguenza di alcune leggi vessatorie contro l’agricoltura di sussistenza, i contadini non riuscirono più a ricavare dalle loro terre ciò di cui avevano bisogno per vivere, e furono costretti a emigrare nelle città, nelle quali trovavano da lavorare come operai nei primi opifici in cambio di un misero reddito monetario che li metteva in condizione di comprare, sotto forma di merci, i beni che non potevano più autoprodurre. Senza le migrazioni forzate degli ex contadini, l’industria non avrebbe trovato la manodopera di cui aveva bisogno per produrre merci, e nemmeno un numero sufficiente di persone provviste di reddito monetario in grado di acquistare le merci prodotte.
La crescita della produzione industriale, con cui è stato identificato il benessere, richiede un aumento costante di produttori e consumatori di merci, che sono due facce della stessa medaglia, perché per avere il denaro necessario a comprare le merci, a meno che non si viva di rendita, occorre lavorare nella produzione di merci, o nei servizi necessari al funzionamento di una società che tende a mercificare tutto, in cambio di un reddito monetario. Pertanto la crescita ha sempre avuto bisogno di costringere, con la forza legale dello stato, integrata da forme di forza illegale, e allo stesso tempo di convincere, con l’uso dei mezzi di comunicazione di massa, un numero crescente di persone a passare dall’economia di sussistenza all’economia mercantile.
Un’economia finalizzata alla crescita della produzione di merci ha bisogno di distruggere le economie di sussistenza e di avviare flussi migratori dalle campagne alle città, prima in ambito regionale (come è avvenuto in Italia nella prima metà del Novecento), poi a livello nazionale (come è avvenuto in Italia nella seconda metà del Novecento), poi a livello internazionale, come è avvenuto in Europa a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso con l’arrivo di migranti dai paesi dell’Est e dall’Africa.
«Dobbiamo aprire le nostre porte»
L’11 maggio 2015 il banchiere Carlos Moedas, Commissario europeo alla ricerca, all’innovazione e alla scienza, ha dichiarato all’emittente francese Europe1: «Bisogna avere più immigrati in Europa. L’immigrazione è necessaria alla crescita ed è certo che se potessimo avere più persone, potremmo avere più crescita. Il mio messaggio ai francesi e all’Europa è che dobbiamo aprire le nostre porte». Con una sintonia che potrebbe stupire, il XXIV Rapporto Immigrazione dal titolo Migranti, attori di sviluppo, presentato il 4 giugno 2015 all’Expo di Milano dalla struttura della Chiesa cattolica che si occupa di questo problema, la Caritas/Migrantes, ha messo in evidenza che i migranti costituiscono una ricchezza per l’Italia, perché producono l’8,8% del prodotto interno lordo, pari a oltre 123 miliardi di euro. E vengono pure pagati meno dei lavoratori italiani: un italiano guadagna in media 1.326 euro al mese, un cittadino comunitario 993, un extracomunitario 942. Per non parlare di chi lavora in nero, a cui viene dato solo il necessario per sopravvivere e tornare a lavorare giorno dopo giorno fino a quando ce n’è bisogno.
Cosa si può volere di più? Per smontare le resistenze delle persone anziane in apprensione per la loro sicurezza, i mass media ripetono in continuazione: «Come si potrebbero pagare le vostre pensioni senza i versamenti dei lavoratori stranieri?».
Un meccanismo che si autornalimenta
Per cortesia, lasciamo stare la retorica dell’accoglienza basata sui buoni sentimenti, sulla carità cristiana, sulla fratellanza e sulla giustizia sociale. Non che non ci sia chi agisce con questa nobiltà d’animo, ma chi lo fa finisce col rischiare di fare il cavallo di Troia a favore di chi, invece, utilizza i migranti (i quali per lo più sono persone nel pieno della loro forza fisica e della loro lucidità mentale) per far crescere il prodotto interno lordo dei paesi ricchi, utilizzando teste e braccia che potrebbero invece produrre ciò che serve per far uscire dalla miseria i propri paesi d’origine. Per non parlare di chi, come si è visto con l’indagine di Mafia Capitale, utilizza per arricchirsi illegalmente i finanziamenti stanziati per l’accoglienza temporanea dei migranti.
Le migrazioni dai paesi non industrializzati verso i paesi industrializzati sono causate dal fatto che questi ultimi, per sostenere la crescita dei propri sistemi economici, depredano i primi delle loro risorse, istigano i popoli che li abitano a farsi guerre fratricide, li cacciano dalle loro terre comprandole per un tozzo di pane, corrompono i loro governanti portandoli al potere e li sostituiscono o li fanno uccidere se diventano un ostacolo per i loro interessi, usano i contributi economici di aiuto allo sviluppo per costringerli a passare dall’economia non mercantile all’economia monetaria, dall’agricoltura tradizionale di sussistenza, da cui hanno sempre tratto da vivere, alle monocolture per il mercato mondiale, inducendoli a fertilizzare chimicamente i terreni per aumentare le rese fino a renderli sterili. E mentre i paesi ricchi impoveriscono scientificamente quelli poveri, anche col pretesto di aiutarli, fanno balenare davanti agli occhi dei loro abitanti la possibilità di accedere alle loro meraviglie tecnologiche.
I migranti che se ne vanno dai loro paesi nei quali non riescono più a vivere contribuiscono col loro lavoro a far crescere il prodotto interno lordo dei paesi d’immigrazione e quindi ad accentuare il loro fabbisogno di risorse. Per procurarsele, i paesi industrializzati continueranno a rapinare i paesi non industrializzati, utilizzando tutte le forme di violenza e sopraffazione con cui sono soliti sottometterli, faranno accrescere ulteriormente la loro povertà e indurranno quindi molti altri dei loro abitanti a emigrare per vivere.
Le migrazioni tendono ad autornalimentarsi. Se le organizzazioni umanitarie in cui si impegna la componente più generosa della nostra società non si preoccupano di intervenire sulle cause, contribuiscono a prolungare nel tempo l’ingiustizia e l’iniquità.
«Alla ricerca di un futuro migliore»
Premesso che alleviare una sofferenza è un dovere morale e, pertanto, deve essere svolto tempestivamente senza se e senza ma, capirne le cause è un dovere altrettanto impellente.
La comprensione delle cause che attivano i flussi migratori dall’Africa ai paesi dell’Europa occidentale è offuscata dal sistema di valori che accomuna, al di là delle differenze, tutte le correnti di pensiero presenti nei paesi in cui l’economia è stata finalizzata alla crescita della produzione di merci. Per descrivere gli occupanti dei barconi che arrivano sulle coste dell’Italia meridionale, o affondano tragicamente nel canale di Sicilia, i mass media ripetono un luogo comune di cui non immaginano le implicazioni culturali: «Disperati che si sottopongono a sofferenze indicibili e mettono a rischio la loro stessa vita alla ricerca di un futuro migliore». Il futuro migliore sarebbe l’inserimento nelle società in cui vivono i popoli che si autodefiniscono sviluppati per il fatto di avere un alto valore del prodotto interno lordo procapite. Convinti di appartenere alla società più evoluta che sia mai apparsa nella storia, inevitabilmente questi popoli pensano che il massimo desiderio dei popoli che essi definiscono sottosviluppati, sia di condividere i loro stili di vita. Di diventare sviluppati anche loro. Non riescono nemmeno a immaginare che possa esistere un’idea di benessere diversa dalla crescita del prodotto interno lordo procapite, magari più vera e più capace di futuro. Non si rendono conto che nei confronti dei migranti dall’Africa in Europa, come nei confronti dei contadini, degli artigiani e delle comunità nei paesi in via di sviluppo, si sta ripetendo la stessa storia iniziata nel diciottesimo secolo in Inghilterra.
Decrescita e stili di vita responsabili
L’unica possibilità per attenuare le sofferenze dei migranti dai paesi africani, non è spianare, seppure con le migliori intenzioni, la strada all’esigenza delle economie della crescita di accrescere con le migrazioni il numero dei produttori e consumatori di merci allo scopo di continuare a crescere, ma impegnarsi affinché i paesi industrializzati abbandonino la finalizzazione dell’economia alla crescita, riscoprendo l’importanza dell’autoproduzione per l’autoconsumo, dell’agricoltura tradizionale, dell’artigianato, dei rapporti comunitari, dell’economia del dono, della sobrietà, del rispetto della terra, della simbiosi che lega l’umanità alla fotosintesi clorofilliana attraverso il respiro, della bellezza, della contemplazione, della spiritualità. Questo recupero di valori e di modelli di comportamento del passato è una condizione necessaria per ridurre l’impronta ecologica della specie umana e per consentire una più equa ripartizione delle risorse tra i popoli, ma non sarebbe sufficiente se non venisse accompagnato da un grande slancio progettuale di innovazioni tecnologiche finalizzate all’aumento dell’efficienza nell’uso delle risorse della terra. È necessario rendere compatibile il consumo delle risorse con la loro capacità di riprodursi e di metabolizzare le emissioni che, inevitabilmente, si producono nei processi che le trasformano in beni per le esigenze vitali della specie umana.
Solo la decrescita della produzione di merci nei paesi industrializzati, attuata mediante l’adozione di stili di vita più responsabili e di tecnologie finalizzate eticamente, può ridurre la necessità di risorse, evitare che esse vengano sottratte ai popoli poveri attraverso forme sofisticate di violenza di massa, evitare a molti la costrizione dell’emigrazione rischiando la vita per il fatto di non riuscire più a trarre da vivere, come i loro avi, dalla terra in cui sono nati. Solo una decrescita con queste caratteristiche può consentire di realizzare condizioni di maggiore giustizia non solo tra i popoli, ma anche con le generazioni future.
Laudato si’
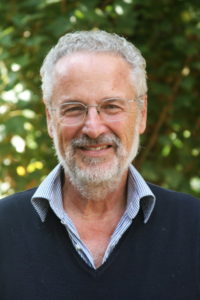 Nell’enciclica Laudato si’, con cui papa Francesco già dal titolo ha voluto sottolineare la ragione per cui ha scelto il suo nome di pontefice, la decrescita dei consumi di risorse da parte dei popoli ricchi viene indicata, seppur con alcune cautele che sembrano motivate dalla preoccupazione di attenuarne l’impatto sul paradigma culturale fondante delle società industriali, come la condizione imprescindibile per realizzare una maggiore equità tra i popoli. «[…] e? arrivata l’ora – scrive il pontefice – di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse perche? si possa crescere in modo sano in altre parti». Anche se questa interpretazione non evidenzia con chiarezza la connotazione della mercificazione insita nella crescita economica, indicando soltanto la diminuzione dei consumi di risorse da parte dei popoli che hanno più del necessario per consentire l’aumento della disponibilità delle risorse per i bisogni vitali dei popoli poveri, per la prima volta la decrescita riceve un riconoscimento della massima autorevolezza morale e viene indicata come la condizione indispensabile per realizzare in questa fase della storia la pulsione all’eguaglianza insita nell’animo umano, che costituisce l’elemento caratterizzante dell’insegnamento di Cristo. Dopo due secoli e mezzo di esaltazione acritica della crescita da parte di tutte le correnti di pensiero, di destra, di sinistra e della stessa Chiesa cattolica, a fronte dell’irrisione riservata sino a ora alla decrescita da politici, imprenditori e intellettuali che pure si vantano della loro formazione cattolica (e che, per quanta buona volontà ci mettano, non riescono dal 2008 a far ripartire la crescita economica), questa affermazione di papa Francesco segna l’inizio di una svolta storica.
Nell’enciclica Laudato si’, con cui papa Francesco già dal titolo ha voluto sottolineare la ragione per cui ha scelto il suo nome di pontefice, la decrescita dei consumi di risorse da parte dei popoli ricchi viene indicata, seppur con alcune cautele che sembrano motivate dalla preoccupazione di attenuarne l’impatto sul paradigma culturale fondante delle società industriali, come la condizione imprescindibile per realizzare una maggiore equità tra i popoli. «[…] e? arrivata l’ora – scrive il pontefice – di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse perche? si possa crescere in modo sano in altre parti». Anche se questa interpretazione non evidenzia con chiarezza la connotazione della mercificazione insita nella crescita economica, indicando soltanto la diminuzione dei consumi di risorse da parte dei popoli che hanno più del necessario per consentire l’aumento della disponibilità delle risorse per i bisogni vitali dei popoli poveri, per la prima volta la decrescita riceve un riconoscimento della massima autorevolezza morale e viene indicata come la condizione indispensabile per realizzare in questa fase della storia la pulsione all’eguaglianza insita nell’animo umano, che costituisce l’elemento caratterizzante dell’insegnamento di Cristo. Dopo due secoli e mezzo di esaltazione acritica della crescita da parte di tutte le correnti di pensiero, di destra, di sinistra e della stessa Chiesa cattolica, a fronte dell’irrisione riservata sino a ora alla decrescita da politici, imprenditori e intellettuali che pure si vantano della loro formazione cattolica (e che, per quanta buona volontà ci mettano, non riescono dal 2008 a far ripartire la crescita economica), questa affermazione di papa Francesco segna l’inizio di una svolta storica.
Maurizio Pallante

