Per scaricare quesot testo completo di note clicca qui.
Per il sito-blog su sr Leonella, clicca qui
Carissimi Missionari e Missionarie,
Il prossimo 17 settembre celebriamo il X anniversario del martirio della nostra sorella, la Serva di Dio Suor Leonella Sgorbati, uccisa nel 2006 a Mogadiscio – Somalia. Le ultime sue parole furono:
«Perdono, perdono, perdono…». Il martirio di Suor Leonella è espressione della radicalità dell’offerta della propria vita e profezia della sua donazione. Il suo martirio è profezia che rende visibile l’amore e testimonia il dono e la responsabilità che abbiamo nella nostra vocazione di consacrati per la missione. Mettiamoci all’ascolto di Suor Leonella per riscoprire la bellezza della nostra vocazione e per amare senza riserve e con grande generosità nella nostra missione. Leonella c’insegna il perdono, il perdono come regalo per rompere il circolo vizioso di rispondere al male con il male, il perdono che ci rende liberi per immaginare il nostro futuro, il perdono come dono e questo ci basta!
-
La Causa di Beatificazione e Canonizzazione
 1.1 La richiesta del X Capitolo generale MC
1.1 La richiesta del X Capitolo generale MC
Il 20 giugno 2006 la Direzione Generale MC, in un incontro con le Superiore di Circoscrizione, aveva indetto un tempo di preparazione al primo centenario dell’Istituto che si sarebbe celebrato nel 2010.
La domanda che accompagnava questa indizione era la seguente: «Che cosa chiede lo Spirito di Dio all’Istituto MC, oggi, per essere fedeli all’intuizione carismatica del Fondatore, il Beato Giuseppe Allamano, che ci volle donne consacrate, votate alla Missione anche a costo della vita?».
La risposta a questa domanda fondamentale ci venne appena qualche mese dopo con il martirio di Suor Leonella Sgorbati che, come Gesù, si è offerta nel perdono e nell’amore totale.
L’Istituto lesse, nel dono di vita di Suor Leonella, un richiamo forte del Signore alla fedeltà alla Missione. Per questo, il X Capitolo generale MC del 2011 chiese alla Direzione generale di dare inizio al procedimento per riconoscee il martirio:
«Suor Leonella Sgorbati ha vissuto l’amore incondizionato a Cristo e ha realizzato il desiderio del Fondatore: “servire la missione anche a costo della vita” (cf. Conf. S., 24 settembre 1916). Alla luce delle parole del S. Padre Benedetto XVI, della testimonianza di tante Sorelle e di tanta gente, il X Capitolo Generale chiede alla Direzione generale di dar inizio alla procedura per il riconoscimento del martirio di suor Leonella Sgorbati avvenuto a Mogadiscio il 17 settembre 2006 perché diventi per tutte noi esempio di come vivere la missione, anche nel contesto dell’oggi».
Dopo aver valutato la richiesta del X Capitolo generale 2011, l’attuale Direzione generale MC, considerando importante dare avvio all’Inchiesta Diocesana per il riconoscimento del martirio di Suor Leonella, ha nominato la Postulatrice della Causa nella persona di Suor Renata Conti, MC. Verificata e raccolta in un Dossier la “Fama di Martirio e di Segni”, la Direzione generale ha quindi domandato – attraverso la Postulazione – al Vescovo competente, Sua Eccellenza Mons. Giorgio Bertin, Vescovo di Djibouti e Amministratore Apostolico di Mogadiscio, di volere accogliere questa richiesta perché Suor Leonella, con la sua vita e soprattutto con la sua morte per la fede, potesse essere un esempio e incoraggiamento per le sorelle dell’Istituto nel loro impegno missionario, sostenere i Cristiani del Medio Oriente3 nel loro cammino di fedeltà a Cristo e alla Chiesa e dire alla società che la santità della Chiesa è visibile nei suoi membri, anche oggi.
1.2. L’iter dell’Inchiesta diocesana
Il primo passo realizzato dalla Postulatrice fu di raccogliere e sistematizzare la documentazione che riguardava la “Fama di Martirio e di Segni” di cui godeva Suor Leonella.4
Il Dossier elaborato riunisce, per temi, i numerosi documenti pervenuti all’Istituto in occasione della sua morte.
Il giorno 25 settembre 2012, a Nepi (VT – Italia), in Casa Generalizia MC, S.E.R. Mons. Giorgio Bertin diede inizio ufficiale al percorso dell’Inchiesta Diocesana con la S. Messa. Parteciparono numerosi Missionarie e Missionari della Consolata e tanta altra gente.
A nome dell’Istituto e accompagnata dalla Postulatrice, Madre Simona lesse il Supplex libellum, ossia la richiesta formale di dare inizio alla Causa. Successivamente, Suor Renata presentò al Vescovo il Dossier contenente i documenti sopra citati.
Mons. Bertin rispose con il seguente messaggio:
«Con immensa gioia e gratitudine verso Dio, accolgo la vostra domanda di dare inizio all’Inchiesta Diocesana per il riconoscimento del Martirio di Suor Leonella Sgorbati, uccisa nella mia Giurisdizione Ecclesiastica, in Somalia, il 17 di settembre del 2006. La sua vita e il suo martirio nel segno del perdono ci sono di esempio e di motivo per dare inizio al cammino di verifica e di ricerca attraverso le testimonianze e lo studio dei documenti allegati al dossier. Possa lo Spirito di Dio illuminare e sostenere quanti saranno impegnati nel portare avanti l’Inchiesta Diocesana».5
Da settembre 2012 a settembre 2013 Mons. Giorgio Bertin, in collaborazione con la Postulatrice, prepararono ciò che conceeva l’organizzazione del tribunale:
-
Nomina delle commissioni storica e teologica per lo studio degli scritti non editi: Lettere circolari alle sorelle del Kenya, due diari personali e la corrispondenza
La commissione storica fu conformata da: P. Antonio Magnante IMC, Mons. Luigi Paiaro, Vescovo emerito della Diocesi di Nyahururu (Kenya) e Suor Chiara Piana MC; la commissione teologica da: Mons. Carlo Ghidelli, Vescovo emerito della Diocesi di Lanciano (Italia) e P. German Arana SJ, Rettore del Seminario Pontificio Comillas (Spagna).
-
Nomina dei membri del Tribunale per l’iter diocesano.
Essi furono: P. Francesco Giuliani IMC, giudice delegato; P. Giovanni Tortalla, promotore di giustizia; Suor Kathy Meier MC, notaio attuario; Signor Vincenzo Marini e signora Marilena Credidio, notai aggiunti.
L’Inchiesta Diocesana ebbe inizio in Djibouti il 16 di ottobre 2013 alle ore 09:00 e si concluse il 15 gennaio 2014 alle 12:30 con una S. Messa di ringraziamento per i lavori portati a termine. L’inchiesta si sviluppò in quattro tappe: prima tappa a Djibouti, seconda tappa a Nairobi con la partecipazione anche dei testimoni della Somalia, terza tappa nel Meru e quarta tappa a Torino con la partecipazione anche dei familiari. I testimoni furono 46: 2 vescovi, 1 sacerdote diocesano, 4 Missionari della Consolata, 2 Religiose di altre Congregazioni, 19 Missionarie della Consolata e 18 laici.
Alla conclusione dell’Inchiesta Diocesana e dopo aver ottenuto il “nulla osta” della Congregazione per le Cause dei Santi, la Postulatrice elaborò la Positio che venne consegnata alla stessa il 7 aprile 2016.

-
Importanza della testimonianza martiriale di Suor Leonella
Il 17 settembre 2006 Suor Leonella Sgorbati veniva colpita a morte da una raffica di colpi di arma da fuoco. Con lei moriva la guardia del corpo, Mohamed Mahamud, che aveva cercato di difenderla. L’assassinio della nostra sorella la unisce di fatto alla scia di sangue che ha segnato indelebilmente la storia recente della Somalia: Mons. Salvatore Colombo (Mogadiscio, 1989), p. Pietro Turati (Gelib, 1991), Graziella Fumagalli (Merca, 1995) e Annalena Tonelli (Borama, 2003).
Il telegramma inviato da Benedetto XVI tramite il Segretario di Stato all’Istituto MC pare rivolto a tutta la Chiesa:
«[…] Nel riaffermare ferma deplorazione per ogni forma di violenza Sua Santità auspica che sangue versato da così fedele Discepola del Vangelo diventi seme di speranza per costruire autentica frateità tra i popoli nel rispetto reciproco convinzioni religiose di ciascuno […]».
Poche righe, senza articoli né punteggiatura, com’è lo stile del telegramma. Ma dove si stigmatizza con chiarezza tutta la semplicità e la grandezza della fede di chi muore per una causa in cui crede e in cui investe la vita, tutta. In queste poche righe è espressa una convinzione forte: Suor Leonella non è morta, ha versato il sangue. E nel linguaggio della Chiesa, «l’azione del “versare il sangue per…” è l’azione dei martiri».6
Possiamo desumere l’importanza della testimonianza martiriale della Serva di Dio per la Chiesa perseguitata del Medio Oriente anche da alcune espressioni di una lettera che il Patriarca Latino di Gerusalemme, Fuad Twal, indirizzò al Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, in data 4 aprile 2013 con copia a Mons. Giorgio Bertin ofm.
Nella lettera sopra citata il Patriarca rilevava come i Vescovi Latini per le Regioni Arabe si auguravano che il sangue versato da Suor Leonella Sgorbati fosse come l’acqua che fa fiorire il deserto. Essi erano convinti che l’amore fino a versare il sangue e le ultime parole pronunciate da Suor Leonella sarebbero state, per tutti gli abitanti del Coo d’Africa, l’esempio di una riconciliazione e di un perdono sempre possibili.7
Ricordare il martire è un inno alla vita e non alla morte. Giovanni Paolo II, durante la giornata dei Martiri celebrata al Colosseo nell’anno giubilare del 2000, ricordava che la memoria dei martiri non doveva andare perduta, anzi doveva essere ricuperata in maniera documentata perché la storia del martirio è quella di una lotta tremenda e tragica, che va scritta, capita e non dimenticata.
Anche Papa Francesco rileva come la Chiesa è chiamata a ricordare i martiri perché essi ci insegnano che dobbiamo mettere Cristo al centro della nostra vita ed il loro esempio ha molto da dire a ciascuno di noi e alla Chiesa tutta.9 Nella sua visita apostolica in Corea il Santo Padre rilevava come l’esempio dei martiri mostra l’importanza della carità nella vita di fede e la loro eredità dove ispirare tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad operare in armonia per una società più giusta, libera e riconciliata ed aggiungeva che essere martiri voleva dire soprattutto essere testimoni di Gesù.

-
Dimensione Eucaristica e martiriale della vocazione missionaria in Suor Leonella
Suor Leonella operò nella sua vita la scelta radicale di eliminare tutto quanto lei definiva il «fascino della nullità»11, per impegnarsi con passione e determinazione affinché lei e Gesù non fossero solo
«buoni vicini di casa»,12 ma si stabilisse tra loro una unione sponsale.13 Ella cercò la completezza umana e spirituale con Gesù, con accenti di squisita delicatezza. In tutte le espressioni che Suor Leonella usò rivolgendosi a Gesù,14 si percepisce come una interiore nostalgia mistica:
«Che nostalgia – ella annotava quando andava a salutare le Suore Sacramentine appena arrivate in missione – […] nostalgia di una vita che ha solo il Signore per ragione e motivo».
Il martirio di Suor Leonella è stato preparato da un’intensa relazione con Gesù nel mistero Eucaristico nel corso di tutta la vita. Nei suoi diari si percepisce però che durante il mese allamaniano, vissuto a Castelnuovo nel febbraio del 2006, essa fu particolarmente e gradualmente attratta da questo mistero e Gesù Eucaristia le concesse grazie particolari d’intima unione, fino al punto di sentirsi una cosa sola con Lui, secondo le parole stesse di Gesù:
«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me» (Gv 6, 56-57).
Diceva: «Se il Suo corpo e il mio sono una cosa sola, se il Suo sangue e il mio sono una cosa sola, allora è possibile essere sempre in Lui, dono d’amore, dono di Lui, per tutti. Sempre, in ogni momento! Allora è possibile testimoniare sempre che Lui c’è e ci ama».
Le parole di Gesù erano per lei esperienza e le ripeteva continuamente. Questa esperienza l’aveva segnata come un marchio di fuoco.16 Fu proprio all’interno di questa esperienza che Suor Leonella percepì chiaramente la chiamata di Gesù a vivere il mistero eucaristico fino alla fine, fino al dono della vita, fino allo spargimento del sangue, come Lui e a questo invito rispose con il suo Sì d’amore. Non sapeva come questa chiamata si sarebbe concretata; era sicura però che si trattasse del dono della sua stessa vita, in maniera radicale e in un tempo breve. Lei disse il suo Sì, con tutto l’amore del suo cuore, con gratitudine e umiltà per tanta grazia, con tanta consapevolezza della sua fragilità e sofferenza e del fatto che l’amore fedele per Gesù era più forte.17 Da quel giorno quante volte Suor Leonella ha ripetuto il suo Sì, quante volte ha supplicato di pregare per lei perché fosse fedele!
Quando fu colpita a morte, le sue ultime parole non potevano essere se non quelle di Gesù: “Perdono”!
Suor Leonella scriveva nel suo diario n. 2 il 27 febbraio 2006:
«Il mio andare in Somalia è la risposta a una chiamata: tu Padre hai tanto amato la Somalia da donare il tuo Figlio… e io dico con lui “questo è il mio corpo, questo è il mio sangue donato per la salvezza di tutti”. Ho solo questo momento presente per… »
La sua penna si ferma qui. Forse non ha osato andare oltre.
-
Missione come dialogo di vita
Suor Leonella dona la sua vita, fino all’effusione del sangue, nella missione tra i non cristiani, da lei vissuta come un andare a cercare i più poveri, coloro che non hanno mai conosciuto il messaggio dell’Amore di Dio, la mitezza e la mansuetudine del Figlio. Scriveva alle sorelle del Kenya nella circolare dell’11 novembre 1994:
«Sorelle carissime, rivediamo insieme le nostre posizioni; Siamo disposte a schierarci dalla parte dei più poveri? Siamo disposte a scelte che ci renderanno forse meno efficienti, più povere, più spoglie e più abbandonate alla Provvidenza? Siamo disposte ad andare a cercare coloro che il messaggio dell’Amore di Dio non l’hanno mai conosciuto, anche se questo implica distacco e sacrificio fino a dare la vita? Siamo disposte a dare la vita, a dare il sangue se occorre testimoniando la mitezza e la mansuetudine del Figlio? Si, io credo di si. Credo che nel cuore di ciascuna di noi è viva e vibrante la freschezza della nostra prima chiamata…».
Per Suor Leonella la missione era dialogo di vita e dono senza riserve. Il 28 febbraio 2006 scriveva nel suo diario 2, rivolgendosi a Gesù:
«Forse anche a te sarà costato “lasciare” il Padre e partire per la tua Missione, ma il tuo amore per il Padre e per noi ha vinto, magari anche tu hai pianto … ma hai teso le braccia alla volontà d’amore … e la tua missione ci ha salvato, mi ha salvata… Tu per primo hai amato e hai, per amore, dato la vita… Il Tuo Sì è nostra vita. Non c’è amore più grande. Tu sei con me… Buon Pastore. La missione Somalia è ciò che Tu mi chiedi ora. Ti dono la mia vita in tutto e per tutto come Tu desideri… Mi chiami ad amare Te, ad amare le sorelle, ad amare la gente, i Fratelli dell’Islam… Possiedimi Signore e ama in me… che io sia una cosa sola in te e Tu possa donare loro la gioia di sentirsi amati da te».
Qui il dialogo della vita tocca le radici più profonde del nostro carisma!
«Insieme a Suor Leonella, un Somalo, un uomo musulmano, ha versato il suo sangue nel tentativo di salvarla, dopo che il primo sparo l’aveva raggiunta. Si tratta di Mohamed Mahamud, sposo e padre di quattro figli. […].
Suor Leonella e Mohamed Mahamud uniti per sempre nel dono della vita. Lei offrendola per i suoi Figli e Figlie Somali, Lui in un gesto estremo per tentare di salvarla …
Lei, donna cristiana, fedele al Suo Signore e alla Missione, lui, uomo musulmano, certamente fedele ad Allah ed al Profeta; uniti nel servizio al loro Popolo, sognando la Pace, la fratellanza … Mohamed per i suoi figli, Suor Leonella per ogni Somalo e per tutti i popoli …
C’è un dialogo di vita, stupendamente in atto in questo gesto; c’è il superamento di barriere, il dono di sé, per sempre… mistero dell’Amore, mistero di Pasqua, di Risurrezione… speranza e consolazione».18
È importante continuare ad ascoltare, approfondire e cogliere il messaggio di “Vita” di Suor Leonella, per tutti noi, consapevoli che il suo esempio ci stimola a vivere la Missione cercando strade di comprensione, riconciliazione e dialogo, nella certezza che solo quando sapremo unire cuore e forze, vita e sangue, potremo costruire il Regno a cui tutti, musulmani e cristiani, uomini e donne di ogni religione e cultura, che credono nella Vita, sono chiamati a dare il proprio apporto.

-
Suor Leonella e la Consolata
Un altro aspetto molto presente nella vita di Suor Leonella è il rapporto con la Consolata. Un rapporto filiale molto sentito. Nel periodo in cui Suor Leonella fu Superiora regionale in Kenya, quasi tutte le sue circolari alle sorelle della Regione parlano di Maria. Suor Leonella percepisce Maria come Colei che, nel suo Figlio, dona la Consolazione. Suor Leonella non stacca mai Maria da Gesù e dalla missione. Diceva alle sorelle:
«[…] siamo chiamate ad essere presenza umile e rispettosa, come Maria, che condivide la vita ed il cammino di fede delle persone e dei popoli… . Presenza di consolazione, rimanendo con il popolo afflitto o in festa, fidandosi più di Dio che dell’umana prudenza con il coraggio dello Spirito per portare il Vangelo nelle situazioni concrete della vita, specialmente nei momenti di rischio, di insicurezza, di scomodo, fino a dare la vita».19
Suor Leonella si chiede: «Che cosa vuole dire “donare la Consolazione” oggi? Cosa vuol dire entrare nel mistero dell’Incaazione, e diventare il Figlio oggi? Perché è proprio nel rapporto filiale che conosceremo per esperienza che cosa è la Consolazione e che cosa significa essere Consolate per Consolare.» E risponde lei stessa:
«Significa accogliere che il Figlio sia libero in ciascuna di noi, in me, libero di perdonare attraverso la mia persona a chi mi reca offesa, libero di spezzare il pane della bontà, della comprensione e della compassione nella mia comunità, libero di fare in me il cammino che il Padre ha fatto fare a Lui con le scelte che il Padre indica. Libero di farmi percorrere il cammino della pazienza, della mansuetudine, dell’umiltà che passa attraverso l’umiliazione…
Libero di amare attraverso di me con l’Amore più grande, l’Amore che va fino alla fine… che è più forte dell’odio e dell’inferno… nella verità, nella pratica di ogni giorno e di ogni momento… e per diventare così abbiamo bisogno che la Consolata generi in noi questo Figlio Consolazione affinché lo possiamo riconoscere anche nel volto degli umiliati ed oppressi».
Nella festa della Consolata del 1996 scriveva:
«Contempliamo la Madre che accoglie nel suo Grembo e genera per noi la Consolazione stessa – il Figlio – e generando Lui genera anche noi in Lui “figlie nel Figlio” Missionarie dell’Amore del Padre oggi, perché portiamo la Sua Tenerezza in questo nostro tempo dove l’umanità ed il creato tutto sembra gemere e grondare sangue!
Contempliamo la Consolata nell’attitudine di donarci il Figlio! Questa Madre che diventa “Tabeacolo e Calice” affinché nutrendoci di questo Figlio che lei ci porge diventiamo davvero figlie nel Figlio!
Il Fondatore passava ore a contemplare la Madre, passava ore ad adorare il figlio reso pane spezzato per noi! E così, anche noi, diventiamo consapevoli e capaci, per l’energia stessa del nostro carisma, di dare risposte d’amore coraggiose alle sfide dell’oggi perché l’umanità riscopra la sorgente della sua identità e felicità».
-
Conclusione
Carissimi Missionari e Missionarie, il prossimo 17 settembre sia per noi tutti una giornata di viva memoria del dono di Suor Leonella! Celebriamo con intensa gratitudine questo anniversario, nelle nostre comunità tra i diversi popoli a cui siamo inviate, possibilmente assieme: Missionari, Missionarie e Laici Missionari della Consolata.
Carissime e carissimi, mostriamo con la nostra vita sull’esempio di Leonella, che l’amore è più forte della morte. L’amore ispira la fiducia, scaccia la paura e porta la pace. Un amore disposto anche a morire, come Gesù, come Leonella e tanti altri che lo hanno capito. Senza amore, nessun gruppo di persone può diventare comunità. È l’amore più forte della morte a rendere i membri della comunità capaci di restare insieme nonostante i propri difetti e fallimenti. È l’amore a costruire relazioni di fiducia che danno pace a una comunità. È l’amore a trasformare le persone in testimoni premurosi e disposti a sacrificarsi gli uni per gli altri. È l’amore del Signore risorto che prende forma in una persona e in una comunità. Ciò di cui il mondo ha bisogno ora è l’amore. È la sola cosa di cui vi è sempre troppo poco. Suor Leonella c’insegna questo amore, c’insegna che una comunità può essere veramente missionaria solo quando vive l’amore, il perdono e la misericordia. È di questo che il mondo, noi missionarie e missionari, tutti abbiamo bisogno adesso! Buona missione!
Sr. Simona Brambilla MC, Superiora generale della Missionarie della Consolata
P. Stefano Camerlengo IMC, Superiore generale dei Missionari della Consolata




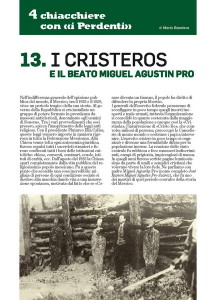
 FRANZ JÄGERSTÄTTER nacque nel 1907 a Sankt Radegund, in Austria, e come semplice contadino visse le vicende della sua patria fino a che Hitler nel 1938 con l’Anschluss (ovvero l’annessione) inglobò l’Austria, facendola diventare parte integrante della Germania nazista. Come tutti i giovani del suo tempo, doveva obbligatoriamente prestare servizio militare e giurare fedeltà alla dottrina del nazional-socialismo e al Führer tedesco, cosa che egli si rifiutò di fare per la sua tenace convinzione che il nazismo fosse incompatibile con il Cristianesimo e che non potesse assolutamente mettere in secondo piano i principi evangelici per assumere quelli della dottrina nazional-socialista.
FRANZ JÄGERSTÄTTER nacque nel 1907 a Sankt Radegund, in Austria, e come semplice contadino visse le vicende della sua patria fino a che Hitler nel 1938 con l’Anschluss (ovvero l’annessione) inglobò l’Austria, facendola diventare parte integrante della Germania nazista. Come tutti i giovani del suo tempo, doveva obbligatoriamente prestare servizio militare e giurare fedeltà alla dottrina del nazional-socialismo e al Führer tedesco, cosa che egli si rifiutò di fare per la sua tenace convinzione che il nazismo fosse incompatibile con il Cristianesimo e che non potesse assolutamente mettere in secondo piano i principi evangelici per assumere quelli della dottrina nazional-socialista.
 Franz: Io fui allevato da mia nonna perché mia mamma mi generò da una relazione
extraconiugale. Quando la mia mamma, dopo qualche anno dalla morte del mio papà
naturale, sposò Heinrich Jägerstätter, questi mi adottò e ne assunsi il
cognome. Nel 1933 morì senza figli propri e così ne ereditai le proprietà. Nel
1936 sposai Franziska Schwaninger e dal matrimonio nacquero tre figlie:
Rosalia, Maria e Aloisia. Qualche anno prima avevo riconosciuto la pateità di
una bambina nata da una relazione sentimentale con un’altra ragazza, Theresia
Auer. Per dirla tutta, non ero «uno stinco di Santo» e anche la mia famiglia
aveva qualche problema con la morale ufficiale della Chiesa.
Josef:
Nella ditta in cui lavoravo a Bolzano, ebbi la fortuna di conoscere Hildegard
Straub, una ragazza che era impiegata nello stesso posto e che proveniva anche
lei dal gruppo dei giovani dell’Azione Cattolica altornatesina. Dopo un breve
fidanzamento, nel maggio del 1942 ci sposammo e l’anno successivo nacque nostro
figlio, cui demmo il nome di Albert.
Franz: Io fui allevato da mia nonna perché mia mamma mi generò da una relazione
extraconiugale. Quando la mia mamma, dopo qualche anno dalla morte del mio papà
naturale, sposò Heinrich Jägerstätter, questi mi adottò e ne assunsi il
cognome. Nel 1933 morì senza figli propri e così ne ereditai le proprietà. Nel
1936 sposai Franziska Schwaninger e dal matrimonio nacquero tre figlie:
Rosalia, Maria e Aloisia. Qualche anno prima avevo riconosciuto la pateità di
una bambina nata da una relazione sentimentale con un’altra ragazza, Theresia
Auer. Per dirla tutta, non ero «uno stinco di Santo» e anche la mia famiglia
aveva qualche problema con la morale ufficiale della Chiesa.
Josef:
Nella ditta in cui lavoravo a Bolzano, ebbi la fortuna di conoscere Hildegard
Straub, una ragazza che era impiegata nello stesso posto e che proveniva anche
lei dal gruppo dei giovani dell’Azione Cattolica altornatesina. Dopo un breve
fidanzamento, nel maggio del 1942 ci sposammo e l’anno successivo nacque nostro
figlio, cui demmo il nome di Albert.


