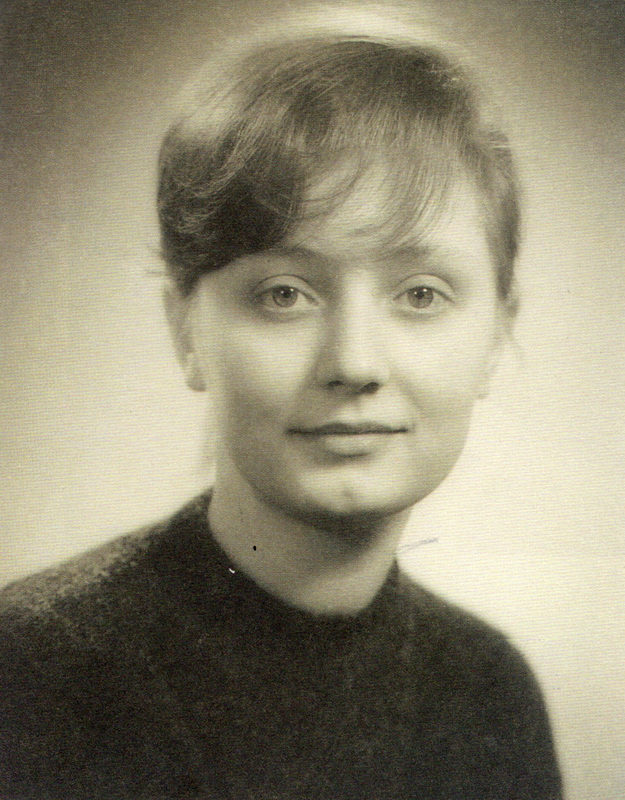Cari Missionari
Grazie a don Paolo Farinella
Buonasera,
sono un vostro abbonato, nonché estimatore. Ho letto che don Paolo Farinella, che conduceva la rubrica Insegnaci a pregare, lascia. Intanto ringrazio MC per aver fatto una scelta così importante a suo tempo. Mi dispiace che lasci; il suo linguaggio, la sua rubrica l’aspettavo ogni mese. Mi è stata compagna di meditazioni ogni mattino; vi ritornavo spesso sempre sullo stesso numero. Devo dire che ho atteso più di 50 anni prima di trovare chi facesse scivolare/penetrare la Parola di Dio, così come l’ha fatto lui; quanto scriveva mi suscitava il gusto di accedervi più volte. Sì, quando uno ti mette nella condizione di gustare (io che sono uno qualsiasi) e di progredire, puoi solo essergli grato.
Posso dire che come Piero Angela ha saputo parlare alla gente della complessità della scienza e farla gustare, così ha fatto don Paolo nel suo ambito. Don Paolo, un abbraccio riconoscente.
Ottorino Saccon
21/12/2018
Questa è la risposta di don Paolo.
Carissimo Sig. Ottorino
[…] la ringrazio per la e-mail che padre Gigi, direttore di MC, mi ha fatto avere. Non le nascondo che mi sono sentito in grave imbarazzo leggendo, e nello stesso tempo ho provato la gioia di sapere che la Parola di Dio può essere indirizzata a tutti, anche non specialisti, basta studiare tanto per parlare un linguaggio umano accessibile e comprensibile. Se lei vuole e se le interessa può visitare il sito www.paolofarinella.eu/ oppure digiti «Paolo Farinella, prete» su Google, e lo trova. Poi alla finestra Liturgia trova tutti i commenti alle domeniche e feste di tutto l’anno (quello in corso è l’Anno-C).
Da 13 anni non ho solo scritto per la rivista, ma consapevole della mia responsabilità, ogni giorno portavo i lettori di MC, verso i quali ho sempre nutrito una grande stima, nel mio cuore e nella mia preghiera perché, pur non conoscendoli, io entravo tutti i mesi nelle loro case, non sapendo quale effetto potessero avere le mie parole. Per questo tutti gli articoli erano prima pensati e poi pregati e poi pubblicati, nel tentativo di aiutare qualcuno a uscire dal «raccontino biblico» per avere un «incontro» vitale con la Parola che è comunione con Dio.
Lei mi ha dimostrato che è possibile e quindi mi conferma che è questa la strada giusta e l’obiettivo di una vita per cui vale la pena vivere.
Da questo momento lei e tutta la sua famiglia, le persone che ama, siete presenti nella mia Eucaristia e nella mia amicizia, oltre il tempo oltre lo spazio. Con affetto.
Paolo Farinella, prete
Genova, 22/12/2018
Abbiamo ricevuto anche altre email in proposito e le abbiamo girate a don Paolo che, come suo solito, ha risposto immediatamente. Grazie ancora Paolo Farinella, prete innamorato della Parola. Anche noi ti portiamo nel cuore e preghiamo per te. Sul nostro sito è possibile trovare i testi pubblicati e scaricarli in formato pdf dallo sfogliabile. Entro Pasqua contiamo di raccogliere i testi di don Paolo pubblicati in un unico pdf per facilitarne la lettura e la consultazione e scaricarli con facilità.

Ho paura, ma voglio ancora diventare prete
Dal Carmel di Bangui, Rep. Centrafricana.
La mattina del 15 Novembre ad Alindao, cittadina a circa 500 km da Bangui, un campo di sfollati situato nei pressi della Cattedrale, è preso d’assalto da un gruppo di ribelli islamisti che porta il curioso nome di «Unione per la pace in Centrafrica». Si tratta di uno dei tanti gruppi agli ordini di un certo Ali Darassa, sorti dalla dissoluzione della Seleka e che ancora infestano i tre quarti del paese. I morti sono più di ottanta. Un vero massacro. Anzi, una razzia: oltre alle persone uccise, i ricoveri degli sfollati sono incendiati, l’intero sito è raso al suolo, le abitazioni sono saccheggiate, la chiesa è profanata. La strage avviene davanti all’inerzia del contingente dell’Onu che avrebbe, di per sé, il mandato di proteggere i civili. Tra le vittime, oltre a donne, bambini e persone anziane, anche due sacerdoti: abbé Célestin e abbé Blaise.

Il coraggio del giovane vescovo di Alindao, Cyr-Nestor Yapaupa (nella foto qui sotto), impedisce che il bilancio sia ancora più pesante. Invece di accogliere la gente, che vorrebbe trovare rifugio all’interno della cattedrale, ordina a tutti di scappare nella savana. Se i cristiani non gli avessero obbedito, il numero dei morti sarebbe stato ancora più alto. Il vescovo e alcuni sacerdoti decidono di restare comunque.
La notizia e i dettagli dell’avvenimento ci raggiungono increduli e scoraggiati. Le foto dei cristiani carbonizzati fanno il giro del mondo. Le già lentissime lancette dell’orologio della pace sembrano improvvisamente e drammaticamente correre all’indietro. Il Centrafrica sembra ormai essersi ingarbugliato in un inestricabile groviglio d’ingerenze straniere, inadempienze della comunità internazionale e incapacità del governo locale. L’elemento confessionale non fa che rendere il cocktail ancora più micidiale.
Alcuni giorni dopo gli avvenimenti, partecipiamo a un incontro di sacerdoti a Bangui. È presente abbé Donald, appena arrivato da Alindao. Originario di Bangui, sacerdote da poco più di un mese, aveva trascorso al Carmel i giorni di preparazione all’ordinazione, ascoltando con attenzione le conferenze del sottoscritto. Conferenze che avrebbero dovuto dargli le ultime istruzioni prima di essere un ministro di Dio per sempre.
Da qualche settimana Donald era stato inviato in aiuto alla diocesi di Alindao. Questa volta sono io che ascolto con attenzione la sua conferenza, nonostante sia ancora sotto shock, circa quanto avvenuto ad Alindao. Donald non ha ancora avuto il tempo d’imparare a fare il prete; ma ne ha già visti due morire, davanti ai suoi occhi, uccisi per il vestito che indossavano e il mestiere che esercitavano.
In classe, durante la lezione, è quindi un dovere parlarne. Gli studenti che ho davanti non sono allievi qualunque. Sono i futuri sacerdoti del Centrafrica. Provengono dalle città e dai villaggi dell’intero paese. Hanno visto la guerra e ora sono nel Seminario di Bangui perché vogliono fare lo stesso mestiere di Célestin e Blaise. Poi ripartiranno, sacerdoti, nelle diocesi da cui sono venuti. Chiedo loro se hanno ancora voglia di continuare il cammino intrapreso e se sono consapevoli dell’alto rischio che li attende.
Odilon, dall’alto dei suoi vent’anni, risponde per tutti: «Ho paura, mon père. Ho tanta paura. Ma non cambio idea. Voglio ancora diventare prete». La sua sincerità e il suo coraggio disarmerebbero anche Ali Darassa. Vorrei dire a Donald che ho paura anch’io. Ma nessuna voglia di cambiare mestiere. Penso al giorno in cui sono diventato sacerdote. Proprio non immaginavo che sarei finito qui, a spiegare chi era Origene e Agostino, a decine di volti neri, curiosi e imprevedibili, ostinatamente convinti che si può e si deve diventare preti, anche in un paese in guerra.
[…] C’è forse un legame tra il sacrificio dell’abbé Célestin e dell’abbé Blaise, il coraggio del vescovo Cyr-Nestor, quanto ha visto abbé Donald, la solenne promessa di Odilon e il «per sempre» di fra Michaël?
Sant’Agostino chiedeva a Dio, per sé e i suoi pastori, di amare il proprio gregge fino a morirne aut effectu aut affectu, cioè di fatto, con il sacrificio della vita, o con il cuore, nella dedizione senza risparmio al servizio del popolo di Dio. In passato gli argomenti per parlare male di questa giovane chiesa non sono certo mancati. Questo 2018, nel quale ben cinque sacerdoti e decine di cristiani sono stati uccisi durante le celebrazioni o nei pressi delle loro chiese, ci consegna una chiesa sicuramente ancora giovane e fragile, ma che non scappa davanti al nemico e i cui pastori non sono mercenari.
Padre Federico Trinchero
Bangui, 17/12/2018

Rinnovi e cancellazioni
Spett. Redazione Rivista Missioni Consolata,
vi sarei grata se sospendeste l’invio della rivista all’indirizzo […] a causa del decesso del destinatario. Vi sarei altresì molto grata se la sospensione avvenisse nel più breve tempo possibile per non riempire eccessivamente la cassetta delle lettere. Cordiali saluti
Email firmata, 22/01/2019
Desidero continuare a ricevere la vostra interessantissima rivista. Grazie per gli articoli che riportano notizie serie, non facilmente reperibili in altra carta stampata.
M.P., 22/12/2018
Buongiorno. Vi scrivo per disdire l’abbonamento alla rivista Consolata, che continua ad essere spedita all’indirizzo di mia zia, nonostante lei sia morta dall’anno 2005. Se vi chiedete perché io non doni al posto suo, vi dico che ho scelto di aiutare l’Unicef. Potreste risparmiare carta e quindi alberi; è pur vero che avrei potuto scrivervi prima di adesso. Vi auguro di continuare la vostra missione nel miglior modo possibile.
Email firmata, 17/11/2018
Con la presente vi chiederei cortesemente di non inviarmi più la bella rivista Missioni Consolata, la rivista aveva incominciato ad arrivare a casa dopo che mio figlio aveva fatto una bella esperienza in Africa, tanti anni fa. Adesso lui non vive più in questo indirizzo ed io non riesco che a leggere ogni tanto un articolo e mi dispiace che venga sprecata.
Email firmata, 22/10/2018
Abbiamo condiviso con voi alcune delle email ricevute di questi tempi. La maggior parte riguarda benefattori delle nostre missioni che sono andati alla casa del Padre. Non finiremo mai di ringraziare il Signore per il loro affetto e il loro sostegno.
Naturalmente non tutti i messaggi ricevuti sono benevoli. Alcuni, inviati dagli «eredi» dei nostri lettori/benefattori suonano come aspri rimproveri perché in tutti questi anni abbiamo approfittato della loro buona fede per spillare soldi.
Non è piacevole neppure sentirsi dire che la nostra rivista riempie eccessivamente la cassetta postale, come se fosse insistente e invasiva alla stregua della pubblicità dei supermercati.
Quanto alla scelta di aiutare un’agenzia Onu invece dei nostri missionari, pur rispettando la libertà personale, inviterei a valutare le percentuali dei fondi usati per il personale in quelle agenzie e quanto usi invece la nostra Onlus o altre simili alla nostra.
Yukari passava di lì
![]() Yukari passava di lì, quando vide una strana costruzione e vari stranieri che andavano e venivano. Pensò: «Se gli stranieri qui sono i benvenuti, allora accoglieranno bene anche me». Salì una gradinata ed entrò: stava cominciando la messa. Lei non sapeva che quella era una chiesa, in particolare la chiesa di Tong Du Chon dove i nostri padri Tamrat Defar e Patrick Mrosso portano avanti la pastorale dei migranti.
Yukari passava di lì, quando vide una strana costruzione e vari stranieri che andavano e venivano. Pensò: «Se gli stranieri qui sono i benvenuti, allora accoglieranno bene anche me». Salì una gradinata ed entrò: stava cominciando la messa. Lei non sapeva che quella era una chiesa, in particolare la chiesa di Tong Du Chon dove i nostri padri Tamrat Defar e Patrick Mrosso portano avanti la pastorale dei migranti.
Yukari è una donna giapponese nata dalle parti di Osaka e sposata con un coreano. Si sono conosciuti e sposati in Giappone ma, per ragioni di lavoro, lui è cuoco, si sono dovuti trasferire in Corea del Sud. Yukari era in Corea da pochi mesi, non conosceva ancora la lingua ed era triste quel giorno. Entrata in chiesa rimase colpita dalla luminosità dell’edificio. Finita la messa qualcuno si accorse che lei non era una dei soliti fedeli, la invitò a prendere un caffè con gli altri migranti e le spiegò come poté che ogni domenica c’era una scuola di coreano gratis. Fu così che Yukari cominciò a frequentare la comunità di Tong Du Chon e a partecipare alla messa domenicale. Quel giorno, il 6 agosto 2017, le è rimasto impresso nella memoria come uno degli eventi più belli che le siano capitati.
«Ogni volta che partecipavo alla messa – mi dice – sentivo la gioia che entrava in me, in piccole dosi, come pacchettini di gioia e vedevo la luce brillare intorno a me. Allora chiesi a una delle volontarie, insegnante di lingua, cosa dovevo fare per diventare cristiana. Da quel momento cominciai il catecumenato e a Pasqua del 2018 (nella foto: Yukari – a destra – il giorno del battesimo) ricevetti il battesimo e scelsi come nome nuovo quello di Justina».
«Come è cambiata la tua vita da quando sei diventata cattolica?», le chiedo.
«Adesso non ho più paura», mi risponde senza esitare. «Per esempio – mi dice – a metà del 2018 ci fu un forte terremoto nella zona di Osaka e l’epicentro era proprio dove stanno tutti i miei parenti. Normalmente sarei stata terrorizzata, ma quel giorno invece ero serena. Guarda che combinazione – e mi mostra sul suo telefonino un’app in giapponese – quel giorno la Parola di Dio diceva di non temere e di confidare nel Signore».
Adesso Yukari si difende bene col coreano, partecipa al coro e ad altre attività della parrocchia e ha stretto una bella amicizia con le altre volontarie. Parla della sua esperienza anche alle sue amiche giapponesi che vedono ancora Chiesa e cristianesimo come una cosa strana (ricordiamoci che in Giappone solo lo 0.35% della popolazione è cattolico). È attiva, allegra e ha partecipato perfino alla nostra festa della Consolata, incaricata di leggere una preghiera, per mostrare che il Signore continua a chiamare pecore nel suo gregge da qualsiasi terra Lui voglia.
Yukari passava di lì, ma diamo grazie al Signore perché quel giorno c’era anche qualcuno pronto ad accoglierla!
padre Gian Paolo Lamberto
Daejeaon, Corea del Sud, 16/10/2018
Informazione sicura
Caro padre,
[…] sfogliando il numero (di ottobre 2018) ho visto la lettera «Ha ragione Salvini?». Lì si parla in realtà del fenomeno (che è tra lo strambo e il surreale) del gender e delle sue conseguenze ma si cita Salvini che è uno dei simboli […] di questa presunta deriva anti-cristiana.
Ora, Salvini sì o Salvini no, a me interessa poco adesso, quello che mi fa riflettere è che siamo in tempi in cui sostenere ovvietà come il fatto che il matrimonio è tra uomo e donna e un bambino ha un papà e una mamma oppure che i fenomeni migratori vanno regolati e sono comunque un sintomo di squilibri sociali da «riaggiustare», si passa per intolleranti e brutti e cattivi e anche per cattivi cristiani. Ma anche un’opinione (questa sì è un’opinione, diversamente dal fatto naturale che i genitori sono papà e mamma) come lo ius sanguinis… apriti cielo! Non si può. […]
Rimanendo all’immigrazione penso che, nonostante tutto, molti non siano ancora convinti che il fenomeno migratorio Africa-Europa così come lo vediamo non è per nulla spontaneo, come non lo è quello nuovo dall’Honduras verso gli Usa (guarda caso ci sono le elezioni di medio termine in Usa…) e credo che una buona parte della causa di ciò sia nei mass media (diciamo almeno l’80% dei grandi media) che sembrano lì apposta per «formare» l’opinione pubblica invece che informarla. Sono più attori della politica invece che osservatori.
Ancora rifacendomi a cose già dette, se MC fa giornalismo, allora ha una gran responsabilità e c’è un gran bisogno di informare in modo ben ragionato i lettori. Se volete anche formare le pecorelle che credono di essere rimaste all’ovile ne sarò molto felice ma che sia formazione cristiano «sicura», basata non sulle ventate dell’attualità ma sulla Verità e ciò che la Chiesa ha sempre insegnato a ragion veduta. Un saluto
Andrea Sari
15/01/2019
Caro Sig. Andrea,
mi perdoni se ho di nuovo tagliato la sua lunga email. La questione dei migranti è molto complessa e il modo con cui è trattata nei mass media (e dai politici, e non solo quelli nostrani) non aiuta a capire che questa tragedia, vissuta da milioni di uomini che fuggono dalla loro terra e altri milioni che si vedono «invadere», non è «il problema», ma solo l’effetto di problemi ben più gravi, certo non causati dai mass media. Guerre, riscaldamento climatico, sfruttamento sconsiderato delle risorse, dominio incontrollato delle multinazionali, debolezza dell’Onu, dittature, corruzione e altro, sono i veri problemi da affrontare. MC, nel suo piccolo, cerca di dare un’informazione documentata, puntuale e non di moda.