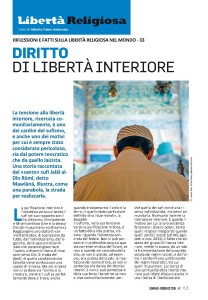I perdenti 13 i Cristeros e il beato Miguel Agustin pro
Nell’indifferenza generale dell’opinione pubblica del mondo, il Messico, tra il 1925 e il 1929, visse un periodo tragico della sua storia. Al governo della Repubblica si era installato un gruppo di potere formato in prevalenza da massoni anticlericali, denominato «gli uomini di Sonora». Tra i vari provvedimenti che essi presero, spicca l’inasprimento delle leggi anti religiose. Con il presidente Plutarco Elia Calles, queste leggi vennero imposte in maniera rigorosa in tutta la Federazione Messicana. Alla Chiesa venne tolta ogni autonomia giuridica, furono espulsi tutti i sacerdoti stranieri e furono confiscati tutti i beni delle istituzioni cattoliche: chiese, conventi, seminari, scuole, istituti di carità, ecc. Dall’agosto del 1925 la Chiesa sparì completamente dalla vita pubblica del religiosissimo popolo messicano. Fu a questo punto che accadde una cosa incredibile: migliaia di persone di ogni condizione sociale si diedero alla macchia dando vita a una insurrezione spontanea, motivata dal fatto che se «Cesare diventa un tiranno, il popolo ha diritto di difendere la propria libertà».
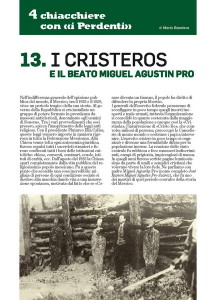
I generali dell’esercito federale pensavano di sconfiggere in poco tempo quegli insorti inesperti e male armati, tuttavia l’organizzazione si consolidò in quanto sostenuta dalla maggioranza della popolazione e nacque così la «Cristiada», l’insurrezione di «Cristo Re», che coinvolse milioni di persone, preoccupò le Cancellerie di mezzo mondo e costrinse i papi a intervenire. L’esercito cristero in poco tempo si organizzò e divenne una formidabile difesa per la popolazione inerme. La reazione dello stato centrale fu rabbiosa e fece massacri indiscriminati, campi di prigionia, impiccagioni di massa.
In quegli anni furono scritte pagine luminosissime da parte di umili e semplici cristiani che volevano vivere la loro fede. Ne parliamo con padre Miguel Agustin Pro (nome completo José Ramón Miguel Agustín Pro Juárez), che fu uno dei martiri di quel periodo convulso della storia del Messico.
Padre Miguel, come ebbe inizio questa tragedia?
Dopo il trentennale governo di Porfirio Diaz, un presidente che si era convertito dopo la morte della moglie, presero il potere elementi giacobini e radicali chiamati «gli uomini di Sonora», i quali fecero approvare dal parlamento una costituzione ferocemente anti religiosa. La Chiesa accusata di essere retrograda e responsabile di tenere il popolo nell’ignoranza dei propri diritti, fu privata di ogni possibilità di intervento sul piano religioso e sociale a favore della popolazione.
Ovviamente questa era una campagna di menzogne fatte circolare ad arte in certi ambienti per privare la popolazione di un supporto istituzionale sicuro.
Mai menzogna nel mio paese fu più ignobile di questa, in quanto i cattolici erano i più attivi nel paese. Il vivace laicato messicano aveva elaborato ambiziosi programmi di sviluppo ispirandosi all’enciclica «Rerum Novarum» di papa Leone XIII; inoltre c’erano associazioni di mutuo soccorso, patronati di beneficenza e una miriade di gruppi che si prendevano cura dei giovani e dei più poveri. C’erano anche molte cornoperative sociali, per aiutare i più bisognosi.
Ma tutto ciò non fu sufficiente a fermare la crudeltà di chi aveva preso il potere.
Certo che no. La requisizione dei beni fu accompagnata da uno spietato controllo poliziesco che impediva ogni forma di manifestazione religiosa pubblica o privata. Questo spinse prima pochi gruppi di persone, poi interi villaggi a darsi alla macchia per conservare gli ideali e i principi religiosi che da secoli caratterizzavano il popolo messicano.
Nasceva così la «Cristiada», una resistenza armata per difendere la Chiesa e i cristiani.
Questi rebeldes, come venivano definiti dal potere massonico, erano in gran parte contadini, ma tra le loro fila vi erano anche operai, impiegati, funzionari, avvocati, studenti e altra gente di città. La lotta era sostenuta, nelle aree urbane, anche da una resistenza passiva che ricorreva a boicottaggi, foiva false informazioni alle truppe federali e, nel contempo, cercava di far continuare la vita sacramentale, come era già avvenuto in passato nell’Inghilterra anglicana e, solo pochi anni prima, nella Russia sovietica.
Quale ruolo ebbero le donne in questa insurrezione?
Migliaia di donne, inquadrate nelle brigate di Santa Giovanna d’Arco, sfidando ogni sorta di pericolo, procuravano munizioni ai Cristeros i quali, lungo gli anni, erano cresciuti di numero arrivando a essere quasi cinquantamila combattenti. A causa dell’assenza dei loro uomini dai villaggi, erano loro a portare avanti il lavoro nei campi, a organizzare incontri di preghiera e a provvedere in ogni modo all’educazione dei figli.
Cosa ha contribuito a far sì che i Cristeros diventassero un’armata capace di tenere in scacco l’esercito regolare?
Enrique Gorostieta, un generale che si definiva ateo ma affascinato dall’ideale dei Cristeros, si era unito ai ribelli e in breve ne era diventato il comandante. Grazie alla sua capacità professionale i Cristeros non persero più una battaglia, sconfiggendo l’esercito federale dovunque, e tenendolo in scacco per anni, nonostante che quest’ultimo godesse di un massiccio appoggio economico e logistico da parte delle logge massoniche degli Stati Uniti.
Una guerra, anche se di difesa, comunque provoca sofferenze, lutti e distruzione.
La prova che il Messico ebbe ad affrontare fu devastante sotto ogni aspetto, il paese restò diviso tra zone controllate dai Cristeros e zone controllate dai Federali. L’economia crollò, i morti furono decine e decine di migliaia, gli storici parlano di circa centomila vittime, contando anche coloro che morirono di malattie e di fame nei campi di prigionia.
La festa religiosa di Cristo Re era stata istituita da Pio XI nel 1925. «Viva Cristo Re» fu il grido che gli insorti adottarono per sostenersi a vicenda nei conflitti che ebbero con i federali.
Il grido di «Viva Cristo Re» si udiva sempre più frequentemente e nella comunità cristiana lo si ripeteva in continuazione. Insieme a questa invocazione si gridava anche «Viva la Vergine di Guadalupe», con ciò si riaffermava la divinità di Cristo Re dell’Universo e ci si poneva con fiducia sotto la protezione della «Morenita» (così il popolo messicano chiama la Madonna di Guadalupe).
La guerra della «Cristiada», con i suoi morti, i suoi martiri e i suoi umili eroi, è poco conosciuta anche in America Latina, al di fuori del Messico è pressoché ignorata.
È vero. Eppure siamo di fronte al caso eclatante di un esercito che vince tutte le battaglie ma perde la guerra perché depone le armi su richiesta dei propri vescovi, e di riflesso della Santa Sede, che volevano evitare un ulteriore bagno di sangue specialmente alla popolazione inerme ed innocente. Non furono le armi a sconfiggere i Cristeros, ma la diplomazia internazionale con gli Arreglos (accordi) del ’29, che ponevano fine agli eventi bellici: la Chiesa accettava pesanti limitazioni pur di mantenere la libertà della pratica religiosa.
I cristiani messicani diedero una bella testimonianza di fede nonostante l’uragano antireligioso che si era abbattuto sul tuo paese.
Nella tormenta di quegli anni il Signore fece emergere persone meravigliose. Voglio ricordare in particolare un adolescente di appena 14 anni: José Luis Sanchez Del Rio, che si unì ai Cristeros diventandone il loro portabandiera. Nel corso di una battaglia il piccolo Josè cedette la propria cavalcatura al generale Luis Guizar Morfin perché si mettesse in salvo dicendogli: «La vostra vita è più utile della mia». Catturato dai federali non gli fu fatto nessun processo ma si accanirono su di lui percuotendolo e seviziandolo, gli spellarono le piante dei piedi, lo fecero camminare sul sale e lo condussero al cimitero, dove esasperati dalle sue continue grida:« «Viva Cristo Re», lo uccisero con un colpo di pistola.
Stessa sorte toccata anche a te o sbaglio?
Nato nel 1891, nel 1911 ero entrato nella Compagnia di Gesù. Inviato a completare gli studi in Belgio, fui ordinato sacerdote nel 1925. Venuto a conoscenza di quanto stava succedendo nella mia patria, chiesi ai miei superiori di tornare in Messico. Una volta rientrato iniziai a svolgere clandestinamente un’intensa attività assistenziale e pastorale, celebrando la Messa nelle case private e portando l’Eucaristia di nascosto agli ammalati e a coloro che me lo chiedevano (a volte oltre 500 al giorno). La mia allegria e la mia chitarra mi aprivano molte porte. Ero anche l’animatore spirituale della Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas, una delle tante organizzazioni nate tra il popolo per resistere alla repressione anticattolica.
E quando ti scoprirono, che successe?
Nel 1927 venni arrestato con la falsa accusa di aver partecipato a un attentato contro il generale Alvaro Obregón, candidato alla presidenza repubblicana. Ignorando tutte le testimonianze in favore della mia innocenza e senza farmi nessun processo, il 23 novembre 1927 mi portarono davanti ad un plotone di esecuzione insieme a mio fratello Humberto. Mentre i soldati scaricavano su di me il piombo dei loro fucili, consegnavo il mio corpo all’amata terra messicana e rendevo la mia anima a Dio gridando: «Viva Cristo Re».
Il 20 novembre 2005 papa Benedetto XVI ha beatificato sia il piccolo José Luis Sanchez Del Rio che padre Miguel Agustin Pro insieme ad altri 11 martiri di quella persecuzione decisa a estirpare il cattolicesimo dal Messico. Oggi possiamo dire che se quel paese è rimasto cattolico lo deve in gran parte a quegli umili, piccoli-grandi eroi, che sacrificarono la vita per la causa del Vangelo e per il diritto alla libertà religiosa. Va detto che gli Arreglos, ovvero gli accordi tra lo Stato Federale Messicano e la Chiesa Cattolica, posero fine alla lotta armata ma non alle malversazioni che il governo centrale continuò a esercitare sulla Chiesa e i suoi fedeli. I Cristeros che fecero ritorno alle loro case, una volta disarmati, subirono numerose e feroci vendette dai militari federali nonostante le garanzie verbali di incolumità loro promesse. Morirono più Cristeros dopo gli accordi che durante la guerra. Vi fu una caccia all’uomo spietata, la repressione andò avanti in forma surrettizia fino alla fine degli anni ’30 e la Costituzione messicana con risvolti anticlericali rimase in vigore fino al 1992.
Quando Papa Wojtyla si recò a Puebla nel 1979, per aprire i lavori dell’Assemblea dell’Episcopato dei paesi latinoamericani, fu accolto dalle autorità messicane come «Signor Wojtyla», ma il calore entusiastico della gente semplice, che Giovanni Paolo II sperimentò lungo le strade del Messico, fece capire al Papa e al mondo intero che il sacrificio dei Cristeros non era stato consumato invano.
Don Mario Bandera, Missio Novara
Video e films.