Perù. L’avanzata del fujimorismo
«Il Congresso ha sferrato un nuovo colpo. Questa volta contro la società civile», così lo scorso 13 marzo il quotidiano la República ha commentato la decisione del parlamento del Perù di modificare la legge 27692 istitutiva dell’Agenzia peruviana per la cooperazione internazionale (Apci). Le modifiche approvate autorizzano il controllo sulle attività delle organizzazioni della società civile che ricevono finanziamenti dalla cooperazione internazionale, aprendo la porta a restrizioni ingiustificate, arbitrarietà e censura.
L’approvazione del Congresso è avvenuta senza ostacoli con 81 voti a favore e soltanto 16 contro mentre quattro congressisti si sono astenuti. Dei dodici partiti presenti soltanto i tre (piccoli) partiti della sinistra si sono opposti. «Non possiamo permettere che il discorso sui diritti umani venga utilizzato come arma ideologica per minare l’autorità dello Stato e delegittimare il principio di ordine», ha spiegato la presidente Dina Boluarte.

Gli scopi reali sono però altri. Secondo l’Instituto de defensa legal, la legge «cerca di eliminare le Ong con sanzioni e multe multimilionarie per atti come “lo svolgimento di attività che influenzano l’ordine pubblico”. La persona che determinerà cosa costituisce “un’alterazione dell’ordine pubblico” sarà un funzionario dell’Apci. La nuova legge stabilisce che questo organismo ha il potere di respingere i progetti che non approva [….] il colpo di grazia è rivolto alle Ong per i diritti umani, alle quali è impedito di difendere i casi in cui lo Stato viene citato in giudizio. Ad esempio, […], i parenti dei leader ambientalisti assassinati e le famiglie delle vittime delle proteste del 2022 e del 2023 sono rimasti senza assistenza legale gratuita. Come si può vedere, questa legge è assolutamente incostituzionale perché lede il diritto alla libertà di associazione, il diritto alla difesa, l’accesso alla giustizia e viola molti trattati internazionali sui diritti umani sottoscritti dal Perù».
«Le Ong sono in crisi da molto tempo e per varie ragioni. Sono isolate e deboli. Molta gente ne parla male per ragioni razziali (sono in mano a bianchi) e religiose (sono in favore dell’ideologia gender). Premesso questo, il vero scopo del Congresso è quello di silenziare le voci discrepanti e chiunque possa intentare processi contro lo Stato peruviano. Una deriva pericolosa», ci ha spiegato Wilfredo Ardito Vega, giurista esperto in diritti umani e professore alla Pontificia universidad católica del Perú (Pucp).
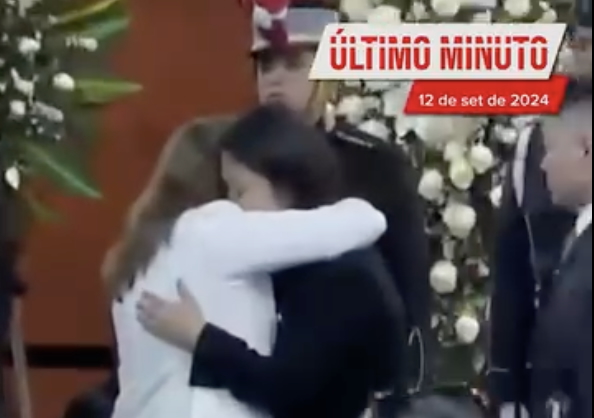
Molto duro il commento di Gianni Vaccaro, da una vita in Perù, trait d’union tra l’Italia e le Ong peruviane: «Contro le Ong hanno votato tutti i partiti legati a Keiko Fujimori e all’economia illegale che oggi in Perù produce più ricchezza dei comparti economici legali. L’economia illegale è quella legata al narcotraffico, all’attività mineraria informale, alla tratta di persone, alla prostituzione, alle estorsioni sempre più diffuse».
La legge anti Ong s’inserisce in una situazione complessiva pesante. Secondo recenti inchieste (Datum-El Comercio), addirittura il 93 per cento dei peruviani boccia la gestione della presidenta Dina Boluarte e del suo governo. Ne è stata ulteriore prova la manifestazione dello scorso 21 marzo. Migliaia di persone hanno attraversato le vie di Lima per protestare contro la delinquenza, ma soprattutto contro la presidenta, il Governo e il Congresso.
Sarà interessante vedere cosa accadrà da qui alle elezioni di presidente e Congresso appena fissate per il 26 aprile del 2026. Non pare ottimista Signos, la rivista del prestigioso Istituto Bartolomé de Las Casas, fondato da padre Gustavo Gutiérrez: «Entriamo in un anno pre elettorale, in un contesto reso strano dal consolidamento di una coalizione corrotta, mafiosa e autoritaria che ci governa e cerca di perpetuarsi al potere e che, quindi, farà tutto il possibile per controllare il processo elettorale del 2026».
Paolo Moiola
