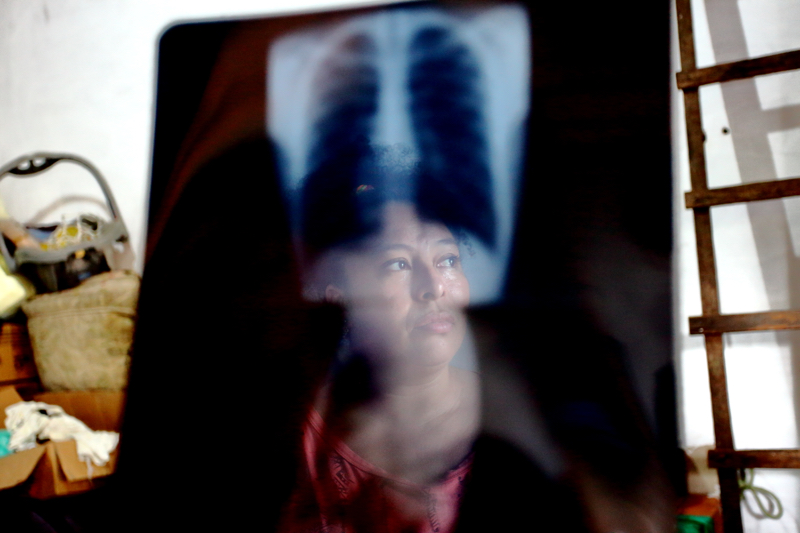Brasile. Voci di donne dalle favelas
Povertà, criminalità e promiscuità: di solito, sono queste le parole che descrivono le «favelas», luogo simbolico del Brasile. Proviamo a capirle attraverso donne di favela come Carolina Maria de Jesus (morta nel 1977) e Marielle Franco (assassinata nel 2018). Oggi altre donne seguono il loro esempio di lotta e speranza.
Delle favelas si parla molto, e forse ancora di più è stato scritto: libri, articoli e indagini accademiche. Ma quante voci hanno parlato della favela dalla favela? Quante volte abbiamo avuto la possibilità di ascoltare, direttamente e senza filtri, un racconto autentico proveniente da quel luogo «non luogo», incastonato nell’immaginario collettivo e diventato sinonimo, per molti, di povertà, criminalità e promiscuità? Si potrebbe rispondere poche, o quantomeno poche sono quelle arrivate dal Brasile fino alle nostre latitudini, permettendoci di aprire una finestra su quel mondo. Un mondo troppo spesso raccontato proprio da coloro che hanno contribuito a creare e alimentare l’emarginazione sociale materializzata nelle favelas.
Un nome che ha brillato negli ultimi anni per averle raccontate dal di dentro è sicuramente quello della compianta Marielle Franco: donna appartenente al collettivo Lgbtiq+, afrobrasiliana, madre single, politica, attivista per i diritti delle donne e baluardo contro tutte le discriminazioni del sistema capitalista, colonialista e patriarcale ben personificate dal presidente Jair Bolsonaro.

Marielle, favelada di Rio de Janeiro
Marielle Franco, cria da favela da Maré (figlia della favela Maré) con una laurea in sociologia in tasca, ha rappresentato per molti anni una voce forte e determinata contro i soprusi vissuti dai favelados (abitanti della favela) di Rio de Janeiro.
Le parole di Marielle, prima come attivista, poi come consigliera comunale (vereadora) di Rio de Janeiro, avevano colpito l’apparato di repressione della polizia che, fino a quel momento, aveva operato quasi completamente nel silenzio delle autorità amministrative (e spesso con il loro beneplacito). Parole tanto forti da essere silenziate con 13 colpi di pistola. Era il 14 marzo del 2018. Quella notte, in un vile attentato le cui responsabilità sono ancora da chiarire, Marielle è stata uccisa insieme al suo autista Anderson Gomes.
Si spegneva dunque un baluardo delle rivendicazioni di una popolazione emarginata, non solo a Rio de Janeiro e non solo nelle favelas. Allo stesso tempo, però, fiorivano migliaia di altre Marielle che dal sangue del suo martirio hanno trovato forza, ispirazione e coraggio.
Carolina, favelada di São Paulo
Lo stesso giorno in cui Marielle Franco veniva uccisa, si celebravano i 114 anni della nascita (14 marzo 1914) di Carolina Maria de Jesus, la prima voce afrobrasiliana delle favelas a ottenere rilevanza mondiale. Un filo conduttore, dunque, ci porta da Rio de Janeiro a São Paulo e lega due donne afrobrasiliane che hanno vissuto la favela ma soprattutto hanno usato la loro voce come strumento di lotta politica, denuncia sociale e rivendicazione di diritti umani fondamentali. Negli anni Sessanta,
Carolina ha preso «a pugni» il Brasile e il mondo squarciando il velo che copriva le reali condizioni di vita dei favelados. Dal cuore della favela Canindé, sulla riva del Tietê nella metropoli di São Paulo, la voce di Carolina è emersa in modo prepotente raccontando senza filtri il dolore e la fame.
Nata il 14 marzo del 1914 a Sacramento, nello stato di Minas Gerais, successivamente emigrata nella metropoli paulense per lavorare come domestica e raccoglitrice di carta e ferro per la strada (lavoro ancora molto comune), Carolina ha vissuto di stenti e patimenti, lottando ogni giorno contro un mondo ostile, fatto di difficoltà, discriminazione, violenza e precarietà. Il suo unico rifugio era la scrittura, passione alla quale dedicava il poco tempo nel quale non lavorava, non doveva preoccuparsi dei suoi figli e non era così stanca da crollare sul giaciglio della sua baracca.
Carolina ha coltivato sempre la speranza di vedere un giorno pubblicati i suoi scritti e di poter abbandonare la favela, luogo del suo quotidiano supplizio, un vero e proprio inferno in terra. Sapeva di non essere una raffinata ed erudita intellettuale, non aveva avuto accesso alle migliori scuole dell’élite bianca che governava (e che governa) quel Brasile in piena rivoluzione modernista, ma lei sapeva leggere e scrivere quanto bastava per consegnare a un diario le sue riflessioni, paure, speranze e sogni. Dopo alcuni tentativi falliti di pubblicizzare il suo lavoro di scrittrice, è stata scoperta dal giornalista Audálio Dantas che stava lavorando a un articolo sulle favelas. Quell’articolo, dove si parlava di Carolina e si faceva cenno ai suoi scritti, è stato poi pubblicato sul giornale O cruzeiro il 10 giugno 1959: Carolina Maria de Jesus aveva 45 anni e finalmente aveva realizzato il suo sogno. Ciò però che lei ancora non sapeva era che quello sarebbe stato solo l’inizio del suo viaggio. Infatti, tutto il suo diario, pubblicato inizialmente suddiviso in articoli sullo stesso giornale, sarebbe poi stato redatto in forma di libro nel 1960, causando un vero terremoto letterario.

La fame è questa
Preso il titolo di Quarto de despejo: Diário de uma favelada («Stanza della discarica: diario di un’abitante della favela»), l’opera di Carolina è stata tradotta in più di dieci lingue, arrivando a vendere oltre 100mila copie.
Il libro è di una crudezza che ferisce, le parole vengono usate con una ingenuità che lacera e stordisce. I messaggi sono diretti, essenziali, ma di una forza che obbliga molte volte a distogliere gli occhi dal libro, prendere fiato e lasciare che i sentimenti prendano il sopravvento. Carolina scrive e parla all’altro Brasile, quello che non vive nella favela e che non la conosce, il Brasile bianco, «educato», che non deve preoccuparsi ogni giorno di procurarsi un pezzo di pane.
Racconta la sua vita, la sua quotidianità, la fame. Questa parola, «fame», ritorna in modo costante, scandendo le giornate che si susseguono nel diario, quasi fosse la routine di una condannata: una litania che ci accompagna tra le pagine che raccontano la favela di Canindé, a São Paulo, tra gli anni 1955 e 1959.
Sono riflessioni asciutte, a volte semplici ma taglienti e penetranti, come le seguenti:
«21 luglio 1955 – Quando sono tornata a casa erano le 22:30. Ho acceso la radio. Ho fatto una doccia. Ho scaldato il cibo. Ho letto un po’. Non so dormire senza leggere. Mi piace avere tra le mani un libro. Il libro è la migliore invenzione dell’uomo».
«8 maggio 1958 – È necessario conoscere la fame per saperla descrivere».
«10 maggio 1958 – Il Brasile ha bisogno di essere gestito da una persona che ha già provato la fame. La fame è una grande maestra. Chi soffre la fame impara a pensare agli altri e ai bambini».
«13 maggio 1958 – Sono andata a chiedere del lardo alla signora Alice. Mi ha dato il lardo e il riso. Erano le 21 quando finalmente ho potuto mangiare. E così il 13 maggio 1958 (settantesimo anniversario dell’abolizione della schiavitù in Brasile, ndr) io ho combattuto contro l’attuale schiavitù, la fame!».

«Esiste una favela in paradiso?»
Carolina era molto credente, anche Dio è spesso presente nelle sue riflessioni che provano a giustificare una situazione difficile, di estrema povertà e abbandono da parte delle istituzioni. I suoi sentimenti, tracciati esplicitamente nelle pagine del diario o comprensibili attraverso ciò che non è scritto ma che traspare dalle parole da lei usate, sono altalenanti. Passa da una fiducia cieca nella Divina Provvidenza a uno sconforto profondo che le fa pensare al suicidio. Uno dei passaggi più duri ed eloquenti su questo tema si trova alla data del 3 giugno 1958: «Quando sono a corto di soldi, cerco di non pensare ai miei bambini che chiederanno pane, ancora pane e caffè. Devio i miei pensieri al paradiso. Penso: ci sono persone lassù? Sono migliori di noi? Il loro dominio supererà il nostro? Ci sono nazioni così varie come qui sulla terra? O è un’unica nazione? Esiste una favela? E se c’è una favela lì, io vivrò nella favela anche quando morirò?».
Il diario di Carolina è stato ripubblicato più volte. In Italia, è famosa l’edizione del 1962 di Bompiani, con la prefazione di uno dei più importanti intellettuali italiani del XX secolo, Alberto Moravia.
Dopo Stanza della discarica, Carolina ha pubblicato altri testi che, seppur ben accolti dalla critica e dal pubblico, non hanno replicato il successo del primo.
Carolina, scrittrice afrobrasiliana, donna coraggiosa e insorgente, è scomparsa all’età di 62 anni (era il 13 febbraio del 1977) senza aver mai potuto abbandonare del tutto la povertà e la precarietà.
La notorietà acquisita con Quarto de despejo non le ha procurato la ricchezza sperata, anche se le ha permesso di migliorare la sua condizione e di lasciare la favela di Canindé nel 1963, dove era arrivata 16 anni prima, nel 1947, all’età di 33 anni e incinta.
![]()
«Cenerentola negra»
Dopo la sua morte, sono stati pubblicati postumi una serie di lavori editoriali che raccoglievano il materiale prodotto da Carolina e che non aveva ancora visto la luce in forma di libro. Carolina Maria de Jesus ha inaugurato un nuovo filone nella tradizione nella letteratura brasiliana, partendo dall’appropriazione della lettura da parte delle classi popolari. Il suo lavoro è stato una grande fonte d’ispirazione per altre donne non appartenenti alle classi agiate, che hanno cominciato a scrivere sotto l’influenza di Carolina.
Un elemento che colloca la sua voce tra le grandi personalità della letteratura brasiliana, come riconosciuto nel 2021 anche dall’Università federale di Rio de Janeiro che ha concesso alla scrittrice afrobrasiliana il titolo di dottore honoris causa postumo.
São Paulo e il Brasile riconoscono oggi il valore storico, culturale, antropologico e simbolico di quelle parole arrivate dalla Stanza della discarica. Parole che mostravano una «razzializzazione» della povertà (una povertà cioè che aumenta di pari passo con la tonalità più scura della pelle) e che, per la prima volta, provenivano da dentro la favela, aggirando le fredde analisi urbanistiche, statistiche e sanitarie di giornalisti, politici e specialisti.
Diversi sono stati gli omaggi riservati a Carolina Maria de Jesus in questo 2022. Uno dei più importanti è stato sicuramente la mostra ospitata dal prestigioso Instituto Moreira Salles, che si trova nell’Avenida Paulista, luogo simbolo del potere economico brasiliano: «Carolina Maria de Jesus: un Brasile per brasiliani».
L’istituto Moreira Salles aveva già contribuito in passato a riconoscere l’importanza della figura di Carolina Maria de Jesus, quando ad esempio, il 14 marzo 2014 (per il centenario della sua nascita) proiettò per la prima volta in Brasile un documentario, realizzato nel 1975 dalla televisione tedesca West Germans intitolato «Favela: la vita in povertà», con la stessa Carolina protagonista.
Altro omaggio è stato fatto il 23 aprile, durante il primo carnevale post pandemia di São Paulo, nel quale la sua figura è stata onorata dalla scuola Colorado do Brás con il tema: «Carolina, a Cenerentola Negra do Canindé». La scuola ha raccontato, in un corteo emozionante, la storia della scrittrice di Sacramento, passando per la città di Franca (dove Carolina aveva iniziato a vivere con un gruppo circense) e arrivando poi a São Paulo nella favela di Canindé. Svelando un volto doloroso del Brasile, la vita di Carolina è stata raccontata con serietà e rispetto dalla scuola, cosa che non ha impedito al corteo di essere colmo di bellezza e colori.
Diego Battistessa

Nascita del termine «favela»
All’inizio era (soltanto) una pianta
Forse pochi sanno che favela è il nome dato in Brasile a una pianta endemica (cnidoscolus quercifolius) e che la diffusione di questo termine in ambito urbano si relaziona con la «Guerra de Canudos» (1896-1897) che ebbe luogo nel sertão di Bahia. La città di Canudos, scenario di uno scontro politico religioso si ergeva in mezzo ad alcune colline, tra le quali vi era il Morro da Favela (Collina della Favela), così battezzato perché ricoperto dall’omonima pianta.
Dopo la guerra, una parte dei soldati reduci dal conflitto, fecero ritorno a Rio de Janeiro ma, trovatisi senza stipendio, decisero di stabilirsi dentro alloggi precari da loro costruiti nel Morro da Providência (Collina della Provvidenza). Data una certa similitudine tra lo scenario di questa nuova sistemazione e la Collina della Favela vista a Canudos, i soldati battezzarono il nuovo insediamento Morro da Favela.
È da quel momento che gli insediamenti di alloggi e case di fortuna, dove risiedono persone con un basso (o quasi nullo) potere d’acquisto, passarono a essere chiamati favelas. Le favelas sono presenti in tutto il Brasile (circa 800 solo a Rio de Janeiro) e si stima che siano abitate da 15-20 milioni di persone.
WIKIFAVELA
Considerati questi numeri non c’è da stupirsi che si parli tanto di favelas brasiliane. Vale la pena di segnalare un progetto dedicato a Marielle Franco, ovvero il portale «Wikifavela», un dizionario virtuale che combatte la discriminazione in Brasile. Proprio dal sito, disponibile in portoghese, inglese e spagnolo, possiamo leggere che: «Il Dizionario della favela è una piattaforma virtuale ad accesso pubblico per la produzione e la diffusione della conoscenza delle favelas e delle loro periferie. Mira a stimolare e consentire la raccolta e la costruzione delle conoscenze esistenti sulle favelas, collegando una rete di partner nelle università e nelle istituzioni e collettivi esistenti in questi territori. Il Dizionario della favela continua la lotta della consigliera comunale di Rio de Janeiro Marielle Franco e di molti altri leader della comunità contro il pregiudizio e l’esclusione, costruendo una società più giusta ed egualitaria».
Importante ricordare anche l’Instituto Marielle Franco, uno spazio creato dalla famiglia della defunta attivista che vuole continuare a lottare per la giustizia, difendendo la sua memoria, moltiplicando la sua eredità e annaffiando i suoi semi.
D.B.

Chi è la possibile erede
«Mi chiamo Renata Souza»
Renata Souza è già un simbolo. Lei è una «favelada» della Maré, figlia cioè dello stesso complesso di favelas al Nord di Rio de Janeiro dove è nata e cresciuta Marielle Franco, sua grande amica e fonte di ispirazione. Souza, 40 anni, deputata dell’Assemblea legislativa di Rio de Janeiro dal 2018, è già una figura politica di spicco, un grimaldello che apre i palazzi del potere e che permette l’accesso della periferia marginalizzata ed esclusa nelle sale dove si prendono le decisioni importanti.
Niente è stato facile (e non lo è tutt’ora) per Souza, nel Brasile governato da Jair Bolsonaro dove razzismo, classismo e machismo sono all’ordine del giorno. Renata ricorda che una delle decisioni più importanti della sua vita la prese quando aveva solo 15 anni: decise che sarebbe diventata giornalista perché voleva raccontare la favela in modo diverso da come i media la dipingevano, senza pregiudizi, senza spettacolarizzazione della povertà e della violenza.
Nel percorso universitario conobbe Marielle, e tra le due nacque un’amicizia forte, mischiata a militanza, attivismo e lotta politica. Nel 2006 Souza, che già svolgeva il suo lavoro/missione di reporter dalla favela, accettò di unirsi alla campagna elettorale di Marcelo Freixo (il 3 ottobre candidato di sinistra a governatore di Rio de Janeiro). Da quel momento non lasciò più la politica accompagnando la sua amica Marielle durante le elezioni e diventando il suo capo di gabinetto. Fino al 14 marzo del 2018, quando per lei il mondo cambiò completamente. L’omicidio di Marielle le provocò una ferita che ancora non si è rimarginata. Il dolore fu enorme, il più grande della sua vita, ripete Souza nelle interviste, ma la spinse a fare un ulteriore passo in avanti. Nelle elezioni del 2018 fu la candidata di sinistra più votata e da quel momento è stata una delle voci più determinate nell’emiciclo dell’assemblea di Rio de Janeiro.
Per il suo impegno ha ricevuto minacce di morte da gruppi affini al «bolsonarismo» e ha dovuto abbandonare la favela. Da deputata ha promosso una legge per dare priorità alle indagini sugli omicidi di bambini e adolescenti oltre a varie misure per combattere «la violenza ostetrica» contro le donne afrodiscendenti. Alle elezioni dello scorso 3 ottobre è stata eletta deputata statale di Rio de Janeiro con 174.132 preferenze. In questo ruolo cercherà di portare ancora più in alto la voce della favela, le rivendicazioni del femminismo afrodiscendente e la lotta per i diritti umani.
D.B.