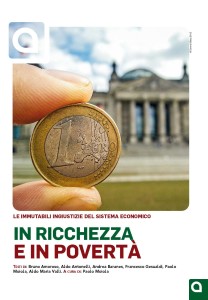Albania: Il call center dell’Europa
Durante la lunga dittatura comunista l’isolamento del paese era scalfito soltanto dalle televisioni commerciali italiane. L’italiano divenne la lingua straniera più parlata. Dopo l’arrivo (nel 1992) di un regime più democratico, l’Albania è rimasta un paese con molte contraddizioni ma in rapida crescita. Il sistema economico liberista e i bassi salari hanno attratto consistenti investimenti. Con l’Italia in prima fila.
Non c’è paese dove l’Italia sia più rilevante, eppure per la maggioranza degli italiani l’Albania rimane il più lontano dei posti vicini: un «Oriente sotto casa». Tra le due sponde adriatiche la storia ha pesato più della geografia. Nei due millenni dell’era cristiana, il navigatissimo canale d’Otranto ha funto anche da fossato culturale: di qui Roma, Rinascimento e capitalismo; di là Bisanzio, Impero Ottomano e comunismo. In tempo di Guerra fredda, l’Italia costituzionale fu ben lieta di scordare l’ex colonia mussoliniana. Paradosso dei paradossi, in quegli stessi anni le nostre Tv commerciali esercitarono un ineguagliabile potere fascinatorio sulle vittime del comunismo più isolato d’Europa. Frutto della contingenza internazionale, questa sorta di colonialismo involontario riuscì la fare ciò che il fascismo non avrebbe osato sognare: fece dell’italiano la seconda lingua d’Albania, e dell’Italia «Lamerica» degli albanesi. A venticinque anni dall’attracco della nave Vlora al porto di Bari (8 agosto 1991; si legga a pag. 27, ndr), sebbene risiedano in Italia mezzo milione di albanesi, è ancora difficile parlare di «reciproca conoscenza». Questo perché tra i due paesi il rapporto non è mai stato alla pari. I pregiudizi degli anni Novanta sono finalmente tramontati, ma allo «stereotipo leghista» è andata via via sostituendosi una narrazione giornalistica tanto positiva quanto plastificata: l’Albania indicizzata su Google è un paese dinamico che ha davanti a sé la crescita che gli italiani hanno già consumato. Buona o cattiva che sia, anche questa semplificazione non rende giustizia alla realtà: è un disinteresse con il segno più. Chi, da italiano, voglia conoscere l’Albania, dovrà smettere di usare se stesso come unità di misura. «Mi ricorda il Sud Italia del dopoguerra» o «il mare è bellissimo, sembra la Grecia» sono frasi che parlano di noi.
In questo articolo proveremo a fare un po’ d’ordine partendo dalla storia per arrivare fino ai giorni nostri.
Dentro i confini del 1913
Gli albanesi esistono da prima del loro stato. Sulle origini (illiriche?) della lingua e dell’etnia albanese esistono discussioni accorate ma meno studi, quello che è certo è che sangue e idioma furono le basi ideologiche della Rilindje, il Risorgimento albanese. Inizialmente restii ad abbandonare la compagine ottomana, i patrioti che il 28 novembre 1912 proclamarono da Valona la nascita dell’Albania – nello stesso simbolico giorno in cui, cinquecento anni prima, l’eroe nazionale Skanderbeg aveva dichiarato guerra ai turchi dal suo feudo di Kruja -, lo fecero con il placet della potenze europee, nel tentativo di arginare l’espansionismo serbo e greco che, da Nord e da Sud, spingeva sulle province albanesi della Sublime Porta (termine indicante l’Impero ottomano, ndr). La nascita dello stato albanese somiglia a quella di altri stati emersi dalla dissoluzione dei grandi imperi multietnici. È una storia fatta di visione e di afflato ideale, ma anche di contingenza e di realismo politico. Il riconoscimento internazionale arrivò nel luglio 1913, durante la Conferenza di Londra (sostenitrice della necessità di uno stato albanese era proprio l’Italia liberale). Nel febbraio dell’anno seguente gli stati europei fissarono confini e governo del Principato d’Albania: per dare un’idea del livello di empatia che gli albanesi del tempo dovettero provare nei confronti del nuovo assetto statuale basti ricordare che a insediarsi sul trono fu un perfetto estraneo: il principe Guglielmo di Wied, uno dei nipoti della Regina Elisabetta di Romania. Giunta al porto di Durazzo il 7 marzo 1914, sotto la protezione di una sparuta milizia olandese, la famiglia reale resistette fino al 3 settembre, quando una rivolta la costrinse ad abbandonare il paese. Da quel giorno, l’indipendenza formale dell’Albania ha subito diverse interruzioni – all’occupazione italiana durante la Grande guerra seguirono il debole regno di Zog, l’occupazione fascista del 1939 e mezzo secolo di comunismo – ma i confini stabiliti dagli ambasciatori del 1913, i quali non includono tutti gli albanesi entici, sono gli stessi dell’Albania odierna.
Il comunismo di Hoxha
Questi precedenti giocarono un ruolo determinante all’indomani della II guerra mondiale. Scelto dagli iugoslavi nel fuoco della Resistenza condotta contro i nazisti che dopo l’8 settembre avevano occupato i territori italiani della Balcania (Badoglio lasciò in Albania 130 mila soldati privi di ordini), il comandante partigiano Enver Hoxha governò l’Albania comunista dal 1944 al 1985 (anno della sua morte) combinando spregiudicate alleanze internazionali a un discorso politico nazionalista di stampo appunto risorgimentale. Nei primi anni del dopoguerra l’Albania sembrava avviata a diventare la settima repubblica della Federazione Jugoslava, ma nel giugno del 1948 Stalin ruppe con Tito. Per conservarsi al potere, Hoxha preferì schierarsi con l’Urss, lasciando il Kosovo alla Jugoslavia e resuscitando sul piano interno la secolare narrazione anti serba. Un decennio dopo, il copione sarebbe stato simile: ribelle alle ingerenze sovietiche dello «slavo Krusciov» l’Albania Popolare siglò un’improbabile alleanza con la Cina di Mao: tra gli applausi dell’Occidente, i sottomarini sovietici abbandonarono i porti mediterranei mentre la scelta dottrinaria del marxismo-leninismo isolava il piccolo paese balcanico anche all’interno del Secondo mondo (quello, appunto, orbitante attorno all’Urss).
Il comunismo albanese fu una risposta violenta ai bisogni di una società agropastorale, rimasta a livelli di vita primordiali: ad appena un milione di abitanti – per l’80% contadini poveri, con il 9% della terra del paese a disposizione – un leader finalmente «autoctono» offrì la possibilità di credere al progresso materiale della propria patria. Il prezzo pagato dagli albanesi per la modernizzazione realizzata da Hoxha non è ancora materia di storici altrettanto «locali». Le difficoltà che gli albanesi incontrano nella rielaborazione del loro passato recente si devono al fatto che in quella dittatura «il comunismo» fu poco più di una grammatica dell’economia e della propaganda: una lingua straniera utilizzata per adattare al contesto della Guerra fredda quella peculiare narrazione etnica che affonda le sue radici nell’identità culturale albanese e il cui frutto moderno è, appunto, lo stato albanese. Studiare il regime enveriano implicherebbe la sua comprensione all’interno della storia che lo ha preceduto; se, ancora oggi, quest’operazione viene rimandata è perché l’intoccabile mito nazionalista fonda anche l’Albania democratica. Purtroppo, nessuna coscienza storica ha mai illuminato il cammino della nascente democrazia albanese: né a livello accademico, né a livello di élite politiche. Il risultato, visibile, sono ferite non rimarginate. Lasciate senza spiegazioni, le persone comuni, cresciute lacerate tra due mondi, sanno soltanto che si stava peggio (o meglio) «quando c’erano i comunisti»: come se anche questi ultimi fossero invasori venuti da fuori.
Passaggi complessi
L’Albania è uno stato balcanico e in quanto tale si pensa e si racconta come «unico» (il nazionalismo balcanico è fondato sull’appartenenza etnica) e «mutilato» (non soltanto del Kosovo, ma anche di parte della Macedonia e del Sud della Grecia). Nel 2014 hanno fatto il giro del mondo le immagini di Serbia-Albania, partita valida per la qualificazione all’Europeo di Francia, sospesa per rissa dopo che un drone telecomandato aveva fatto piovere sullo stadio una bandiera dell’«Albania etnica» munita di Kosovo. L’accaduto venne derubricato a «poco edificante folklore sportivo», ma non sfuggì alle cancellerie europee la rinuncia del primo ministro albanese Edi Rama alla storica visita in programma pochi giorni dopo a Belgrado (gli ultimi leader a incontrarsi erano stati Hoxha e Tito, nel 1948). Se il mito risorgimentale della nazione rimane il discorso politico più comprensibile all’opinione pubblica interna, l’Europa è oggi presente nelle esternazioni di tutti i politici albanesi, indipendentemente dall’appartenenza di partito. Come lo stesso Rama ama ricordare in ogni visita all’estero, «l’Albania è il paese più europeista d’Europa». Un’asserzione che contiene elementi di verità, ma che non indaga le ragioni di questa propensione. Per la maggior parte degli albanesi l’Ue – che il giornalismo albanese confonde volentieri con la Germania di Angela Merkel – è un club di paesi ricchi dal quale non si vuole venire esclusi. Che l’integrazione esiga dei doveri è chiaro a tutti, ma che questa implichi il superamento culturale dell’idea di confine nazionale non è ben spiegato ai cittadini albanesi: né dai propri politici nazionali, ferventi europeisti anzitutto quando parlano in inglese, né dalla delegazione della Commissione europea aperta a Tirana, che con i suoi report monitora l’avanzamento delle riforme necessarie all’apertura dei negoziati d’adesione, faticando a rendersi comprensibile al di fuori di una ristretta cerchia di privilegiati della capitale.
Lo sbandierato «europeismo» di un’Albania, che – dal 2014 – è ufficialmente candidata all’Ue, va dunque collocato all’interno di quella generica e ingenua «esterofilia» che ha accompagnato il passaggio del paese dal socialismo paranoico al liberismo selvaggio. Da questo punto di vista, la discontinuità incarnata dal governo Rama si ridimensiona.
Dopo Sali Berisha
Le elezioni politiche del 2013 hanno posto fine all’era di Sali Berisha – il leader del Partito democratico (la destra albanese) che dal 1992 aveva gestito, seppur con qualche interruzione, la transizione dal comunismo. Ma, nonostante la vittoria di una ritrovata coalizione socialista, la strategia economica del paese rimane appiattita sul paradigma neoliberista: apertura alla delocalizzazione estera, riassorbimento della domanda di lavoro affidato agli investimenti stranieri, nessuna tutela per i lavoratori albanesi che rimangono in patria. La proliferazione di call center internazionali che lucrano sul plurilinguismo dei giovani retribuendolo 200 euro al mese è la manifestazione più simbolica dell’assenza di politica nazionale. Più di dieci anni fa, sulle pagine di questa stessa rivista, Pier Paolo Ambrosi osservava che «finché una parte importante della popolazione, a causa delle serie condizioni di povertà in cui vive, rimane praticamente esclusa dal circuito economico, essa non avrà alcun legame né interesse verso le forme di pratica della democrazia». Questa drammatica considerazione è altrettanto attuale oggi, e trova conferma nelle promesse clientelari che precedono ogni tornata elettorale, nell’elezione del faccendiere Ilir Meta a presidente del parlamento, nelle proteste di diversi governi europei per le domande d’asilo che ancora giungono dall’Albania e nel fenomeno di «spedizione» di minori non accompagnati denunciato di recente proprio dai servizi sociali italiani. I gommoni non ci sono più, ma la corruzione, il disagio sociale, la disillusione e il conseguente sogno d’emigrazione a tutti i costi sono lungi dall’essersi esauriti.
Tra corruzione e riforme
Per cercare di traghettare il paese nel futuro, il nuovo governo «socialista» ha rilanciato con abilità l’immagine dell’Albania all’estero – talvolta sbandierando che «qui da noi non ci sono i sindacati», talvolta ottenendo importanti riconoscimenti come l’agognata candidatura all’Europa – ma ha anche affrontato difficili riforme, come quella dell’Università, mirata a fare ordine nel caotico panorama degli istituti privati, e quella della giustizia, che dovrebbe aprire la strada a una magistratura finalmente indipendente. Nonostante la corruzione del sistema politico e sebbene il parlamento continui a dimostrarsi permeabile agli interessi della criminalità organizzata, la riforma della giustizia è passata all’unanimità. La stampa internazionale e le istituzioni europee hanno salutato con soddisfazione il «risultato epocale», fingendo di non sapere che nei giorni immediatamente precedenti la delegazione Ue e l’ambasciatore americano in persona avevano minacciato i deputati albanesi di pesanti ritorsioni nel caso in cui avessero votato contro. In attesa che il futuro ci dimostri che in questo caso il fine europeo ha giustificato i mezzi, è doloroso constatare come una volta superato lo strapotere di Berisha la «democrazia albanese» non possa ancora togliersi le virgolette.
Ammessi i ritardi socio economici, dopo vent’anni di sviluppo caotico ma ininterrotto, l’Albania continua a possedere un notevole potenziale. Stiamo parlando di un paese demograficamente giovane, straripante di bellezze naturalistiche e seduto su un invidiabile patrimonio storico: al confine (strategico) tra Oriente e Occidente, balcanica ma non iugoslava, ex comunista ma non ex sovietica, musulmana ma occidentalizzata, la storia di questo piccolo stato è costellata di apparenti contraddizioni che una volta accettate dal popolo, che ne è custode, potrebbero sprigionare la loro inestimabile ricchezza.
Statue, piramidi, rifugi
Per godere delle contraddizioni albanesi, basta una passeggiata nel centro di Tirana: una città cui la speculazione edilizia degli anni Novanta ha negato per sempre l’aggettivo «turistica», ma che anche per questo risulta interessante a tutti i visitatori stranieri, peraltro in crescita esponenziale. Facciamo due passi in piazza Skanderbeg: in quale altra piazza del mondo s’incontrano a distanza di pochi metri gigantismo sovietico, neoclassico italiano e una moschea ottomana? Circondato dal pastiche architettonico dei dominatori stranieri, al centro della piazza campeggia la statua equestre dell’eroe dell’etnia: uno Skanderbeg invincibile, mitologico e, in quanto tale, poco propenso a valorizzare le strepitose contaminazioni che, certo figlie delle sconfitte, hanno reso unica l’Albania. Pochi metri più a Sud, lungo il boulevard di costruzione italiana, si trova la «Galleria nazionale delle arti». Se al suo interno un piano è dedicato alle opere del regime, la celebre statua di Stalin che, fino al 1968, occupava il posto di Skanderbeg è nascosta, incappucciata, dietro l’edificio. Nello stesso oblio versa l’incredibile piramide che la figlia del dittatore volle erigere a memoria del padre (1988). Per tutta la transizione democratica, questi segni, fonte di fascino e d’interesse per i forestieri, sono stati ragione d’imbarazzo per gli albanesi: il «Baffo» è rimasto in punizione dietro la galleria che poteva ospitarlo e la piramide, altrettanto abbandonata, ha rischiato a più riprese la demolizione. Soltanto nel novembre 2014, in occasione dei 70 anni dalla Liberazione, Edi Rama ha finalmente messo mano alla memoria collettiva, aprendo alla cittadinanza il rifugio militare che Hoxha fece costruire tra il 1970 e il 1972 alle pendici del monte Dajti. Ogni ambiente del sotterraneo, furbescamente ribattezzato Bunk’Art, è oggi adibito a museo. In una delle stanze più visitate, nominata «camera di Hoxha», foto a mezzo busto del dittatore circondano una televisione d’epoca: in onda, a loop, le immagini del suo funerale. Sono indimenticabili le facce dei bambini albanesi che si assiepano davanti a quella Tv. I genitori, timorosi di un passato che hanno vissuto, in genere fanno per tirarli via; ma i piccoli insistono, ipnotizzati da una storia che in fin dei conti è anche loro. Sono quei bambini, e non vecchi eroi a cavallo, il futuro, l’unico possibile, dell’Albania. Futuri cittadini cui i governanti attuali dovranno saper fornire una memoria e una direzione: un motivo per rimanere. Quando la giovane Albania democratica si dimostrerà capace di accettare, ricostruire e raccontare in autonomia la propria complessa storia, nel cuore dei suoi giovani figli nasceranno senza dubbio nuove motivazioni, il desiderio di scriverne il seguito.
Nicola Pedrazzi*
* Nicola Pedrazzi (Bologna, 1986) è giornalista pubblicista e redattore dell’agenzia stampa NEV-Notizie Evangeliche. A nome dell’Università di Pavia ha speso in Albania tre anni di ricerca dottorale. È stato corrispondente da Tirana per l’Osservatorio Balcani e Caucaso (Obc) e per Kosovo 2.0.