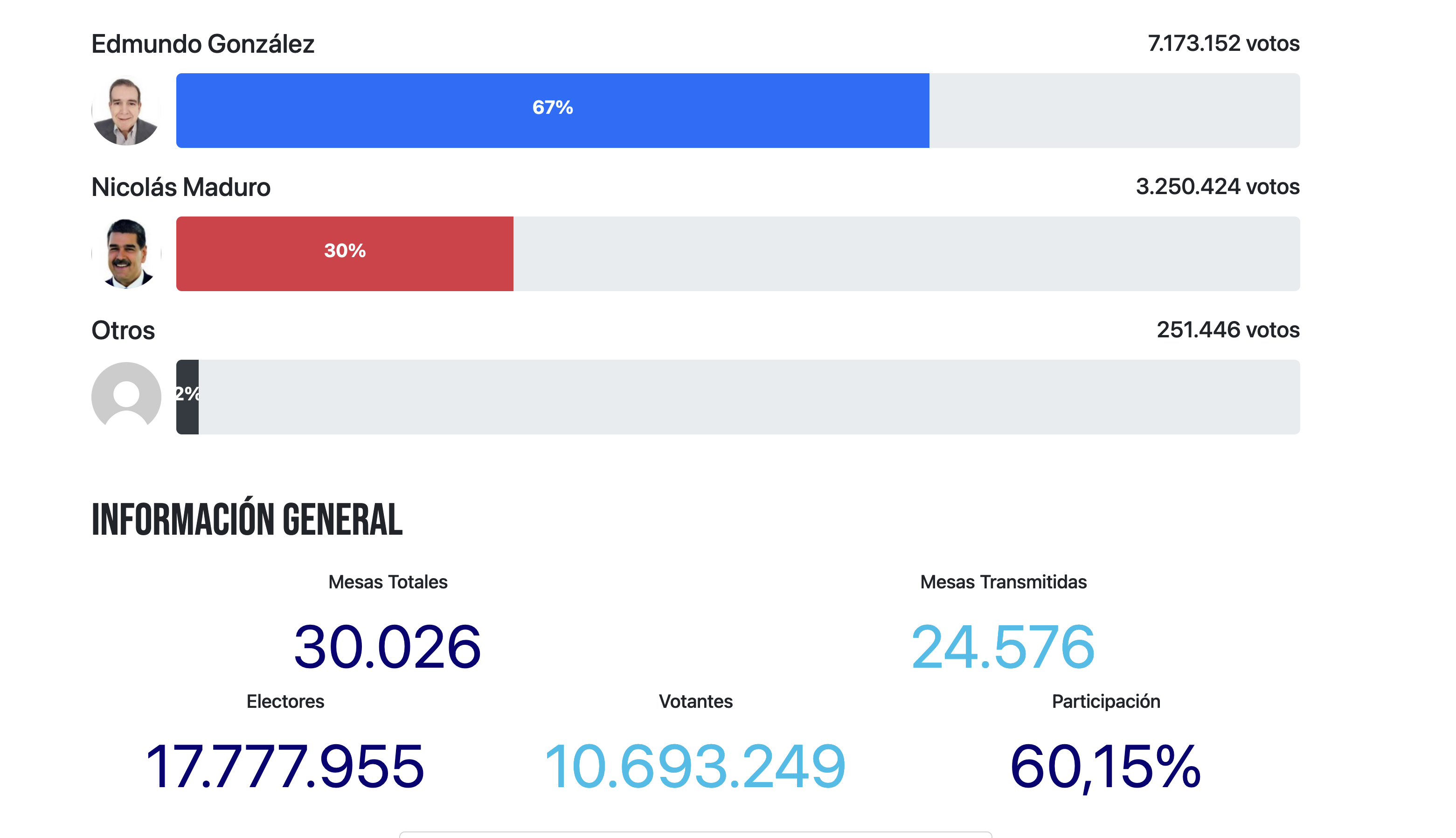Turchia. Restare al potere con qualsiasi mezzo
Sabato 29 marzo: sono migliaia le persone fuori dai cancelli dell’ufficio comunale di Istanbul. Le autorità parlano di cinquecentomila persone, i manifestanti affermano di essere oltre due milioni. Tutti sono qui per protestare contro la detenzione di Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul, arrestato lo scorso 19 marzo.
Negli ultimi anni, Ekrem İmamoğlu è stato uno degli avversari più accreditati per contendere la presidenza della Turchia a Recep Erdoğan, al potere dal 2014. Figura di spicco nella politica di opposizione e uomo estremamente carismatico, İmamoğlu ha visto crescere di molto la sua popolarità negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. Molti ragazzi e ragazze, da quando sono al mondo, hanno praticamente conosciuto solo il governo di Erdoğan. İmamoğlu sembrava poter essere la speranza di un cambiamento. Le accuse mosse al sindaco di Istanbul sono varie: corruzione, illeciti in gare d’appalto, relazioni con il Pkk, il partito dei lavoratori curdo, considerato da Erdoğan un gruppo terroristico. Il 19 marzo, insieme a İmamoğlu, sono state arrestate con le stesse accuse altre 106 persone, tra cui due sindaci distrettuali.
Chi è Ekrem İmamoğlu? Nato nel 1970, si è laureato a Istanbul in economia aziendale. Dopo un master, comincia a lavorare nell’azienda di famiglia che si occupa di edilizia. Negli anni Novanta, intraprende la sua carriera politica.
Si iscrive prima all’Anap (Partito della madrepatria) e, in seguito, al suo partito attuale: il Chp (Partito popolare repubblicano), gruppo di orientamento laico e socialdemocratico.
Nel 2014, viene eletto sindaco del distretto di Beylikdüzü, periferia europea di Istanbul. Nel 2019, dopo 25 anni di dominio del partito di Erdoğan, diventa sindaco della metropoli turca. Proprio questa vittoria, lo proietta come antagonista ideale di Erdoğan. Ma, subito dopo le elezioni del 2019, il presidente prova già a intralciare il cammino del suo avversario: annulla la vittoria a sindaco per illecito e lo sospende per due mesi. İmamoğlu, però, vince di nuovo nella ripetizione delle elezioni, e con ancora più voti di quelle precedenti. In seguito, stravince anche le elezioni del marzo 2024.

L’arresto dello scorso 19 marzo è arrivato in maniera molto «puntuale». Pochi giorni dopo, infatti, il suo partito lo avrebbe candidato per le prossime presidenziali. Inoltre, il giorno prima dell’arresto, l’Università di Istanbul aveva annunciato la revoca della sua laurea (rilasciata 35 anni fa), perché il passaggio dall’università iniziata a Cipro a quella di Istanbul, non avrebbe rispettato le regole amministrative. Senza una laurea, in Turchia, non si può concorrere alle presidenziali.
Come molti immaginano, si sta ricorrendo a qualsiasi mezzo pur di non far candidare İmamoğlu contro Erdoğan. Peraltro, quello di queste settimane, non è il primo tentativo del presidente turco di sabotare il suo avversario. Nel dicembre 2022, infatti, il sindaco di Istanbul è stato condannato a due anni e sette mesi di carcere per aver insultato alcuni funzionari pubblici. Il processo d’appello per questa accusa è ancora in corso.
Özgür Özel, leader del partito del Chp, ha annunciato che, nonostante la detenzione, manterrà la candidatura di İmamoğlu alle presidenziali, organizzerà una campagna nazionale per raccogliere firme a sostegno della sua liberazione, e per chiedere le elezioni anticipate. Nel frattempo, il consiglio comunale di Istanbul ha eletto Nuri Aslan come sindaco ad interim, mentre sono state applicate restrizioni e divieti alle manifestazioni fino al primo aprile.
Tutto questo, però, non ha assolutamente bloccato le contestazioni che continuano a infiammare le strade della Turchia. Molte proteste, inizialmente pacifiche, sono sfociate in scontri violenti contro la polizia. Le forze dell’ordine hanno reagito usando cannoni ad acqua, razzi lacrimogeni e armi antisommossa. A Smirne, è stata bloccata una manifestazione che avrebbe coinvolto più di mezzo milione di studenti.
Dal 19 marzo ad oggi, sono più di duemila le persone arrestate per aver protestato. Tra di loro, ci sono anche quaranta giornalisti.
Negli ultimi mesi, in seguito ai possibili accordi con il Pkk, sembrava potesse esserci uno spiraglio di pace. La detenzione di İmamoğlu e la repressione violenta delle proteste, però, riportano il timore che la Turchia possa sprofondare ancora di più in un regime totalitario, con Erdoğan che – da più di trent’anni (come sindaco di Istanbul, primo ministro e, infine, presidente) – spadroneggia usando qualsiasi mezzo per restare al potere.
Angelo Calianno