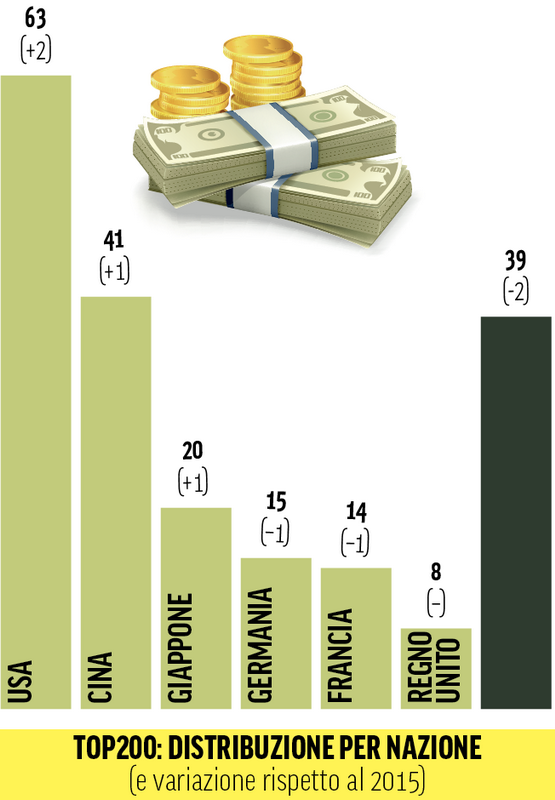Cari Missionari
Preghiera per l’Ottobre Missionario 2018
Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti
O Dio Padre che sei nei cieli,
con gioia e stupore ti ringraziamo perché per un’iniziativa del tuo amore preveniente ci troviamo in questo mondo. Per mezzo del Cristo, tuo dilettissimo Figlio, ci hai creati a tua immagine e ci hai rigenerati a vita nuova, rendendoci tuoi figli adottivi in virtù del dono del tuo Santo Spirito, che ci fa vivere l’entusiasmante avventura di chiamarti Papà nella Chiesa, tua famiglia. Nella fede riconosciamo che la nostra vita è una missione: attratti da te ed inviati nel mondo, ci percepiamo interiormente animati dal tuo Spirito d’amore che custodisce in noi la speranza. Ti supplichiamo umilmente: fa’ che nessuno rifiuti il tuo amore, in modo tale che cessi la povertà materiale e morale e ogni discriminazione di fratelli e sorelle.
O Cristo Gesù crocifisso e risorto,
aprendoci alla missione che tu ci affidi dicendoci: «Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi», la nostra fede rimane sempre giovane. Tu dai senso alla nostra vita, tu sei la verità che ci rende liberi, il tesoro che riempie di gioia la vita, il fondamento dei nostri sogni e la forza per realizzarli. Stando con te prendiamo coscienza che il male è provocazione ad amare sempre di più. Dalla tua croce gloriosa impariamo la tua logica amorosa, l’offerta di noi stessi come annuncio del tuo Vangelo per la vita del mondo. Tu per la fede abiti nei nostri cuori e vuoi parlare e agire in noi.
Spirito Santo, anima della Chiesa,
dal battesimo dimori in noi come in un tempio.
Illumina e infiamma la mente e il cuore di ciascuno di noi, rendendoci missionari del Vangelo nel mondo
intero. Ti ringraziamo per il dono di coloro
che ci hanno trasmesso la fede con la vita e la parola, testimoniando la perenne vitalità del Vangelo.
O Maria, Regina degli Apostoli e madre e modello della Chiesa,
prega per noi perché in fretta raggiungiamo gli ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù vivente nella Chiesa. Aiutaci a donarci nella vocazione che ci è stata regalata dal Creatore, seguendo il tuo Figlio Gesù. Insegnaci a metterci il grembiule per servire i più piccoli, promuovendo la dignità umana e testimoniando la gioia di amare e di essere cristiani. Ricordaci che molta gente ha bisogno di noi, che Cristo conta su di noi, chiamandoci incessantemente ad essere suoi discepoli missionari, sempre più appassionati per il suo Regno.
San Francesco Saverio, Santa Teresa del Gesù
Bambino, Beato Paolo Manna, intercedete per noi e accompagnateci sempre.
Amen. Alleluia!
don Francesco Dell’Orco
di Bisceglie (BT), 02/08/2018
Ha ragione Salvini?
Cari Missionari,
ve la prendete se dico che, almeno in una cosa, Salvini ha ragione? Non è meglio se i coniugati che hanno figli vengano chiamati padre e madre, anziché genitore uno e genitore due?
Mario Zumpanesi
12/08/2018
Caro Mario,
dal mio povero punto di vista non credo ci sia bisogno di scomodare Salvini per dire che un bambino/a ha un padre (maschio) e una madre (femmina) e non genitore 1 e/o 2. Lo dice la natura stessa, la nostra specie. Tanto più che essa è una realtà con paladini più credibili di un ministro che governa (o fa campagna elettorale perenne) twittando.
Primo, c’è una tradizione dell’umanità che va avanti da qualche migliaio di anni ed è condivisa dalle culture più disparate. E questo è «civiltà», come avrebbe scritto Giovannino Guareschi che definiva «progresso» la «tornilette vicino alla stanza dove mangi e dormi», e «civiltà» il «cesso fuori da dove vivi» (come era un tempo nella sua Bassa).
Poi c’è una solida tradizione biblica e cristiana. È vero, il Vangelo non ha norme su come devono essere scritti e formulati i documenti dello stato, e quindi è legittimo che questo usi le diciture che preferisce. Ma se si vuole essere davvero inclusivi e rispettare tutti i credi e le opinioni, perché imporre a tutti quel «genitore 1 e 2» che, se rispetta una minoranza, insulta invece una grande maggioranza?
Da ultimo. Uno stato può e deve legiferare su aborto, divorzio, unioni omosessuali, gender, utero in affitto e via dicendo, ma per un credente l’aborto rimane un omicidio, il matrimonio è per la vita, l’unione tra due persone dello stesso sesso non è matrimonio, l’utero in affitto non è accettabile (vedi a pag. 62) così come la sperimentazione genetica sui feti, un bambino/a nasce dall’incontro tra uno spermatozoo di un maschio e l’ovulo di una femmina, eccetera. Benvenga la modifica dei documenti twittata da Salvini, purché mantenga uno spazio di rispetto per chi la pensa in modo diverso e non sia un’imposizione ideologica.
Dissentire da Gesualdi
Gent.mo padre Gigi,
seguo da anni la rivista e apprezzo molti articoli, devo però dissentire su molte cose scritte negli articoli di Francesco Gesualdi.
Ad esempio, nell’articolo di giugno appare che tanti problemi siano dovuti alla mancanza di sovranità monetaria degli stati. Quando si afferma che «la moneta unica ha prodotto risultati disastrosi», forse sarà pur vero in qualche caso (ha tolto terreno agli speculatori), ma è innegabile che i risultati positivi sono stati di gran lunga maggiori. Ma se la Grecia o l’Italia non avessero avuto una stabilità monetaria cosa sarebbe successo?
Come sarebbero stati gli interessi che si sarebbero dovuti pagare, senza l’euro, a chi ha prestato capitali (usati per politiche demagogiche come mandare in pensione statali con soli 15 anni di lavoro o dare invalidità a tanti che non ne avevano diritto)? Ma si è certi che bastava stampare altra lira per azzerare il debito? Il default dell’Italia sarebbe stato meglio?
Il vero problema è la mancanza di una politica comune (fiscale, economica, estera) e l’esistenza di tanti egoismi locali e nazionali. Ripeto: il problema non è la mancanza di sovranità monetaria.
Quando si fa riferimento a Keynes, come esempio da seguire si dimentica che sono passati 90 anni, che il mondo è cambiato, le distanze si sono enormemente accorciate; alcuni stati (europei e non solo) hanno bilanci inferiori a quelli di alcune multinazionali. Non si può tornare indietro … «Piccolo è bello», slogan in voga negli anni ‘80-’90 ha dimostrato che è un’illusione chiudersi nel proprio piccolo, nazione o gruppo.
Comunque, continuerò a leggere Missioni Consolata e quando leggerò gli articoli di Gesualdi scuoterò sconsolato la testa.
Antonio Borello
20/07/2018
Caro signor Antonio,
quanto Francesco Gesualdi scrive con competenza e passione, non è Vangelo. È un contributo alla comprensione di una realtà – come quella economica – estremamente complessa e sempre più fuori dal controllo non solo di noi gente comune, ma a volte anche dei governi.
È vero che ci fa più piacere leggere cose che confermano quello che già pensiamo, ma confrontarci con chi la pensa diversamente da noi ci arricchisce e ci può invogliare ad approfondire di più e conoscere meglio.
La logica di questa rivista non è quella dei social: riscuotere il più alto numero di «mi piace». Non cerchiamo il consenso, ma crediamo nel cuore e nell’intelligenza dei nostri lettori di cui rispettiamo fino in fondo la libertà di pensiero e di opinione.
Spezzare la catena
La rete che fa partire i migranti africani, cioè quelli che si fermano in Libia, ce l’hanno descritta più volte: ci sono quelli che girano nei paesi per convincere le persone a partire e poi le vendono a una lunga catena di intermediari in tutti i paesi attraversati. Vengono bloccate e torturate fin quando non arrivano altri soldi, e poi l’ultima sanguinosa estorsione avviene in Libia, che magari prende soldi italiani per rubarci su costruendo lager, e altri ancora li estorce dai poveretti per lasciarli imbarcare.
Non potrebbero giornalisti coraggiosi, magari assumendo informazioni dai missionari, descrivere bene questa catena (in cui, a occhio, c’entrano molti stati ex francesi e ora comunque collegati con la Francia che tanto strilla per non riceverli) e l’Italia occuparsi di diffondere queste informazioni su tutte le reti possibili, in modo che arrivino nei paesi d’origine dei migranti?
Claudio Bellavita
04/07/2018
Il problema è grande. Ci sono Ong, associazioni e chiese che si impegnano in questo campo. Pensi solo alla rete «Talitha Kum» creata da tante suore nel mondo che stanno lottando contro la tratta di persone. Oppure alle attività di cui abbiamo scritto a proposito del Niger (MC 3 e 4/2018) o del soccorso in mare (dossier MC 1-2/2018). Quanto alle responsabilità, quella francese è fuori discussione, visto la politica colonialista passata e recente. Ma neanche noi italiani possiamo ritenerci del tutto innocenti: Libia, Eritrea, Somalia ed Etiopia sono nostre ex colonie e il nostro colonialismo non è stato «più buono» di quello inglese, francese o tedesco.
Crollo di una diga in Laos
Spero che la tragedia del 24 luglio, quando il crollo di una colossale diga ha provocato la morte di oltre cento persone e la scomparsa di decine di villaggi nel Sud del Laos, convinca i governanti che il Mekong, più che un gigante pericoloso da imbrigliare con costosissime operazioni di ingegneria idraulica, è un fiume che dovrebbe essere amato, capito e valorizzato per quello che è, ovvero un patrimonio di eccezionale valore biologico, naturalistico e paesaggistico.
Spero che i professionisti dell’informazione facciano del loro meglio per ricordare a tutti che la tutela del Laos e della sua natura è di cruciale importanza per la conservazione degli equilibri ecologici e climatici nella regione del Sudest Asiatico e non solo.
Ave Baldassarretti
12/08/2018
I disastri non risparmiano alcun angolo del mondo. Ma non dovremmo aver bisogno di terremoti, inondazioni, incendi, tsunami ed eruzioni per «custodire il creato». Papa Francesco, nell’enciclica «Laudato si’», ci ha ricordato con forza e chiarezza la nostra responsabilità. Ma come è difficile per tutti cambiare e smettere di comportarci da «padroni» e diventare invece «custodi» e «giardinieri» del mondo.
Cammino verso Czestochowa
«Se vogliamo conoscere il cuore dei polacchi, occorre venire qui a Czestochowa al santuario della Madonna Nera. Bisogna ascoltare in questo luogo l’eco della vita dell’intero popolo vicino al cuore della sua Madre e Regina».

Queste parole pronunciate da Giovanni Paolo II esprimono bene quel rapporto tra il santuario di Czestochowa e la vita di milioni di fedeli. La prospettiva migliore per capire tutto questo è di partecipare a uno dei numerosi pellegrinaggi che a piedi da ogni parte del paese d’estate si dirigono qui. Si contano ogni anno circa 250mila pellegrini provenienti da tutte le 41 diocesi polacche.
La tradizione dei pellegrinaggi al santuario della Madonna Nera è antica. I primi gruppi documentati risalgono al
XVII sec. Nel settembre del 1626 un gruppo di 80 fedeli partì da Gliwice diretto a Czestochowa per onorare un voto di ringraziamento alla Madonna per aver salvato la città dall’assedio dell’esercito danese. Il voto impegnava i cittadini a recarsi lì ogni anno per ringraziare e far memoria dell’evento.
Pochi anni dopo nel 1637 anche i fedeli della città di Kalisz iniziarono a recarsi a piedi al santuario e, cosa singolare, a fare a piedi anche il ritorno. Nel 1771, il 6 agosto, anche i varsaviani come voto di ringraziamento alla Madonna per aver salvato la città dalla peste inziarono a pellegrinare verso il santuario. Questi primi gruppi iniziarono una tradizione ininterrotta che si è sviluppata grandemente e ancora oggi dopo diversi secoli resiste nel tempo.
Dalla sola città di Varsavia partono ogni estate almeno cinque pellegrinaggi a piedi, tra questi quello organizzato dalla Pastorale universitaria dell’Arcidiocesi che ha sede nell’antica chiesa di sant’Anna, nel centro della città. Vi partecipano mediamente 4mila giovani e famiglie divisi in 19 gruppi. Uno di questi gruppi, quello argento, lo guidiamo noi missionari della Consolata. Infatti, fin dal nostro arrivo in Polonia nel 2008 ogni anno partecipiamo al pellegrinaggio con questo gruppo.
Il percorso è di circa 300 km diviso in 10 giorni dal 5 al 14 agosto. La giornata inizia con la sveglia all’alba. Dopo essersi preparati, aver ripiegato la tenda o aver sistemato il sacco a pelo usato nel fienile di qualche contadino, i pellegrini sono pronti ad affrontare la lunga giornata. Ogni due ore circa si fa una sosta nei pressi di una parrocchia che organizza l’accoglienza. Il parroco benedice con l’acqua santa i gruppi che arrivano, mentre i parrocchiani ristorano gli affaticati pellegrini con panini e bevande. In cambio ricevono riconoscenza e tante preghiere. Il programma spirituale è intenso. Ogni giorno, in una cornice di canti gioiosi, vengono fatte conferenze dai sacerdoti, preghiere tradizionali, il rosario, la Corona alla divina misericordia e, come momento culminante, la S. Messa. Alla sera ci si saluta con un momento di ringraziamento in gruppo e un canto mariano. Ogni giorno si fa esperienza dell’ospitalità presso famiglie semplici di villaggi che condividono quello che hanno. Forniscono un po’ di acqua per lavarsi dopo la calda giornata, rendono accessibile il fienile per sistemare i sacchi a pelo e trascorrere la notte oppure i propri giardini su cui montare le tende e passare qualche ora di riposo notturno indispensabile per riprendere un po’ di forza e ripartire il giorno dopo.
Il clima che si crea tra i pellegrini è di grande fraternità e di gioia. Una gioia che umanamente è difficile scorgere in una esperienza obiettivamente faticosa. Eppure, ogni partecipante vive una forza interiore che lo sorregge e incoraggia. Questa forza, lo crediamo, ci è data da Colei verso cui e per cui camminiamo offrendole le fatiche e tantissime intenzioni di preghiera.
Il nostro gruppo in mezzo agli altri si distingue per la caratteristica missionaria. La nostra presenza internazionale vuole essere un segno della universalità della nostra fede vissuta nella fraternità. Spesso invitiamo confratelli e amici da altri paesi che arricchiscono le giornate con i loro racconti e testimonianze.
In una cultura occidentale che propone all’uomo moderno una tecnologizzazione globale, spesso anonima, che esclude le distanze e gli incontri reali così come ogni forma di sacro, il pellegrinare a piedi ha ancora un suo significato prezioso: ridare all’uomo il giusto orientamento per il quale è nato, quello del camminare con altri condividendo una forte esperienza di fede. Per questo andare a piedi percorrendo centinaia di chilometri ha un suo senso e le persone che vi partecipano lo testimoniano con convinzione.
padre Luca Bovio
Czestochowa, 17/08/2018
Grazie, Asante sana
Ringrazio Dio per avermi aiutata a concludere gli studi e a diventare una maestra. Lo ringrazio perché l’aiuto di tante persone che neppure conosco mi ha permesso di arrivare a questo punto e superare tutte le difficoltà. Grazie per esserci stati per me quando avevo più bisogno di voi.
Catherine Smaila
Maralal, Kenya
![]() Con queste parole Smaila [o Smiler) ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla sua educazione dalla scuola elementare fino al completamento dei suoi studi al Teacher’s College.
Con queste parole Smaila [o Smiler) ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla sua educazione dalla scuola elementare fino al completamento dei suoi studi al Teacher’s College.
Ma oggi Smaila è tornata a sorridere grazie all’aiuto di tanti amici che mi hanno permesso di aiutarla nei lunghi anni di scuola. Con lei e con tanti altri bambini e bambine che hanno concluso il loro ciclo di studi o stanno ancora studiando, vi ringarzio anch’io di cuore. Il «sostegno a distanza» è un’avventura lunga e impegnativa, ma la gioia che dà è grande. Che il Signore ricompensi ciascuno di voi per la pazienza e l’affetto con cui aiutate noi missionari a restituire il sorriso e la speranza a tante persone in situazione di grande povertà e sofferenza.