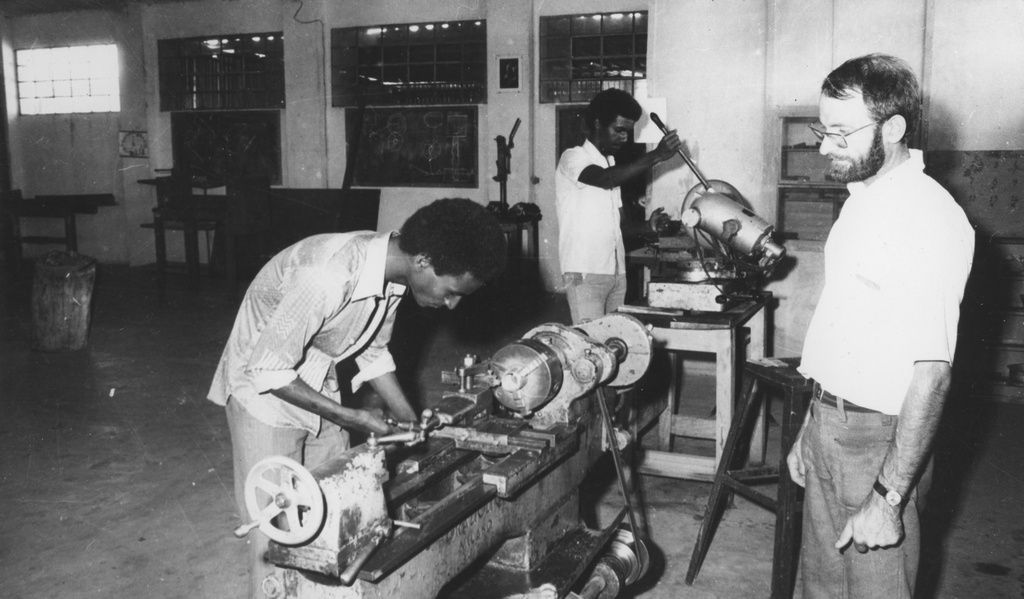Trattori selvaggi
Quella che oggi prevale è l’agricoltura industriale: a monte le multinazionali dei fertilizzanti, a valle quelle commerciali. Con una dinamica dei prezzi che premia quelle stesse aziende mentre penalizza produttori e consumatori finali. Dopo le proteste e i successivi compromessi al ribasso, a perdere sono l’ambiente e i cittadini.
I trattori che, fra gennaio e febbraio 2024, si sono visti sfilare per le vie di varie città europee, non erano macchine vecchie e di piccola taglia, ma imponenti e di alto valore economico. Segno che, a scendere in piazza, non erano tanto i piccoli coltivatori, magari dediti all’agricoltura biologica, ma i produttori di medie e grandi dimensioni pienamente inseriti nella filiera agricola industriale. Quei produttori, cioè, che si pongono l’obiettivo di ottenere rese quanto più alte possibili tramite l’impiego di macchinari sofisticati e l’uso indiscriminato di ogni tipo di sostanza chimica. Rappresentanti di un’agricoltura che, oltre ad avere pessime ricadute sull’ambiente, è anche estremamente rischiosa per i produttori stessi, perché impone l’esborso di grandi quantità di denaro senza nessuna certezza rispetto ai ricavi. I raccolti, infatti, sono sempre un grande punto interrogativo, specie di questi tempi: con il sopraggiungere dei cambiamenti climatici, di raccolti che vanno male ce ne sono sempre di più. Ma il clima che cambia è solo una delle minacce che condizionano i ricavi degli operatori del settore. L’agricoltura industriale è dominata da pochi sciacalli posizionati sia a monte che a valle della filiera. A monte ci sono le multinazionali dei fertilizzanti, dei pesticidi e dei carburanti, pochi soggetti che usano la loro posizione di monopolio per imporre prezzi di vendita più alti possibili sui propri prodotti. A valle ci sono le multinazionali commerciali, pochi soggetti che usano la loro posizione di monopsonio, ossia di acquirente unico, per imporre prezzi di acquisto più bassi possibili. Così i produttori dell’agricoltura industriale lamentano di sentirsi in una morsa che li impoverisce sempre di più.
Costi, ricavi, prezzi finali
Negli ultimi anni vari elementi hanno influito negativamente sia sul fronte dei costi che dei ricavi, mettendo in difficoltà i produttori dell’agricoltura industriale che hanno cercato di rimediare producendo ancora di più, ossia costringendo la terra a dare rese sempre più alte. Sul piano dei costi, sappiamo tutti che, nel corso del 2022, la guerra fra Russia e Ucraina ha fatto impennare i prezzi del gas e più in generale dei carburanti. Una crescita che, se per le famiglie si è tradotta principalmente in aumento delle bollette elettriche e del gas, per i produttori agricoli ha significato aumento oltre che dei carburanti anche dei fertilizzanti azotati considerato che la materia prima da cui si ottengono questi ultimi è il metano. L’Istat certifica che nel corso del 2022, in Italia, i prezzi dei beni e servizi utilizzati in agricoltura sono cresciuti del 25,3 per cento con rincari guidati soprattutto dai prodotti energetici (+49,7%) e fertilizzanti (+63,4%). Gli aumenti hanno investito tutti i settori, seppur con diversa intensità, a seconda della combinazione dei fattori produttivi. I più colpiti sono stati i produttori di semi oleosi e cereali senza risparmiare la zootecnia. Gli esborsi degli allevatori sono aumentati di media del 16,6% e più precisamente del 9,8% per l’acquisto degli animali da allevamento, del 25% per i mangimi, del 61,5% per i prodotti energetici. Incrementi di costo che non sono stati compensati da uguali aumenti di prezzo alla vendita. L’Istat informa che, sempre nel 2022, in Italia il prezzo dei beni agricoli è aumentato mediamente del 17,7% con una differenza negativa, rispetto ai costi, di circa il 7%.
Coldiretti, la principale associazione degli agricoltori italiani, è più pessimista. Basandosi sui dati Fao a livello globale, forniti nel gennaio 2024, l’associazione sostiene che a volare sono stati i prezzi del cibo al consumatore finale, mentre ai contadini i prodotti agricoli sono stati pagati il 10,4% in meno rispetto all’anno precedente. Più precisamente meno 18% per il latte alla stalla e meno 19% per i cereali nei campi. E pensare che, nel 2022, tutto il mondo era in apprensione per l’aumento del prezzo internazionale dei cereali cresciuto di oltre il 20% come conseguenza della mancata commercializzazione di quelli provenienti dall’Ucraina. Ma i guadagni sono stati intascati tutti dalle grandi multinazionali commerciali. In particolare, Archer Daniels, Bunge, Cargills, in sigla Abc, che dominano il mercato internazionale delle derrate agricole.

Pane e finocchi
Del resto, che esista un’ampia sfasatura fra prezzi pagati al produttore e quelli pagati al consumo finale, è cosa risaputa. Coldiretti cita il caso della filiera del pane, facendo notare che in Italia il prezzo finale di questo prodotto cresce anche di venti volte rispetto al grano. Un chilo di grano che viene pagato oggi agli agricoltori attorno a 24 centesimi di euro serve per fare un chilo di pane che viene venduto ai consumatori a prezzi che variano dai 3 ai 5 euro a seconda delle città.
Le anomalie – continua la Coldiretti – sono evidenti anche nei prodotti freschi come gli ortofrutticoli che dai campi agli scaffali dei supermercati vedono salire i prezzi di tre-cinque volte. Il tutto benché non debbano subire trasformazioni. Come esempio vengono citati i finocchi.
Secondo i calcoli di Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) del gennaio 2024, per produrre un chilo di finocchi il contadino deve spendere 18 centesimi di euro, ma riesce a venderli a 12 centesimi, mentre al supermercato sono venduti ai consumatori finali a 1,69 euro, il 1.308% in più. E pensare che i finocchi non necessitano neanche di imballaggio: sono venduti sfusi. Ulteriore conferma di come la filiera agricola sia dominata da posizioni di abuso al cui apice si trovano i signori della grande distribuzione che contribuiscono a ridurre i guadagni degli agricoltori. Signori evidentemente considerati troppo forti per essere presi di petto dalle istituzioni, per cui vengono lasciati in pace. E, infatti, è successo che gli agricoltori hanno diretto la propria protesta verso il soggetto pubblico ritenuto più malleabile. Con richieste sia nei confronti dei rispettivi governi che dell’Unione europea. Ai primi per ottenere abbattimenti fiscali e contributi ai carburanti; alla seconda per ottenere modifiche a certe sue scelte riguardanti sia il commercio internazionale che le condizioni imposte per avere accesso ai suoi contributi.

Accordi e concorrenza
Un fenomeno fortemente sostenuto dall’Unione europea (Ue), che alcuni agricoltori del continente considerano lesivo dei loro interessi, è rappresentato dagli accordi di libero scambio. Questi consistono in contratti fra due paesi per facilitare i reciproci scambi commerciali. Di norma le facilitazioni consistono nell’abbattimento reciproco delle barriere doganali e nell’accettare le caratteristiche produttive dei prodotti importati anche se non in linea con la legislazione del paese importatore.
Parlando di prodotti alimentari, un’eccezione ammessa di frequente dalla Ue è quella di importare prodotti ottenuti con metodiche proibite nell’Unione europea: ad esempio con l’impiego di particolari farmaci o sostanze chimiche. Pratica contestatissima dai nostri produttori che si sentono penalizzati rispetto a quelli esteri.
A gennaio 2024 l’Unione europea risultava avere ben dodici accordi di libero scambio in ambito agricolo. E non tanto con paesi che si affacciano sul Mediterraneo, quanto con paesi dell’Estremo Oriente e d’oltre oceano, come Canada, Messico, Cile, Giappone, Vietnam, addirittura la Nuova Zelanda. L’Unione europea sostiene di averli stipulati perché procurano un vantaggio ai consumatori europei e agli stessi agricoltori. Ai consumatori perché possono garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, magari a prezzi più bassi di quelli interni; agli agricoltori perché ampliano i loro sbocchi di mercato con le esportazioni.
E può darsi anche che sia così. Ma solo per i grandi produttori che possono permetterselo, metre quelli piccoli, più orientati al mercato interno, si lamentano perché subiscono la concorrenza sleale di prodotti provenienti dai paesi agevolati dagli accordi di libero scambio. Un esempio è rappresentato dall’accordo recentemente stipulato con la Nuova Zelanda: gli allevatori europei dediti al latte e agli ovini temono di essere danneggiati dai prodotti lattieri e animali provenienti da questo paese che, in virtù degli abbattimenti tariffari, potrebbero entrare a prezzi più bassi di quelli esistenti internamente. Lo stesso vale per alcuni prodotti provenienti dall’Ucraina. In particolare, gli agricoltori di Polonia e Francia, grandi produttori di cereali, hanno chiesto che venisse rivisto l’accordo di libero scambio stipulato con l’Ucraina già nel 2016, perché la guerra ha alterato tutti i flussi commerciali creando una situazione di concorrenza sleale in seno all’Unione europea. Richiesta accolta dalla Commissione europea che, nel marzo 2024, ha introdotto restrizioni alle importazioni agricole provenienti da questo paese.
Le regole della Ue
I produttori si lamentano anche delle regole ambientali imposte dall’Unione europea per poter godere dei contributi agricoli. Il sistema di sostegno all’agricoltura oggi previsto in ambito europeo prevede sia forme di agevolazione finanziaria per specifici investimenti, sia contributi a fondo perduto in rapporto alla quantità di terra posseduta.
In ogni caso i meccanismi di godibilità sono tutti organizzati affinché i beneficiari principali siano le grandi aziende. Ciò nonostante, sono soprattutto i piccoli produttori a lamentarsi delle condizioni da rispettate per potere accedere ai contributi e alle agevolazioni. In particolare, sono messe sotto accusa alcune regole che l’Unione europea ha imposto a tutela della biodiversità e della salvaguardia dei suoli.
Le più odiate sono quelle che limitano l’uso di pesticidi e che prevedono l’obbligo di tenere a riposo il 4% dei propri terreni.
I piccoli produttori sostengono che si tratta di condizioni capestro che riducono la loro capacità produttiva e quindi i loro già magri guadagni. Richieste di nuovo accolte dalla Commissione europea che, nel febbraio 2024, ha reso più blanda la regola di messa a riposo delle terre e ha ritirato la proposta di regolamento tesa a ridurre del 50% l’uso di pesticidi entro il 2030.

Ambiente e cittadini
Gli agricoltori industriali tireranno un respiro di sollievo: nell’immediato i loro guadagni sono salvaguardati. Ma per la collettività nel suo insieme si tratta di una disfatta perché continuerà ad aggravarsi il degrado ambientale di cui l’agricoltura industriale è una forte responsabile.
Quello che servirebbe è una profonda revisione del modello economico che seguiamo, un radicale ripensamento del modo di produrre e consumare per fare finalmente pace con la natura. Non per amore disinteressato verso il pianeta, ma per amore di noi stessi, per garantirci un futuro meno problematico.
La grande sfida è avviare questo processo di cambiamento senza lasciare indietro nessuno. Ma, per riuscirci, bisogna cominciare a prendere consapevolezza che cambiare è necessario e che occorre farlo con spirito di solidarietà. Ossia sapendo soccorrere coloro che maggiormente sono investiti dai mutamenti, ma al tempo stesso sono troppo deboli per affrontarli da soli.
Fra essi ci sono sicuramente anche gli agricoltori, specie quelli di piccola taglia, che vanno aiutati a passare a pratiche di tipo biologico senza subire contraccolpi eccessivi.
Francesco Gesualdi