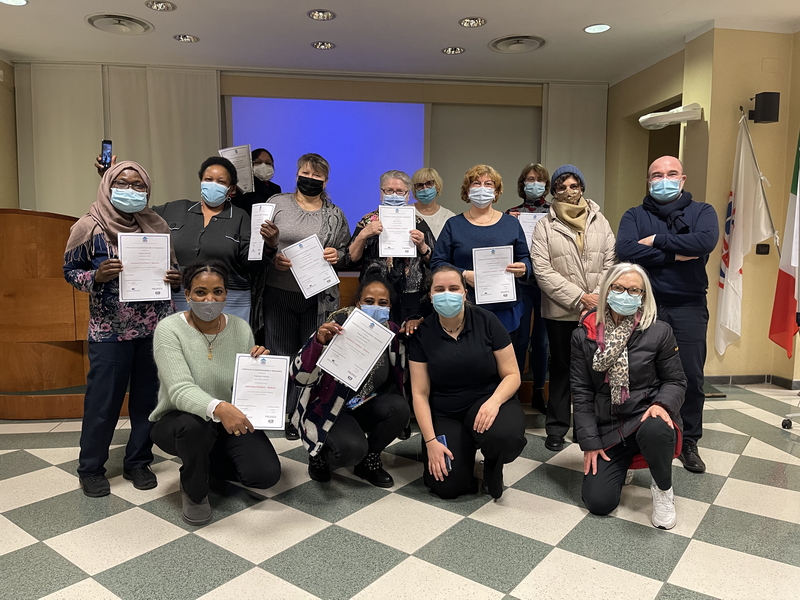A tutto G.A.S.
Oggi, cinque milioni di italiani si nutrono (anche) tramite un gruppo di acquisto solidale. Dalla nascita del primo Gas, trent’anni fa, le reti di economia solidale sono cresciute opponendo il modello della collaborazione a quello della competizione.
I gruppi di acquisto solidali, o Gas, sono formati da persone e famiglie che si aggregano per comprare insieme alcuni prodotti di uso quotidiano, seguendo i principi della solidarietà e della sostenibilità. Questo li porta a scegliere produttori piccoli e locali, rispettosi dell’ambiente e delle persone, con cui entrare in relazione diretta.
Il concetto che sta alla base dei Gas è quello di «filiera corta», cioè dell’avvicinamento fra produttore e consumatore, sia in termini geografici, privilegiando le aziende più vicine, sia in termini «funzionali», saltando gli intermediari.
Economia solidale
La nascita dei Gas segue quella dei loro fratelli maggiori nella famiglia dell’economia solidale. In Italia, infatti, le esperienze di costruzione di un’altra economia iniziano negli anni 80 con il commercio equo e solidale, la finanza etica e il turismo responsabile.
Gli anni 90 vedono invece fiorire esperienze legate al consumo: il consumo critico, i bilanci di giustizia e, appunto, i Gas.
Il primo Gruppo di acquisto solidale si costituisce ufficialmente a Fidenza (Pr) trent’anni fa, nel 1994. I suoi fondatori, insieme alla critica al modello di sviluppo dominante, ingiusto e insostenibile, mettono le esigenze concrete del quotidiano, ovvero la necessità di mangiare cibi sani e gustosi, portatori di significati e di relazioni.

La rete si allarga
Questa pratica inizia a diffondersi in tutta Italia con il passaparola, e altri gruppi si formano sull’esempio del primo.
Nel 1997 nasce la rete di collegamento tra i Gas per scambiare informazioni e organizzare eventi e progetti.
I vantaggi ambientali, sociali e personali della diffusione dei Gas sono numerosi e su diversi livelli: dal punto di vista ambientale, la preferenza di prodotti locali riduce il consumo di energia e l’inquinamento dovuti al trasporto; la scelta di prodotti biologici aiuta a conservare il terreno; inoltre, il tipo di confezioni e di distribuzione diminuiscono di molto gli imballaggi e gli scarti.
Dal punto di vista sociale, questo modo di acquistare pone attenzione alle modalità di produzione, quindi al lavoro, evitando lo sfruttamento, migliorando le condizioni del produttore grazie al giusto prezzo che gli viene riconosciuto e favorendo le relazioni tra i diversi soggetti.
Dal punto di vista personale, un Gas consente al singolo che vi fa parte di ottenere prodotti ottimi, di accrescere le proprie relazioni, di avere una maggiore conoscenza di ciò che acquista e, infine, di risparmiare denaro a parità di qualità dei prodotti.
Si viene a stabilire così un patto tra produttori e consumatori, ricercando lungo la filiera le condizioni migliori per tutti i soggetti coinvolti.
Molte forme
Anche se tutti i Gas utilizzano gli stessi criteri guida nella ricerca dei produttori, riassumibili con i termini «piccolo», «locale» e «solidale», i singoli gruppi si organizzano in modalità molto diverse tra loro. Ne esistono alcuni composti da poche famiglie e altri che superano il centinaio; la maggioranza dei Gas non ha una struttura formale riconosciuta, ma molti sono anche quelli costituiti in associazione.
Al di là delle differenze, i Gas si riconoscono per il loro modo di operare: dopo aver scelto da quali produttori rifornirsi, periodicamente il gruppo raccoglie al suo interno le richieste per i prodotti disponibili; queste vengono sommate per formare l’ordine complessivo del gruppo per ciascun produttore, il quale in seguito lo consegna in un luogo e un tempo definito. Il giorno della consegna, i membri del gruppo passano a ritirare la loro parte. Gli ordini dei prodotti vengono fatti periodicamente, con una frequenza che può variare da settimanale a mensile a stagionale, a seconda dei prodotti. Il gruppo, poi, si incontra periodicamente per confrontarsi sui propri acquisti, sui produttori, sui diversi temi collegati, per vivere un po’ di convivialità.

Dai Gas alle reti locali di economia solidale
Dopo i primi anni un po’ pionieristici, i Gas hanno continuato a moltiplicarsi attraverso il passaparola e la «gemmazione» a partire dai gruppi già esistenti, e a collegarsi in rete.
Nel 2014, dopo 20 anni dalla fondazione del primo, i Gas censiti in Italia erano un migliaio. Quelli effettivi erano probabilmente almeno il doppio.
Oggi è difficile dare una stima della misura del fenomeno. Secondo un sondaggio svolto per il Rapporto sul consumo responsabile 2022 curato dall’Osservatorio per la coesione e l’inclusione sociale, in Italia l’8,6% della popolazione adulta afferma di acquistare tramite un gruppo di acquisto solidale; stiamo quindi parlando di circa cinque milioni di persone che si nutrono, almeno in parte, tramite questa modalità di consumo.
I dati preliminari del 2024 mostrano che i Gas «tengono», anzi danno segni di crescita.
Le diverse reti che si sono create, sia a livello locale che nazionale, favoriscono la nascita di progetti più ampi che collegano diversi Gas, produttori e altri soggetti.
Sono così nate in questi anni molte collaborazioni lungo filiere gestite direttamente dai soggetti coinvolti nei diversi passaggi dal campo alla tavola, estendendo lo schema anche ad altri prodotti e servizi: dal pane alle patate, dalla «pummarola» agli avocado, dal vino alla carne, dai detersivi al tessile e all’energia.
Questi progetti estendono su scala più ampia gli stessi principi di mutuo aiuto che stanno alla base delle pratiche dei Gas: le relazioni tra pari e la ricerca di soluzioni che possano soddisfare nel modo migliore possibile le esigenze dei diversi soggetti coinvolti.
Allo stesso modo, i Gas e i loro intrecci di relazioni sono attivi nella costruzione di reti di economia solidale legate al territorio, identificate con il termine Distretti di economia solidale (Des).

I Gas al passaggio d’epoca
Nel 2024 i Gas compiono trent’anni; l’anniversario è diventato un’occasione per riflettere insieme su cosa è successo in questo tempo, ma soprattutto su come affrontare il futuro.
Molte cose sono cambiate, e ci rendiamo conto di entrare in una nuova era, quella che Gigi Anataloni su Missioni Consolata (marzo 2024) chiama «nuovo feudalesimo». Un’era segnata dal riscaldamento globale e dal capitalismo delle piattaforme, che altri chiamano tecnofeudalesimo. Chi vuole costruire un mondo equo e sostenibile si interroga su come attraversare le diverse crisi della nostra società.
Una cosa che abbiamo imparato è che la legge della collaborazione, quella che Pablo Servigne e Gauthier Chapelle, chiamano «l’altra legge della giungla», è quella che ci consente di vivere meglio. Mentre la prima legge della giungla, quella nota della competizione, consente agli individui di primeggiare gli uni sugli altri, la legge della solidarietà si dimostra vincente a livello di gruppo: i gruppi che vivono meglio nel loro ambiente sono quelli che collaborano maggiormente; infatti, quando le condizioni sono ostili, collaborare è una questione di sopravvivenza.
I Gas e le altre forme di economia solidale hanno in questo un’enorme utilità: ci mostrano che l’altra legge della giungla, quella del mutuo aiuto, ha un suo valore e una sua forza, e ci allenano ad applicarla.
Speranza attiva
Le reti che si sviluppano lungo le filiere sono quelle che ci possono aiutare ad attraversare le avversità. È il caso del Furgoncino solidale (vedi box qui sotto): quando i produttori romagnoli colpiti dall’alluvione sono stati invitati a «salire a bordo» del furgoncino, hanno ricevuto un sostegno attraverso l’inserimento dei loro prodotti in una rete di distribuzione gestita insieme da Gas e produttori.
È questo il modo in cui le reti di solidarietà si attivano, prefigurando la capacità di generare risposte praticabili che aiutano tutti a stare meglio, fornendo strumenti concreti per rispondere agli eventi avversi, mostrando il mondo come lo vorremmo e alimentando in questo modo la speranza attiva.
La strategia del bambù
In questa resistenza alle derive della nostra società, per costruire un mondo equo e sostenibile, i Gas e le altre pratiche degli stili di vita hanno a nostro avviso un ruolo fondamentale: quello di formare un intreccio sotterraneo che conserva e porta il nutrimento.
La foresta di bambù ha una strategia particolare per resistere alle avversità: le canne che noi vediamo svilupparsi verso l’alto sono ancorate a un reticolo di rizomi, delle specie di radici, che si estendono in larghezza sotto la superficie del terreno. L’intreccio dei rizomi delle diverse piante sostiene le canne. In caso di vento forte o neve, queste si piegano, ma quando le condizioni avverse sono terminate ritornano alla loro posizione grazie alla loro flessibilità e alla piattaforma di rizomi intrecciati che le sostiene. Inoltre, i rizomi penetrano il terreno e colonizzano nuovi territori.
I Gas e le altre pratiche degli stili di vita sono come i rizomi che si sviluppano in estensione sotto la superficie, attaccati alle canne che crescono verso l’alto e ne costituiscono la parte visibile: i produttori, le filiere, le campagne, i progetti, le attività economiche.
La resistenza della foresta alle avversità si basa sull’intreccio sotterraneo tra le diverse piante; le canne catturano la luce del sole con le loro foglie, ma si sostengono su una rete di rizomi fitta ed estesa; sono questi a distribuire il nutrimento e scavare il terreno.
La forza della foresta sta nell’estensione dell’intreccio e delle connessioni sotterranee, nel sostegno reciproco tra la parte visibile e quella invisibile.

Pensiamo che il ruolo dei Gas sia mantenere ed estendere lo strato vitale sotterraneo, penetrando nuovi terreni e portando nutrimento ai germogli che in primavera crescono verso la luce del sole.
Le reti e i reticoli dei gruppi e delle organizzazioni che costruiscono un mondo equo e sostenibile, connessi e intrecciati tra loro, attraversano l’epoca tecnofeudale conservando la vita e nutrendo i germogli.
Effetto Gas
In occasione del trentennale dalla nascita del primo Gas, numerosi gruppi e altri soggetti interessati a riflettere su come affrontare il passaggio d’epoca che stiamo vivendo si sono incontrati alla giornata «Effetto Gas» organizzata alla fiera Solidalia a Collecchio (Parma) il 25 maggio 2024, dopo un percorso di preparazione durato un anno.
Solidalia è la festa dell’economia solidale lanciata nel 2022 dal Des Parma. Tra banchetti, incontri, laboratori, giochi e musica è l’occasione per conoscere produttori, progetti e prospettive dell’economia solidale (solidalia.org).
Qui si sono tenuti lavori di gruppo per confrontarsi e identificare proposte e priorità sul futuro dei gruppi di acquisto solidale; si tratta di lavori in corso, nella volontà di mettere in gioco sempre più il ruolo dei Gas facendo tesoro dell’esperienza fatta e per guardare avanti.
In questi trent’anni moltissimi progetti sono nati e sono stati portati avanti. Alcuni di essi erano presenti tra i banchetti e gli incontri a Solidalia.
Abbiamo considerato come l’esperienza dei Gas costituisca un modello con alcune caratteristiche ancora oggi molto utili, pur nel nuovo contesto: favoriscono le relazioni paritarie all’interno del gruppo, la fiducia e la collaborazione; costituiscono un’azione concreta che alimenta la speranza sulla possibilità di resistere e modificare la situazione in cui ci troviamo; sviluppano le reti di cui abbiamo bisogno per affrontare le crisi; seguono una strategia «rizomatica» che si basa sulla forza dei legami e delle connessioni sotterranee; nutrono il sogno della costruzione di un mondo equo e sostenibile che passa anche dal nostro stile di vita.
Un modello con una forma flessibile che può essere rimescolata e reinventata per affrontare le nuove sfide del passaggio d’epoca attuale.
In questo modo i Gas nutrono la speranza, una speranza attiva, come descritta da Rebecca Solnit nell’introduzione alla raccolta di saggi sull’emergenza climatica Not too late (non è troppo tardi).
«La speranza è diversa dall’ottimismo. L’ottimismo presuppone il meglio e la sua inevitabilità, il che porta alla passività, proprio come il pessimismo e il cinismo che presuppongono il peggio. Sperare, come amare, significa correre dei rischi ed essere vulnerabili agli effetti di una perdita. La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che vale la pena fare qualcosa a prescindere da come andrà a finire».
Andrea Saroldi*
*Andrea Saroldi promuove da tempo i Gruppi di acquisto e le Reti di economia solidale come strumenti per il benvivere.
Su questi temi ha scritto numerosi articoli e pubblicato, insieme ad altri autori, Giusto movimento, Invito alla sobrietà felice, Gruppi d’acquisto solidale, Costruire economie solidali, Il capitale delle relazioni, Un’economia nuova, dai Gas alla zeta.
È presidente della Associazione GasTorino e cura il sito www.economiasolidale.net.
Bibliografia minima
Oltre alla rivista «Altreconomia», i libri:
- – Massimo Acanfora, Piccola guida al consumo critico, Altreconomia 2016.
- – Massimo Acanfora (a cura), Il libro dei Gas, Altreconomia 2015.
- – Tavolo Res (a cura), Un’economia nuova, dai Gas alla zeta, Altreconomia 2013.
- – Marco Binotto, Comunicazione solidale. Storia e media del consumo responsabile e dei gruppi d’acquisto solidale. Postfazione di Jason Nardi, Guerini scientifica, Milano 2023.
![]()
Progetti in corso
Numerosi sono i progetti dell’economia solidale in corso che collegano diversi soggetti lungo le filiere, anche su scala nazionale. Alcuni di questi sono coordinati dalla Ass. Co-energia sui temi della sovranità energetica e della sovranità alimentare (www.co-energia.org).
Nel campo della distribuzione, il progetto del Furgoncino solidale (furgoncinosolidale.it) unisce i produttori e i Gas di diversi territori con un furgone che lungo il suo percorso consegna gli ordini ai Gas e preleva i prodotti dai produttori viaggiando, così, sempre carico.
Le notizie e gli aggiornamenti sulle diverse iniziative sono disponibili sul sito della Ries, la Rete italiana di economia solidale (rete-ries.it) e sul sito economiasolidale.net.
A.S.