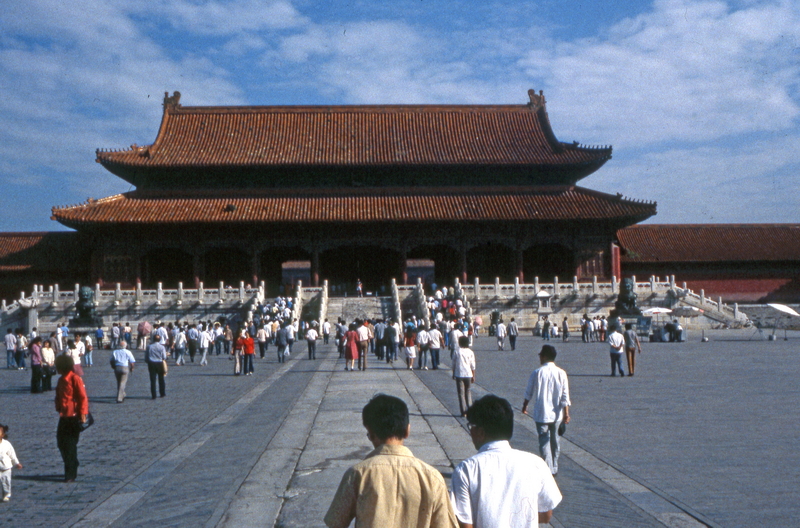Trent’anni di missione
Un’esperienza di un mese nel paese saheliano è stata per lui una «folgorazione». Da allora non ha più smesso di viaggiarci e ne ha fatto il suo Paese di adozione. Fino ad andarci a vivere. La sua è, in tutti i sensi, una famiglia missionaria. Paolo ci racconta la sua storia.
«Io sono tornato molto fiducioso da questo viaggio in Burkina Faso, con tanta voglia di ripartire e fare investimenti nel Paese». Chi parla è Paolo Turini, classe 1969, di Montevarchi (Arezzo). È tornato da qualche settimana dal paese saheliano. Ma la sua non è una butade, è una constatazione suffragata da una lunga esperienza.
Il primo viaggio come esperienza di missione lo ha fatto nel 1994, proprio in Burkina Faso. È successo quasi per caso. Poi si è creata una profonda relazione con quei luoghi.
Lì ha conosciuto Caterina Piu, pure lei volontaria, e da quel momento il rapporto con i burkinabè è stato prima di coppia e poi di famiglia.
Ma andiamo con ordine.
1994. L’inizio di tutto
«Don Gabriele Marchesi era il mio parroco, ma anche il responsabile dell’ufficio missionario diocesano di Fiesole – ci racconta Paolo -. Il 2 novembre del 1994, dopo la messa dei morti gli chiesi: “Come posso fare una esperienza missionaria?”. Lui mi parlò dei corsi di preparazione dei giovani che poi ad agosto avrebbero fatto un’esperienza di missione. Ma mi disse anche: “Però ho un biglietto per un muratore, per andare a posare delle piastrelle in un dispensario in Burkina Faso. Chi doveva andare si è infortunato, e devo trovare qualcuno per il 10 dicembre”».
Il giovane pensò subito al suo capo scout che faceva quel mestiere. «Corsi da lui, ma mi disse che aveva molto lavoro e non poteva partire. Gli chiesi se mi avrebbe insegnato a posare le piastrelle se fossi andato tutti i sabati e le domeniche a lavorare con lui. Si mise a ridere, ma annuì». Paolo fece subito la proposta a don Gabriele, non c’era un minuto da perdere. E il sacerdote: «Guarda che poi là sei da solo, devi essere bravo!». Ma gli diede fiducia, e Paolo, in alcuni fine settimana, imparò a fare il lavoro.
«Una settimana prima della partenza facemmo una riunione con altri due ragazzi che sarebbero pure partiti e con don Carlo Donati, sacerdote fidei donum, che seguiva questa missione. Fui presentato come muratore esperto!».
Arrivati a Ouagadougou, la capitale, il giorno dopo si trasferirono nella città di Koupela. Il lavoro da fare era in un villaggio, Kanougou. «Eravamo su un fuoristrada su una pista di terra e don Carlo mi disse: “Guarda: a questo sasso svolti a destra e a quell’albero a sinistra. Impara perché da domani ci vieni da solo”. E così è stato. Per venti giorni da solo, prima a portare tutti i materiali e poi a posare piastrelle. Con i bambini che venivano a prendere i ritagli per fare i presepi. Altri dieci giorni sono andato in motorino, perché l’auto non era più disponibile». Paolo conclude: «Come prima esperienza in Africa è stata folgorante».
Quell’esperienza, Paolo l’aveva cercata intensamente, ma non sa neppure lui perché. Inoltre, aveva dovuto rinunciare allo stipendio in Italia, perché aveva già fatto le ferie. Il datore di lavoro lo aveva aiutato, tenendogli il posto.
Oltre a un primo assaggio di Africa, Paolo conobbe così il gruppo missionario di don Carlo con il quale iniziò a fare volontariato. Ogni anno tornava in Burkina a svolgere compiti diversi. Nei restanti mesi, in Italia, era attivissimo: usava il suo tempo libero per le diverse attività di promozione della missione sul territorio.
1977. Un’infermiera
«Nel 1997 ero in Burkina per il mese di missione che facevo tutti gli anni. Mi dissero di andare all’aeroporto a prendere tre volontari. Scesero dall’aereo una signora, una ragazza e un ragazzo. La giovane aveva l’orecchino al naso e i tacchi alti. Ho subito pensato: ma chi l’ha mandata in Burkina? Poi iniziai a interessarmi, mi piaceva l’attenzione che dava ai malati. Così ho approfondito la conoscenza».
Caterina è un’infermiera di Nuoro, ed era andata a fare un’esperienza da una suora sarda in missione a Koupela.
«L’anno successivo siamo riusciti a fare insieme due mesi in Burkina, accumulando ferie e altri permessi. Due anni dopo ci siamo sposati».
Fu in quel periodo che Paolo e Caterina maturarono l’idea di passare più tempo nel Paese. «Quando abbiamo deciso di partire per un tempo più lungo, è stato perché, dopo tanti anni di permanenze di un mese, avevamo capito che, se ci si voleva immedesimare nella cultura e aiutare meglio, occorreva vivere sul posto. Una volta compreso questo, abbiamo cercato in tutti i modi di realizzare il nostro sogno, mettendo a disposizione i nostri talenti».
1999. Il primo anno
Il primo passo è stato ottenere per entrambi un’aspettativa di un anno dal lavoro. Paolo nel 1999 lavorava per le ferrovie come manutentore (aveva passato il concorso pubblico), mentre Caterina faceva l’infermiera.
«Io ho sempre creduto nella formazione tecnica dei giovani – continua Paolo -, affinché abbiano le competenze per realizzare essi stessi il cambiamento. Ero in linea con il metodo dei Fratelli della Sacra famiglia, e c’era il modello di Goundi (villaggio nel centro ovest del Paese) di fratel Silvestro Pia: formare i giovani e dare loro gli strumenti per iniziare l’attività».
Quell’anno di aspettativa lo passarono proprio con fratel Silvestro, con l’intento di costruire una permanenza più stabile.
«Cercammo diverse possibilità: congregazioni religiose, Ong. Nessuno si interessò al nostro progetto. A un certo punto ci eravamo accordati con il gruppo missionario di don Carlo: saremmo rimasti nel Paese a seguire i suoi progetti. Il gruppo aveva aperto tre centri per bambini malnutriti e creato diversi orti moderni. Era quasi tutto pronto, ma una telefonata che ci raggiunse proprio in Burkina durante l’anno di aspettativa ci gelò: “Mi dispiace, non possiamo permettercelo economicamente”.
Don Gabriele conosceva tutta la questione. Ci disse: “Se mi garantite di rimanere cinque anni, trovo una formula”. E trovò quella dei missionari laici, che all’epoca era molto complicata. La diocesi di Fiesole ci avrebbe dato un rimborso per pagarci i contributi, circa 500 euro a testa al mese. Avremmo pagato solo i miei, perché gli altri ci sarebbero serviti per vivere. Non possiamo smettere di ringrazialo perché ci permise di partire».
2001. E missione sia
Paolo e Caterina partirono nel marzo del 2001. Iniziarono dando un aiuto ai padri Camilliani, alla periferia di Ouagadougou, in un centro dove accoglievano malati di Aids. Si occupavamo di completare la formazione degli infermieri neo diplomati e di altre attività. «Non era esattamente il nostro sogno, ma ci permise di partire. Prendemmo un impegno di un anno, poi ci saremmo spostati».
Arrivò la soffiata che una sezione dei Lions (organizzazione filantropica, ndr) voleva finanziare progetti di formazione professionale nel Sud del mondo. Paolo, preso a modello il centro di formazione professionale di Goundi, scrisse un documento da presentare all’associazione. La cifra necessaria era di 75mila euro: «Volevamo realizzarlo nella diocesi di Koupela, perché c’era l’accordo con la diocesi di Fiesole. Parlando con il vescovo, questi ci suggerì proprio Kanougou, perché c’era una struttura, il dispensario delle suore dove anni prima avevo messo le piastrelle, che aveva alcune stanze libere. Inoltre c’era il pozzo per l’acqua».
Le cose non andarono bene: «Anche questa volta arrivò una telefonata che ci lasciò di stucco: i Lions stavano ristrutturandosi e non avrebbero finanziato alcun progetto».
Ma la coppia missionaria era tenace. Lavorando dai Camilliani avevano conosciuto un medico italiano, che si impegnò a trovare loro un primo finanziamento. «Abbiamo deciso di cominciare con una cifra molto più bassa, poi via via si sono aggiunti altri contributi: dal centro missionario di Montevarchi, dallo stesso gruppo di don Carlo e da tanti altri ancora. Lavorando un po’ alla volta, siamo riusciti a realizzare tutto, tranne la sala polivalente, che avevamo capito non essere necessaria. Ci abbiamo messo più tempo, ma abbiamo avuto una spesa totale di 65mila euro».
Riflessioni
I due missionari laici si resero conto che vivere sul posto la missione ha un valore aggiunto molto importante: «L’idea di missione che si ha facendo viaggi periodici nel paese per brevi periodi non sempre è adattata al contesto. Per questo io e Caterina abbiamo deciso di stare a vivere in Burkina. Gli anni passavano, il Paese cambiava, cresceva, ma in Italia era rimasta l’idea dell’Africa dei container. Vivendo lontani si rischia di avere un approccio di aiuto di vecchio stile». Certo, lasciare tutto e partire è molto più complicato che mettere a disposizione le proprie ferie ogni anno: «Abbiamo dovuto entrambi licenziarci dal lavoro. Devo dire che le nostre famiglie ci hanno sempre supportati. A Caterina hanno detto: “Basta che tu sia felice”. E mia mamma ha chiosato: “Tanto tu alle ferrovie non sei mai andato volentieri”».
Ripensando al periodo di residenza in Burkina, Paolo ricorda che non era sempre tutto facile, anzi: «Qualche batosta c’è stata. Alcuni problemi che ti fanno dire: ma chi me lo ha fatto fare. Ma poi ci sono le motivazioni di fondo che ti aiutano ad andare avanti».
Nel frattempo arrivarono i primi due figli, Samuele e Francesco, e la famiglia missionaria si era allargata.
2006. Il ritorno
Il 12 agosto del 2006 arrivò una di quelle telefonate che impongono decisioni importanti. «Il provveditorato agli studi mi informava che ero passato di ruolo. Avevo dato il concorso per la scuola molti anni prima. In 48 ore avrei dovuto decidere se prendere il posto o lasciare. Partire o restare in Burkina.
Quella notte non riuscivo a dormire. Mi giravo e mi dicevo: ma chi ce lo fa fare di tornare in Italia? Stiamo qui. Poi mi rigiravo: abbiamo già due figli e quando cresceranno cosa si farà? Don Gabriele era andato in missione in Brasile. Non si sapeva se la diocesi ci avrebbe rinnovato il contratto. Le incognite erano tante. Apro gli occhi e vedo una lucina rossa nel buio della stanza. Penso al tabernacolo. Sento che mi dice: torna in Italia poi semmai ritorni in Burkina.
Al mattino mi sveglio e dico a Caterina: si è deciso, si riparte. Poi mi accorgo che la lucina era lo zampirone contro le zanzare. Ma oramai si era deciso».
In Italia Paolo e Caterina diventarono l’anima del centro missionario Bakonghe, che si costituì come associazione. Furono, inoltre, nominati entrambi responsabili del Centro missionario diocesano di Fiesole, primi laici a svolgere questo servizio. Paolo continuava a seguire il progetto di Kanougou e, una volta all’anno, andava in Burkina.
Ma ci confessa: «Non sempre siamo contenti della scelta di tornare in Italia. Adesso Samuele ha 20 annie sta già lavorando. Francesco e all’ultimo anno delle superiori, e Petra, nata dopo il rientro, al terzo. Vediamo quando saranno autonomi se tornare in Burkina».
2024. Nuove idee
Nel gennaio di quest’anno Paolo è tornato dall’ultimo viaggio missionario con una nuova idea. «Voglio realizzare una fabbrica di motozappe. Se funziona, può migliorare la vita dei contadini burkinabè, e anche darci un piccolo introito che ci permetta di tornare a vivere in Burkina per seguire le attività del centro di formazione a Kanougou».
Paolo ci dice che l’attuale governo vuole favorire l’agricoltura e quindi cercherà di contattare il ministero. «Prevedo una parte per l’assemblaggio delle motozappe e una parte per la vendita. Il prezzo deve essere accessibile a una famiglia del posto. Servono circa 50mila euro, ma non tutti insieme, si può iniziare con una prima parte e poi andare avanti. Ma in tre anni la fabbrica deve essere produttiva. Devo iniziare a cercare i finanziamenti».
Nel frattempo Paolo sta contattando aziende italiane produttrici di motozappe per proporre eventuali collaborazioni, sia tecniche che finanziarie. Intanto con Caterina continua l’attività missionaria con il centro Bakonghe e con la diocesi.
«Lascerei il Cmd anche ad altri, ma purtroppo in Italia adesso c’è poco interesse per la missione», si lamenta. E fa un commento su come è stato vissuto il loro rientro dalla missione: «Quando siamo venuti via dal Burkina, temevo che i burkinabè ci accusassero di essere dei traditori. Cosa che non è mai accaduta. Piuttosto, ci hanno sempre detto: “Voi potrete aiutarci anche dall’Italia”. Invece qui da noi c’è gente che ci ha detto: ma cosa siete tornati a fare, abbiamo bisogno di voi in Burkina. Voglio dire che abbiamo avuto più difficoltà da parte degli italiani che dagli africani».
Dopo trent’anni di missione in Burkina Faso, seppure con modalità diverse, Paolo è più motivato che mai. Neanche la difficile situazione sociopolitica del Paese lo scoraggia. E con lui, la sua famiglia missionaria.
Marco Bello