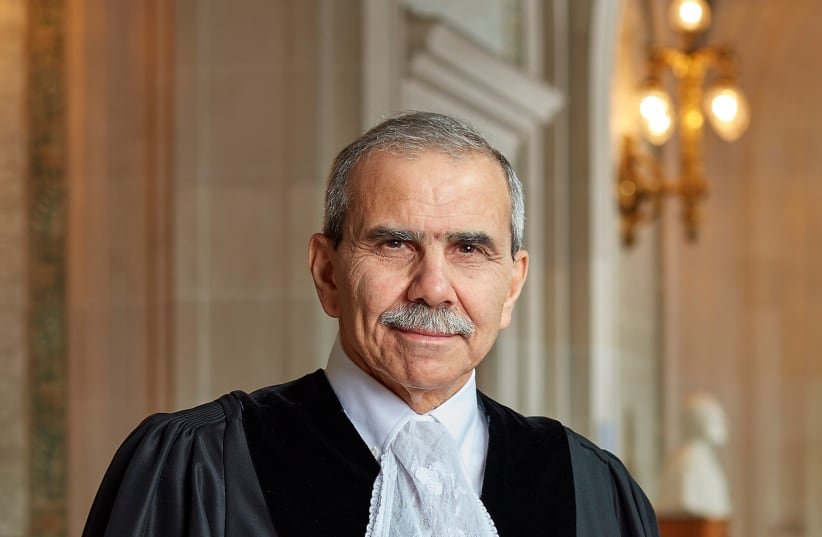Gaza, «qui non c’è più niente»
Per il governo israeliano è una guerra di legittima difesa. I fatti raccontano però una realtà molto diversa. A cominciare dal numero impressionante dei morti palestinesi. E mentre le accuse di genocidio si moltiplicano, c’è chi parla di suicidio di Israele.
Quindici mesi di guerra, una fragile tregua e una pace che pare lontanissima. Terrorismo o resistenza? Legittima difesa o genocidio? Difficile trovare un tema tanto divisivo come quello che riguarda Israele e Palestina.
Per limitarci a un esempio italiano, il giorno seguente all’annuncio della tregua, il direttore di un quotidiano pubblica un peana in onore di Benjamin Netanyahu: «Quest’uomo si è dimostrato un eccezionale leader di guerra», si legge tra l’altro (Libero, 16 gennaio). Ben diversa è l’opinione del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, secondo il quale il premier israeliano non può essere il futuro (la Repubblica, 21 gennaio).

E poi arrivò Trump
La tregua tra i contendenti è arrivata negli ultimi giorni di presidenza di Joe Biden. L’ex presidente statunitense è stato un protagonista remissivo del conflitto concedendo armi e un’assoluta libertà d’azione al primo ministro israeliano. Premesso questo, Donald Trump, il suo successore alla guida degli Stati Uniti, non è stato l’artefice della tregua (come ha sostenuto in virtù del suo egocentrismo ipertrofico) e certamente non può essere considerato un fautore della pace. Nel primo giorno di insediamento (20 gennaio), il
tycoon ha firmato un ordine esecutivo che ha tolto le sanzioni contro i coloni israeliani della Cisgiordania (West Bank, ma Giudea e Samaria per i fondamentalisti religiosi ebraici), invasori delle terre palestinesi tanto estremisti quanto Hamas. Successivamente, ha proposto di ripulire (testuale, «clean out») Gaza spostando i palestinesi in Giordania ed Egitto. Durante il suo primo mandato, lo stesso Trump riconobbe Gerusalemme come capitale d’Israele (dicembre 2017), un palese atto di sfida ai palestinesi. Da ultimo (4-5 febbraio), sono arrivate le sue sparate (molto apprezzate da Netanyahu e dai coloni) sul trasformare Gaza, svuotata dai palestinesi, nella «riviera del Medio Oriente» sotto controllo Usa.
Che la tregua si trasformi da temporanea a permanente sarebbe già un successo. Mentre la pace pare tanto lontana quanto la soluzione «due popoli, due stati», l’unica plausibile.
Distruzione, morte e il suicidio di Israele
Osservare le immagini aeree di Gaza significa vedere una distruzione tale da rimanere senza fiato. Secondo un’analisi del Centro satellitare delle Nazioni Unite (Unosat), più di due terzi degli edifici della striscia sono stati distrutti o danneggiati (pari a oltre 170mila edifici, compresi ospedali, scuole, luoghi di culto, infrastrutture civili). Tuttavia, le città si possono ricostruire, mentre la stessa cosa non può avvenire per le vite umane.
Secondo i numeri di Al-Jazeera, su informazioni del ministero della Salute palestinese, al 3 febbraio 2025 i morti sono stati 1.139 tra gli israeliani e (alme-
- no) 62.614 tra i palestinesi. Tra questi, 17.673 bambini. Altre 14.022 persone risultano disperse.
Il governo israeliano ha sempre negato le cifre diffuse dai palestinesi e dai media internazionali. Eppure, The Lancet, una delle più prestigiose riviste scientifiche del mondo, ha addirittura parlato di cifre sottostimate (articolo del 9 gennaio 2025 che ne segue uno del 5 luglio 2024).
Il già impressionante numero delle vittime palestinesi è sottostimato in quanto, per esempio, non considera le morti indirette. «I conflitti armati – spiega The Lancet nell’articolo di luglio – hanno implicazioni indirette sulla salute oltre al danno diretto della violenza. Anche se il conflitto finisse immediatamente, continuerebbero a esserci molte morti indirette nei prossimi mesi e anni per cause quali malattie riproduttive, trasmissibili e non trasmissibili. […] Nei conflitti recenti, tali morti indirette vanno da 3 a 15 volte il numero di morti dirette».
La rivista stima che, al 30 giugno 2024, i morti tra i palestinesi fossero 64.260. Dunque, a questa cifra andrebbero aggiunte le persone morte tra luglio 2024 e febbraio 2025.
Ragionare attorno al numero dei morti non è un esercizio vano. A parte il dolore per la perdita di vite umane, la questione è l’odio che da questi lutti inevitabilmente si genera. Anche per questo pare adeguato il titolo che la storica ebraica Anna Foa ha scelto per il suo ultimo libro: «Il suicidio di Israele» (Laterza, ottobre 2024).

Se l’antisionismo diventa antisemitismo
In Occidente, chi critica il governo israeliano è spesso tacciato di antisemitismo. Per comodità, per partito preso, per allergia alla critica. Il termine antisemitismo significa – secondo l’Enciclopedia dell’Olocausto (curata dallo United States Holocaust memoria museum di Washington) – «pregiudizio o odio nei confronti del popolo ebraico. […] È una forma di intolleranza e razzismo. […] è un insieme di credenze e idee dettate dall’odio contro gli ebrei e la religione ebraica, il giudaismo».
A volte può trattarsi di antisionismo, probabilmente più comune, ma anch’esso sbagliato come il precedente. Secondo la Treccani, l’antisionismo è un «atteggiamento culturale e politico di opposizione e di contrasto alle più radicali espressioni del sionismo. [Questo è il nome dato al] movimento politico e ideologia volti alla creazione di uno Stato ebraico in Palestina (da Sion, nome della collina di Gerusalemme)».
La realtà è probabilmente quella descritta da Anna Foa: «Cresce l’antisemitismo nel mondo e l’antisionismo si colora sempre più di antisemitismo». Anche in Italia, paese che ha conosciuto l’antisemitismo non soltanto negli anni del fascismo. I ricorrenti insulti alla senatrice Liliana Segre, superstite dell’Olocausto, ne sono la testimonianza.
Massacro o genocidio?

Rimane da stabilire se la guerra tra Israele e Palestina sia stata un atto di legittima difesa del governo Netanyahu dopo l’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023, oppure, come appare ai più, una vendetta trasformatasi presto in massacro. O in genocidio.
«Il termine “genocidio” – si legge nella citata Enciclopedia dell’Olocausto – non esisteva prima del 1944. Si tratta di un termine molto specifico, che indica crimini violenti commessi contro determinati gruppi di individui con l’intento di distruggerli». Ha parlato di genocidio papa Francesco, che non ha mai risparmiato frecciate al premier Netanyahu. Parlano di genocidio i rapporti di tre grandi organizzazioni internazionali: Amnesty International, Human rights watch e Medici senza frontiere.
Scrive Human rights watch: «Le azioni delle autorità e delle forze israeliane per privare la popolazione di Gaza dell’accesso all’acqua equivalgono ad atti di genocidio ai sensi della Convenzione sul genocidio e dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale» (Extermination and acts of genocide. Israel deliberately depriving palestinians in Gaza of water, dicembre 2024). Altrettanto circostanziate sono le accuse di Amnesty che, nelle ultime pagine del suo rapporto, scrive: «Amnesty International ritiene che il modello di condotta che ha caratterizzato le operazioni militari di Israele […] forniscano prove sufficienti dell’intenzione di Israele di distruggere i palestinesi di Gaza, in quanto tali» (“You feel like you are subhuman”. Israel’s genocide against palestinians in Gaza, dicembre 2024).
Leggiamo, infine, nel rapporto di Medici senza frontiere (Gaza: life in a death trap, dicembre 2024): «Gli ospedali sono stati assediati, presi di mira da attacchi aerei o bombardamenti e presi d’assalto dalle truppe di terra, le ambulanze sono state colpite, i pazienti e il personale sono stati uccisi».
La conclusione del rapporto di Msf è carica di pessimismo: «Anche se il brutale assalto di Israele finisse oggi, l’impatto a lungo termine di tale carneficina e distruzione sfiderebbe qualsiasi tentativo di definirlo. […] Ricostruire Gaza sarà un compito monumentale in questa scala di distruzione senza precedenti. […] Potrebbero volerci fino a 15 anni per ripulire le macerie e 80 anni per ricostruire le abitazioni».
«Qui non c’è più niente», conferma a Francesca Caferri (la Repubblica, 22 gennaio) padre Gabriel Romanelli, missionario verbita. Nativo di Buenos Aires, prime esperienze in Egitto e in Giordania, il sacerdote è a Gaza dal 2019, dove è parroco della chiesa della Sacra Famiglia, l’unica chiesa cattolica della Striscia. Dice che ora la sua prima preoccupazione è quella di riaprire la scuola della parrocchia.
Preoccupazione comprensibile se si considera l’impatto devastante prodotto dalla guerra sull’educazione scolastica dei bambini palestinesi, un’educazione peraltro già altamente deficitaria prima di quest’ultimo conflitto. Quali sentimenti rimarranno nella loro testa rispetto a chi li ha ridotti a vivere così? Non pare azzardato ipotizzare almeno risentimento, ma più probabilmente vero e proprio odio nei confronti del nemico israeliano. «Tutti i bambini di Gaza – scrive l’Unicef – sono stati esposti alle esperienze traumatiche della guerra, le cui conseguenze dureranno tutta la vita».
Le colpe dei governanti


A Gaza, il governo fondamentalista di Hamas è stato fallimentare. In Cisgiordania l’anziano e inconcludente presidente palestinese Abu Mazen è in carica senza interruzione da vent’anni. I palestinesi meritano rappresentanti politici nuovi e migliori. Quanto agli israeliani, Benjamin Netanyahu è al suo terzo mandato per un totale di sei governi e diciassette anni al potere, gli ultimi caratterizzati anche da scandali e processi per corruzione. Del suo attuale governo fanno parte integrante alcuni partiti, noti per il loro fondamentalismo religioso (che trova nella Bibbia ebraica la giustificazione del loro agire) e politico (che si manifesta nell’ultranazionalismo e nell’ideologia antiaraba).
«Netanyahu e il suo governo – scrive ancora Anna Foa – devono pagare non solo per quello che hanno fatto ai palestinesi di Gaza, ma anche per quello che la loro politica ha comportato per la stessa Israele. Gli israeliani dovranno trattare con Hamas, colpevole della terribile strage del 7 ottobre, ma i palestinesi dovranno trattare con chi è colpevole di aver distrutto le loro case e ucciso le loro famiglie».
Paolo Moiola