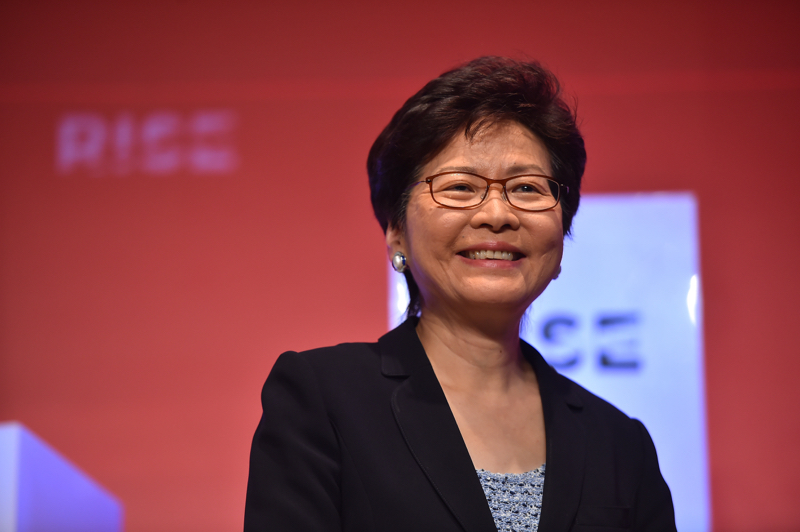Cina. L’offensiva culturale di Xi
L’attacco agli Stati Uniti e all’Occidente da parte del presidente cinese è sistematico e totale. Mira a sostituire idee e valori con la visione cinese. Ma a una disamina attenta emergono le molte contraddizioni di Pechino.
Si dice fosse la città più grande al mondo, con lunghe mura di argilla e un imponente palazzo reale all’interno. Stiamo parlando delle antiche rovine di Liangzhu, risalenti a 5.300 anni fa, ben mille anni prima della dinastia Shang, la prima ad apparire nella documentazione storica scritta.
Quella fiorita sul delta del fiume Azzurro, nell’area che oggi corrisponde alla periferia di Hangzhou, viene considerata tra le culture neolitiche tecnologicamente più avanzate al mondo: quelle rovine ospitano i resti della più antica struttura di ingegneria idraulica di tutta la Cina.
Liangzhu non è però solo la culla della civiltà cinese. Il sito archeologico offre anche i presupposti ideologici per un nuovo ordine internazionale, così come vagheggiato da Pechino: più «democratico» e inclusivo rispetto all’architettura mondiale definita dall’Occidente dopo la Seconda guerra mondiale.
Può sembrare strano, ma le ambizioni riformiste (qualcuno dirà «revisioniste») della leadership cinese attingono a piene mani a quel lontano passato. Per capire perché, occorre arrotolare il nastro al 15 marzo 2023, quando il presidente Xi Jinping, intervenendo a un meeting con i partiti politici stranieri, ha proposto una nuova soluzione alle «molteplici sfide globali»: «Tolleranza, coesistenza, scambi e apprendimento reciproco tra le diverse civiltà svolgono un ruolo insostituibile nel far avanzare il processo di modernizzazione dell’umanità», ha spiegato Xi.
La globalizzazione «armonica» di Xi
![]() Da quel discorso ha preso forma uno dei pilastri della politica estera cinese: la Global civilization initiative (Gci), l’ultima di tre iniziative che, insieme, suggeriscono come perseguire lo sviluppo economico mondiale (la Global development initiative), il mantenimento della sicurezza internazionale (la Global security initiative), e appunto la gestione delle relazioni diplomatiche (la Gci). Secondo quest’ultima, ogni Stato ha una sua cultura specifica e specifici valori che meritano rispetto. Pertanto, è possibile convivere armoniosamente solo rinunciando all’imposizione di relazioni gerarchiche e astenendosi dall’interferire nelle questioni interne degli altri paesi. Non esiste un modello politico economico migliore o universalmente valido.
Da quel discorso ha preso forma uno dei pilastri della politica estera cinese: la Global civilization initiative (Gci), l’ultima di tre iniziative che, insieme, suggeriscono come perseguire lo sviluppo economico mondiale (la Global development initiative), il mantenimento della sicurezza internazionale (la Global security initiative), e appunto la gestione delle relazioni diplomatiche (la Gci). Secondo quest’ultima, ogni Stato ha una sua cultura specifica e specifici valori che meritano rispetto. Pertanto, è possibile convivere armoniosamente solo rinunciando all’imposizione di relazioni gerarchiche e astenendosi dall’interferire nelle questioni interne degli altri paesi. Non esiste un modello politico economico migliore o universalmente valido.
Si tratta di una visione che promuove la saggezza degli antichi principi confuciani e taoisti (dell’«armonia senza uniformità» e «della coesistenza armoniosa delle differenze») come ricetta per affrontare guerre, discriminazioni razziali, competizioni geopolitiche tra paesi: i mali della contemporaneità che Pechino attribuisce alle vecchie potenze occidentali, smaniose di esportare il proprio sistema democratico in giro per il mondo. Oltre che da Confucio e Laozi, il trittico Gdi-Gsi-Gci trae ispirazione dal concetto di «comunità dal destino condiviso», teorizzato dalla leadership cinese negli anni Novanta. Xi lo ha reso uno dei principi cardinali della sua politica estera prima ancora di avviare la Belt and road initiative (Bri), il progetto infrastrutturale volto a riportare l’ex Celeste Impero al centro delle dinamiche economiche e geopolitiche globali. Il presupposto è che «il futuro di tutti i paesi è oggi strettamente connesso» e che «pace, sviluppo, equità, giustizia, democrazia e libertà» sono «aspirazioni comuni» verso cui tendere.
Relativizzazione dei valori e nessuna ingerenza
Se la Bri punta soprattutto a infondere sviluppo materiale, le tre nuove sigle gettano invece i presupposti teorici per un nuovo modello di governance mondiale. Ergo, alla Cina non basta più presentarsi come il paese in via di sviluppo diventato seconda economia mondiale. Vuo-le che allo status economico corrisponda un riconoscimento politico e culturale.
È un’ambizione maturata nel corso di decenni, oggi più esplicita alla luce dei «profondi cambiamenti mai visti in cento anni di storia», come direbbe Xi: le guerre in Ucraina e Medio Oriente hanno evidenziato come una cospicua parte di mondo condivida il malcontento di Pechino nei confronti della postura occidentale nei due conflitti. Per quanto discutibile e largamente retorica, nel cosiddetto Sud globale la «neutralità» cinese viene apprezzata più della conclamata vendita di armi americane a Kiev e Tel Aviv.
Sul giudizio pesano le promesse mancate del Nord del mondo in merito alla necessità di riformare gli organi multilaterali, ancora troppo poco rappresentativi dei paesi emergenti. Esigenza di cui la Cina si è resa portavoce, dall’interno, incoraggiando l’ampliamento delle vecchie istituzioni internazionali (come il G20 e il Consiglio di sicurezza dell’Onu); dall’esterno, incentivando la nascita di piattaforme concorrenziali, a partire dai Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), che nel 2024 hanno accolto altri quattro membri (Etiopia, Egitto, Iran ed Emirati arabi uniti).
Come appare evidente, gli effetti della Gci non sono esclusivamente «culturali», almeno non in senso stretto. Difficile non notare come la relativizzazione dei valori promossa dalla sigla smentisca l’universalità dei diritti umani, che Pechino subordina al raggiungimento del benessere economico. Mentre, sottoposta a un’interpretazione westfaliana della sovranità (lo Stato-nazione), l’ingerenza della comunità internazionale nelle dinamiche politiche dei paesi viene respinta sempre e comunque. Anche davanti all’«operazione militare speciale» di Putin in Ucraina o a una possibile (ri)unificazione di Taiwan alla Cina continentale.
Teoria e realtà
C’è chi ritiene che la missione civilizzatrice di Xi strizzi l’occhio alle autocrazie amiche. Riferimenti alla Gdi, Gsi e Gci, sono ormai una costante nei comunicati congiunti durante gli incontri con gli emissari del Sud globale. Eppure, l’approccio autoreferenziale dell’iniziativa cinese rischia di limitare notevolmente la cerchia degli ammi-
ratori. Se «pace, sviluppo, equità, giustizia, democrazia e libertà» sono principi incontestabili, è impossibile non riscontrare come nel mondo reale Pechino fatichi a rispettarne il significato letterale. Basta pensare all’espansionismo militare nel Mar cinese meridionale, che la Repubblica popolare rivendica quasi tutto per sé e dove negli ultimi mesi pescherecci e guardia costiera delle Filippine sono stati respinti a cannonate d’acqua. O alla repressione delle minoranze musulmane nello Xinjiang, la provincia cinese al confine con l’Asia centrale. Difficile parlare di rispetto per le differenze culturali quando le diversità vengono annullate persino dentro i confini nazionali.
![]()
La superiorità cinese
Scricchiola anche l’assioma dell’«equità», tanto caro al Sud globale. A parole la Cina sostiene la tradizionale architettura internazionale con al centro le Nazioni Unite: l’organizzazione, che meglio esprime le istanze dei paesi in via di sviluppo, figura esplicitamente nei documenti fondativi delle tre nuove iniziative globali di Pechino. Eppure, balza all’occhio come la retorica dei media statali spesso non esiti a rimarcare l’eccezionalità della tradizione cinese.
In una lettera scritta per commemorare il sito archeologico di Liangzhu, Xi ha affermato che la civiltà cinese, essendo «aperta e in costante cambiamento» da oltre 5.000 anni, «assorbe le parti migliori di altre civiltà da tutto il mondo». Riprendendo lo stesso concetto sulla rivista teorica Qiushi, lo scorso maggio il presidente spiegava senza giri di parole che «dal punto di vista della tradizione culturale, la civiltà cinese è l’unica civiltà al mondo che è continuata fin dall’antichità senza interruzioni. L’effetto combinato di molteplici fattori ha consentito alla nazione cinese di modellare gradualmente una mentalità nazionale e una psicologia culturale indipendenti e autonome nel suo sviluppo storico».
Questa autonomia, profondità e longevità – aggiunge il leader – attribuisce alla civiltà cinese «un fascino unico che è diverso dalle altre civiltà del mondo».
Tra le righe, si scorge una malcelata forma di «suprematismo culturale» molto antica che, se in epoca imperiale si manifestava nei confronti dei paesi «vassalli» del vicinato asiatico, oggi spesso emerge per scoperchiare i «doppi standard» degli Stati Uniti, modello di democrazia solo quando si tratta di criticare i paesi rivali.
Non potendo ancora rivendicare una superiorità economica (che, peraltro, oggi pare allontanarsi), a Pechino non resta che reclamare un primato immateriale: il tema della pochezza culturale degli Stati Uniti, il «nuovo mondo» senza storia, ricorre frequentemente sui media cinesi. D’altronde, oltre la Muraglia, proprio lo scontro geopolitico con Washington sembra aver rinvigorito quell’orgoglio per il passato negli ultimi vent’anni un po’ offuscato dai numeri luccicanti del Pil.
Il rapporto con gli Stati Uniti
Nelle relazioni con gli Usa, c’è un prima e c’è un dopo l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, nel 2017. Quello è stato il momento in cui la competizione sino-americana è debordata sul piano ideologico. Che sia stato così, è diventato evidente, però, solo nell’aprile di due anni dopo quando, parlando al Future security forum, l’ex direttore della pianificazione politica del Dipartimento di stato degli Usa, Kiron Skinner, ha rimarcato come per «la prima volta» Washington si trovasse a fronteggiare «una grande potenza» non caucasica.
Da quel momento, per parte dell’establishment americano, la cultura e l’identità razziale sono diventate criteri per stabilire la natura – cooperativa o conflittuale – delle relazioni con gli altri Stati. Tanto che l’autorevole analista cinese Wang Jisi recentemente ha constatato come ormai «il dibattito politico e ideologico tra la Cina e gli Stati Uniti è essenzialmente definito dalle direttrici del nazionalismo, della cultura e della civiltà – “l’Oriente contro l’Occidente” – non tra socialismo e capitalismo, o tra proletariato e borghesia».
Contro le contaminazioni
È quindi la Cina che attacca o va considerata «legittima difesa»? Come spiega Xi sul Qiushi, «Sin dai tempi moderni, l’afflusso delle tendenze culturali occidentali ha avuto un impatto sulle tradizioni culturali e sul mondo spirituale del popolo cinese. Alcune persone hanno gradualmente perso la loro soggettività culturale. Come riconquistare la spina dorsale culturale è diventata una questione importante, legata alla sopravvivenza e allo sviluppo della nazione cinese». Un compito spettante al Partito comunista che, investito di una «missione storica», lo porterà avanti concentrandosi da una parte «sulla civiltà materiale», dall’altra «sulla civiltà spirituale». Il messaggio è chiaro: la prosperità economica non può prescindere dallo «sviluppo della cultura socialista». Non solo perché, come dice Xi, la Cina si sente minacciata dalle contaminazioni ideologiche esterne, ma anche perché dietro l’apparente sicurezza della leadership cinese si nascondono timori e debolezze. Impossibile non notare, infatti, come l’enfasi attribuita al passato glorioso serva a sviare l’attenzione dalle difficoltà del presente.
In patria, il rallentamento della crescita economica (scesa al 5% dal 10% del 2010) sta affossando gli stipendi; oltreconfine le disponibilità economiche più contenute hanno indotto una riduzione degli investimenti nel Sud globale.
![]()
Radici confuciane e marxismo
In cerca di nuove fonti di legittimazione, Pechino guarda indietro. Erede della Cina imperiale e maoista, la leadership comunista guidata da Xi sta investendo massicciamente nell’archeologia e nella ricerca storica per valorizzare tanto le radici confuciane quanto i «geni rossi» del Paese. Nella stanza dei bottoni viene utilizzato il termine «le due integrazioni», formula che sta a indicare la capacità con cui il Partito ha saputo armonizzare «i principi fondamentali del marxismo con le realtà specifiche della Cina e il meglio della sua cultura tradizionale, adattando continuamente il marxismo al contesto cinese e alle esigenze dei tempi».
Occorreranno mesi, forse anni, prima di poter giudicare il valore geopolitico della controffensiva culturale di Xi.
Dall’altro lato del Pacifico qualche perplessità già c’è. Per R. Evan Ellis, docente presso il United states army war college, in molte parti del mondo – proprio quelle a cui ammicca la Gci -, i concetti di «civilizzazione» e «modernità» sono ancora associati alla dominazione coloniale e all’emarginazione delle popolazioni indigene.
Senza bisogno di guardare troppo lontano, nello Xinjiang usi e costumi locali vengono considerati sintomo di arretratezza in contrapposizione al progresso economico e sociale delle province cinesi abitate dall’etnia maggioritaria Han. A quanto pare, i «doppi standard» non sono una prerogativa solo dell’Occidente.
Alessandra Colarizi
![]()