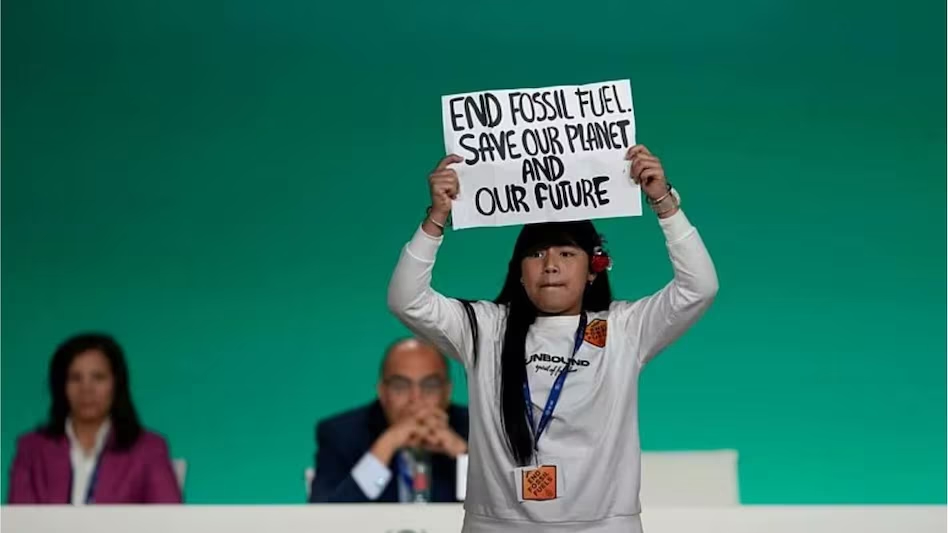Bosnia. Se la miniera è a casa tua
C’è il litio, ma anche il carbone. Nuove e vecchie miniere potrebbero stravolgere il territorio del Paese balcanico. La popolazione locale non sta però a guardare.
La questione ambientale s’inserisce in un contesto in cui le divisioni della guerra civile sono ancora vive.
Estate 2024, montagna di Ozren, distretto di Doboj, Repubblica serba di Bosnia.
Oggi, in un campo normalmente adibito a rifugio di montagna e pista da lancio per parapendii, 36 persone – tra cui ingegneri, biologi, attivisti per l’ambiente – si sono riuniti per una missione di ricerca che durerà per tre giorni. Nella squadra, ci sono uomini e donne provenienti da Bosnia, Serbia e Montenegro. L’obiettivo è quello di raccogliere campioni di flora, di acqua, e tracce della fauna di specie a rischio. Si spera che i dati raccolti in questi giorni possano portare quest’area a essere annoverata tra i parchi protetti della Bosnia. Infatti, con questo inserimento si potrebbe forse fermare l’apertura di miniere di nichel, cobalto, rame e, soprattutto, di litio.
Il campo viene inaugurato dal discorso dei due coordinatori dell’evento: Peter Špullovič e Davor Tubič. Ospite, e osservatore speciale del progetto, è Brian Aggeler, capo missione dell’Osce (Organization for security and cooperation in Europe), l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Scoperta e mobilitazione
Grazie al monitoraggio di alcuni residenti e attivisti locali, nell’ottobre 2023 si è scoperto che alcune compagnie minerarie stavano effettuando ricerche per rilevare la presenza di minerali e metalli. Su tutti, il più importante è il litio, componente fondamentale per il funzionamento di molte batterie, soprattutto quelle dei veicoli elettrici.
Queste società di ricerca fanno capo al colosso svizzero Arcore e alla Lycos metal, compagnia con base in Australia e sedi operative in tutti i Balcani. Le ricerche, da parte di Arcore, sono andate avanti per quattro anni senza che nessuno della popolazione locale ne fosse al corrente. Le associazioni ambientaliste, inoltre, affermano che tutto è stato tenuto nascosto ai residenti, ma è avvenuto con il benestare di governo e autorità. Dopo essere stata smascherata, Arcore ha ammesso di aver effettuato queste ricerche e di aver identificato, in una zona che va da Doboj a Lopare, 1,5 milioni di tonnellate metriche di carbonato di litio. Se così fosse, sarebbe uno dei più grandi giacimenti d’Europa. La compagnia svizzera ha assicurato che le estrazioni avverranno usando tecnologie di ultima generazione e che l’impatto ambientale, soprattutto su acqua e suolo, sarà minimo. Nessuno però ha creduto a questa dichiarazione. A maggior ragione, dopo quello che è accaduto a pochi chilometri da qui, in Serbia, quando nel 2022 alla multinazionale Rio Tinto è stata revocata la licenza di scavo a seguito dei danni ambientali provocati nella regione dello Jadar (cfr, MC agosto-settembre 2023).

Le grotte del ragno
Dopo la cerimonia iniziale, ci prepariamo alle prime esplorazioni. Indossiamo stivali ed elmetti per addentrarci nei boschi del Monte Ozren e all’interno delle grotte di Mokra Megara. Questo complesso di caverne è al centro del progetto di salvaguardia dell’ambiente. Le ragioni stanno nella sua storia, nella sua ricchezza di biodiversità, ma anche nella presenza di un ragno.
Il ragno Rhode Stalitoides, specie endemica dei Balcani, è una specie protetta. La sua presenza, in queste grotte, potrebbe diventare il criterio chiave per convertire l’area in un parco nazionale e impedire così i lavori di estrazione.
All’interno del nostro gruppo, si trova anche un sacerdote ortodosso: padre Gravilo Stevanovič. Padre Gravilo è un testimone della presa di posizione della Chiesa ortodossa serba sulla questione ambientale. Essa, infatti, si è apertamente schierata contro l’esplorazione mineraria, dichiarando anche la volontà di acquistare terreni, pur di salvarli.


Montagne di acqua
Come si estrae il litio? Quali sono i pericoli per l’ambiente? Vladimir è uno dei partecipanti al campo di ricerca. In questi anni si è occupato delle campagne contro le estrazioni illegali di carbone e di metalli pesanti. Inoltre, lavora a soluzioni energetiche alternative che possano sostituire i combustibili fossili. Mi spiega: «L’estrazione del litio comporta dei lavori che durano anni. Una volta terminate le operazioni, quello che rimane del territorio è un habitat invivibile per tutte le specie animali e vegetali. Con il metodo tradizionale, si effettuano delle perforazioni nel suolo. In seguito, nei fori, viene pompata salamoia. I minerali estratti vengono quindi lasciati evaporare per mesi e poi filtrati in diverse vasche fino ad ottenere il carbonato di litio. Per queste operazioni serve tantissima acqua: quasi 190mila litri per tonnellata di litio estratto. L’acqua rimasta, dopo i vari filtraggi, viene poi riversata nuovamente nell’ambiente. Queste operazioni di estrazione, ad esempio ad Atacama in Cile, hanno causato la perdita del 65% dell’acqua dolce della regione».
Zoran, ingegnere ambientale e attivista contro l’estrazione di metalli pesanti, racconta la sua storia: «Lavoravo per una compagnia statale di manutenzione degli impianti energetici. Non mi è stato rinnovato il contratto, perché mi sono unito a una Ong per la protezione dell’ambiente.
Nichel e cobalto sono metalli pesanti. Pesanti vuol dire, in questo caso, che l’estrazione e la produzione sono molto dannosi per l’ambiente. Senza dire che contengono molti componenti cancerogeni. Dodici anni fa, in Serbia, si è verificata una situazione simile a quella che ora sta avvenendo qui. In quel periodo, professori universitari e scienziati hanno pubblicato diversi trattati dove si mostra, scientificamente, l’allarmante pericolosità che le estrazioni minerarie comportano per la salute. Per avere un esempio di quello che potrebbe avvenire qui, basta guardare i giacimenti in Australia, Canada e Russia. In queste nazioni, gli scavi si effettuano in aree remote, inabitate, perché appunto pericolosissimi per l’uomo. Nel caso della Bosnia, parliamo di luoghi a ridosso di fattorie e villaggi. Per estrarre i metalli pesanti ci sono due modi: si trivella nel sottosuolo o si usano gli esplosivi. Nel caso del cobalto, anche questo presente nel nostro territorio, viene introdotto nel suolo acido solforico al 100%. Occorrono, inoltre, grandi quantità di acqua durante l’estrazio- ne. Conosciamo tutti i danni che le miniere di cobalto causano in Congo. Lì, dopo l’estrazione, le acque di scarto vengono riversate nell’ambiente, avvelenando le falde. Per 12 anni, ho lavorato a contatto con gli enti che controllavano la qualità dell’acqua, e i danni che le miniere possono causare. Tutta la documentazione prodotta, e poi divulgata al pubblico, è falsa. Tutto dipende dagli investitori, e da quanto sono disposti a pagare per contraffare i dati».
La politica
Quando chiedo se si possa sperare in un appoggio da parte di qualche formazione politica, Zoran mi risponde: «Qui la politica è sempre una questione complicata. Dopo la guerra, nel 1995, i confini sono stati ridisegnati a tavolino. Oggi, quindi, metà di queste montagne si trovano nella Republika Srpska (Repubblica serba della Bosnia), e l’altra metà nella Bosnia Federale. Sono proprio i governi che hanno erogato i permessi alle compagnie straniere. Sono le autorità politiche, quelle che dovrebbero tutelarci, le prime a non farlo. Dal ‘96 abbiamo gli stessi partiti, i principali sono tre, e puoi considerarli tutti di destra, opposizione inclusa. Qualche volta nascono nuovi movimenti, ma sono piccoli e deboli, e comunque vengono visti sempre con sospetto dalla gente. Purtroppo, molti si allontanano dalla politica per rassegnazione. Anche per questo ci troviamo in questa situazione».
Le tre formazioni politiche menzionate da Zoran sono il partito nazionalista Sda (Partito azione democratica), l’Hdz (Unione democratica croata di Bosnia Erzegovina), partito conservatore cristiano e il partito Snsd (Unione dei socialdemocratici indipendenti) considerato più moderato.
Parola di ministra

Dopo una giornata di ricerche, gli attivisti tornano al campo base. Hanno riportato qui decine di contenitori con campioni di roccia, terra, piante e acqua. Tutto verrà inviato ai laboratori per le analisi. Per la notte, ci si accampa sia nelle baite di legno che nelle tende, allestite per l’occasione.
Il giorno successivo, riceviamo una visita speciale: la ministra per l’ambiente e il turismo della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, in carica da circa un anno, la dottoressa Nasiha Pozder. Mi racconta: «Come sa bene, essendo lo Stato diviso in due entità, la situazione politica bosniaca è molto intricata. Io sono, diciamo, fuori dalla mia giurisdizione. Sono il ministro della Bosnia Federale, mentre qui ci troviamo nella parte della Republika Srpska. Mi dispiace essere qui senza la mia controparte locale. Abbiamo sempre un dialogo tra i vari organi politici ma, sicuramente, abbiamo priorità diverse. Io, nella mia carriera, ho sempre avuto a cuore il problema dell’ambiente. Sono qui perché, per noi, la campagna di pressione per ingrandire le aree protette in Bosnia Erzegovina è molto importante. Per legge, almeno il 16% delle nostre aree naturali dovrebbe essere protetto. Siamo appena al 3%. Per questo, annettere luoghi come il monte Ozren, e le grotte di Mokra Megrava, è fondamentale. Spesso, mi viene chiesto perché la politica non ha fatto nulla contro gli scavi e i rilievi illegali. Il perché bisognerebbe chiederlo a chi è stato in carica quando questi sono stati fatti. Non so se gli organi politici sono stati distratti, pigri o disattenti a riguardo, ma, in ogni caso, non hanno agito. Io, appena ottenuta la carica, ho presentato diversi piani per la protezione dell’ambiente. Sono stati tutti approvati dal governo, ma mai messi in atto.
Per natura sono una persona ottimista, anche se la realtà poi mi contraddice. Qualche volta penso di essere arrivata a questa posizione troppo tardi. Oggi, dobbiamo tenere in considerazione che, anche nel momento in cui riusciremo a proteggere un’area geografica, alle grandi compagnie basterà spostarsi di qualche chilometro per cominciare i lavori di scavo. Quindi, il danno ambientale ci sarebbe ugualmente. Una delle cose che potrebbe salvarci, sarebbe entrare in Europa. Facendo parte dell’Unione europea, le multinazionali straniere dovrebbero rispettare alcuni standard ecologici che qui non esistono. Far parte dell’Europa, inoltre, ci darebbe accesso ai fondi per il turismo. Quella potrebbe essere la svolta della Bosnia Erzegovina. Il turismo porterebbe beneficio a tutte le comunità, mentre l’estrazione di minerali solo alle grandi corporation».
Le miniere di litio
Dopo aver passato tre giorni insieme ai ricercatori sulle montagne di Ozren, mi sposto in direzione di Lopare. Questa provincia, se dovessero cominciare i lavori delle compagnie minerarie, sarebbe uno dei luoghi in assoluto più coinvolti dall’inquinamento. È stato qui, in queste valli, che i cittadini hanno scoperto i rilievi minerari segreti. Qui le campagne anti-minerarie e le proteste sono ancora oggi attivissime.
Andrjana, professoressa di lingua e letteratura serba, mi racconta com’è avvenuta la scoperta: «Prima dell’ottobre 2023, non sapevamo niente della volontà di estrarre il litio.
Quando abbiamo sentito le prime voci, abbiamo cominciato a fare ricerche ma non siamo riusciti a trovare nessun progetto ufficiale. Queste ricerche sono state fatte in segreto. Ma, anche se i dati sull’impatto ambientale fossero disponibili, sarebbero finti. Sono redatti dalle stesse compagnie che hanno effettuato le ricerche. Nessuno qui si fida più di quello che ci viene detto, tutti sanno che, al momento dell’apertura delle miniere, nessuno rispetterà gli standard per la tutela dell’ambiente. Subito dopo la nostra scoperta, abbiamo fondato un gruppo d’azione. Nella prima riunione, eravamo appena cinque. Ora siamo in 25. I politici locali all’inizio ci appoggiavano, ma lo hanno fatto solo per una questione di voti. Una volta eletti, sono spariti. Il litio esiste anche in Portogallo, Germania, Austria, ma di certo non vanno lì a scavare. Le compagnie minerarie scelgono la Bosnia perché qui non devono rispettare le norme ecologiche. Quindi, per loro è molto più economico. Qui, approfittano della mancanza di leggi, della facilità di poterle raggirare e del costo estremamente basso delle concessioni governative».
![]()
Le miniere di carbone
Già da diversi anni, i bosniaci conoscono bene i problemi che le miniere, ad esempio quelle di carbone, possono causare.
Mi metto in viaggio per Sanski Most. In quest’area sono sei i villaggi coinvolti nell’inquinamento dovuto alle miniere di carbone. Qui opera la compagnia Lager, finanziata in parte dal gruppo cinese Energy China group.
Arrivo a Bistrica, un piccolo villaggio di 700 persone, a pochi metri da un’enorme miniera. Incontro Daniel, allevatore e contadino. Dai suoi concittadini, è stato eletto portavoce del movimento contro gli abusi delle miniere. Anche perché, come mi confessa, nessuna delle autorità ufficiali viene più a far visita qui.
«Abbiamo avuto problemi fin da subito, dall’inizio delle estrazioni. Le esplosioni e le trivellazioni, spinte dai venti, sollevano le polveri che ricoprono le nostre case, i prati dove mangiano le nostre mucche, e i nostri orti. I camion che trasportano il carbone sono spesso sovraccarichi, oltre le 15 tonnellate di eccedenza. Questo distrugge anche le nostre strade. Molto spesso, a causa dei lavori, rimaniamo per giorni senz’acqua e senza corrente. La gente è stanca, perché ha già tentato tutte le vie di protesta ufficiali. Ci hanno sempre ignorato. Quelle volte in cui sono arrivati gli ispettori governativi per l’ambiente, ci hanno detto che andava tutto bene, che tutto era in regola. Ma noi sappiamo benissimo che, anche questi ispettori, fanno parte dello stesso sistema corrotto.
Da circa un anno, la gente di Bistrica si è affidata a me per portare avanti le iniziative di protesta. Al momento, abbiamo intentato delle cause giudiziarie, perché alcune esplosioni hanno causato delle frane sulle proprietà di molti contadini. C’è anche da dire che tutta questa distruzione che vedi a noi non porta nessun beneficio. Il nostro carbone va in Serbia, da lì l’energia prodotta viene venduta agli stati europei. A noi non rimane nulla».
Parlando con molti abitanti di queste zone, tutti mi dicono di aver perso la pazienza e che, se non ci saranno cambiamenti, le proteste non saranno più solo pacifiche. Nei giorni scorsi, sulle ruspe delle miniere di carbone, sono stati trovati dei bossoli di fucile, lasciati come avvertimento. La provincia di Sanski Most, nella sua storia, è stata testimone di tante lotte e tragedie. Qui, nel 1941, c’è stata una delle rivolte più importanti della Seconda guerra mondiale contro l’occupazione nazista. Qui, nel 1944, si è tenuto il principale consiglio antifascista della Bosnia Erzegovina, evento che affermò l’uguaglianza tra musulmani, serbi e croati. Nel 1992, queste valli sono state testimoni del massacro sul ponte Vrhpolje, luogo dove venti uomini bosniaci vennero giustiziati. Questa strage è stata poi annoverata tra i crimini di guerra di Momčilo Krajišnik, leader serbo condannato per l’uccisione e la deportazione dei non serbi dalla Republika Srpska.
Il peso del passato
Durante la mia visita a questi villaggi, un uomo mi ha confessato: «È sempre difficile organizzare proteste qui. È difficile perché, ogni volta, l’opinione pubblica torna con la mente ai fatti accaduti durante la guerra degli anni Novanta. Sembra quasi che le stesse persone che vorrebbero essere più attive abbiano paura di farlo temendo che le loro proteste possano sfociare in una violenza simile a quella già patita durante la guerra. Si ha il timore di rompere un equilibrio di pace che rimane fragile.
Noi però vogliamo andare avanti. Vogliamo toglierci questo marchio di nazione che ha vissuto una guerra sanguinosa. Abbiamo voglia che il mondo venga a scoprire le bellezze di questa terra, e lo possa fare sentendosi al sicuro. Questo potrà accadere solo se il nostro territorio verrà protetto dalla distruzione che le grandi multinazionali stanno causando per i loro interessi economici».
Angelo Calianno

Politica e religione. Musulmani e Ortodossi
![]() La Bosnia Erzegovina è una repubblica presidenziale, a struttura federale, nata dagli accordi di Dayton del 21 novembre 1995, accordi che posero fine alla guerra civile del 1992-1995. Lo Stato è oggi diviso in due entità: la Federazione di Bosnia Erzegovina (occupa 51% del territorio e il 67% della popolazione) con capitale Sarajevo e la Republika Srpska (Repubblica Serba della Bosnia che occupa circa il 49% del territorio, con il 33% della popolazione) con capitale Banja Luka. La religione è un elemento fondamentale della Bosnia. Durante e dopo la guerra, molte persone hanno trovato nella fede un nuovo senso di appartenenza. Il 51% della popolazione è di fede musulmana, quasi interamente sunnita. I cristiani ortodossi sono al 31%, mentre i cattolici al 15%. Il resto della percentuale è diviso in altre minoranze, soprattutto atei e agnostici.
La Bosnia Erzegovina è una repubblica presidenziale, a struttura federale, nata dagli accordi di Dayton del 21 novembre 1995, accordi che posero fine alla guerra civile del 1992-1995. Lo Stato è oggi diviso in due entità: la Federazione di Bosnia Erzegovina (occupa 51% del territorio e il 67% della popolazione) con capitale Sarajevo e la Republika Srpska (Repubblica Serba della Bosnia che occupa circa il 49% del territorio, con il 33% della popolazione) con capitale Banja Luka. La religione è un elemento fondamentale della Bosnia. Durante e dopo la guerra, molte persone hanno trovato nella fede un nuovo senso di appartenenza. Il 51% della popolazione è di fede musulmana, quasi interamente sunnita. I cristiani ortodossi sono al 31%, mentre i cattolici al 15%. Il resto della percentuale è diviso in altre minoranze, soprattutto atei e agnostici.
La fede più in crescita risulta essere l’islam. Negli ultimi 20 anni, le statistiche indicano un aumento dei fedeli musulmani dal 44 al 51% della popolazione odierna. Prima del 1990, i musulmani di Bosnia erano considerati poco praticanti. Molti non partecipavano al Ramadan e non osservavano i precetti della propria fede. Addirittura, nella zona di Mostar, molte moschee erano state trasformate in musei. Con il progredire del conflitto, l’islam divenne sempre più importante, tanto che, a un certo punto, quasi tutti i membri dell’armata Armija BiH – l’esercito della Bosnia Erzegovina – erano di fede musulmana. A quasi 30 anni dalla fine della guerra, anche se in alcuni casi la convivenza tra religioni sembra imposta, la tolleranza reciproca è uno degli obiettivi principali dello Stato. Nella Republika Srpska, dove sono state realizzate le interviste per questo reportage, la maggioranza della popolazione – quasi l’83 per cento – è cristiano ortodossa.
An.Ca.