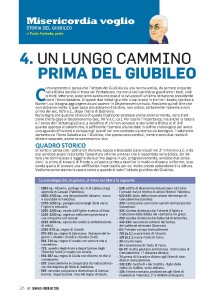Gli spazi bianchi della Bibbia
Il progetto è molto semplice, dare carta bianca a uno scrittore dicendogli: «Scegliti un brano o un personaggio, un episodio della Scrittura, e lo riscrivi in 40 o 60 mila battute». Ne sono nati 12 volumi che mostrano la forza e attualità della Bibbia, e il volto dialogante di una Chiesa in uscita.
«In un angolo del bosco, a mezza riva, con sopra l’orizzonte del cielo, sipario azzurro e nuvole, vicino a un libocedro monumentale, che lei confondendosi chiama librocedo […]; in questo angolo di bosco impervio, più terra grassa che verde, terra umida e muschio, Benedetta siede con la merenda in mano». Benedetta è una ragazzina che vive a Rueglio, in Val Chiusella, a 50 km da Torino, e ha un appuntamento: ogni giorno, per sette giorni, una voce esce da una cavea per raccontarle la Creazione, e per «ricreare», in qualche modo, Benedetta stessa.
Quella di Benedetta non è una storia vera, nel senso che non è un fatto realmente accaduto. È una storia contenuta in un piccolo libro a firma di Gian Luca Favetto, scrittore di Torino, ed è parte di un progetto denominato «Scrittori di Scrittura», che da tre anni ha coinvolto 12 autori pubblicandone i rispettivi testi con la casa editrice Effatà. La Creazione, la Resurrezione, la storia di Saul, quella di Isacco o di Giobbe, le nozze di Cana, l’episodio del giovane ricco, sono alcuni tra i passi biblici presi in considerazione e riscritti da autori come Margherita Oggero, Bruno Gambarotta, Davide Longo, Elena Loewenthal.
Suggestioni bibliche
«Ogni scrittore è partito da una suggestione, e le ha dato corpo», ci spiega l’ideatore del progetto, don Gian Luca Carrega, direttore dell’ufficio di pastorale della cultura della diocesi di Torino, oltre che insegnante di Sacra Scrittura alla facoltà di teologia e incaricato diocesano per la pastorale con le persone omosessuali credenti. «Alcuni anni fa, la Diocesi aveva regalato ai preti giovani un anno di formazione con la scuola Holden (la scuola di scrittura creativa fondata da Alessandro Baricco, nda). Venne fuori un tentativo di ri-narrazione di testi biblici che il regista Leo Muscato, responsabile del corso, aveva apprezzato. Lui mi spronò a proseguire, e nel 2007 uscì un libretto intitolato Un tempo per ogni cosa che metteva insieme 40 riscritture di brani dei Vangeli sinottici. Poi accantonai la cosa». Don Gian Luca oggi ha 44 anni ed è prete per la diocesi di Torino dal 2000: «Quando mi fu affidata la pastorale della cultura tre anni fa, mi toò in mente l’esperienza di quel libretto, e pensai: “Se questo tentativo di riscrittura lo affidassimo a dei professionisti?”».
Una Parola che provoca
A ciascuno degli scrittori coinvolti è stato chiesto di scegliere un brano della Bibbia e di riscriverlo secondo la propria sensibilità e stile, con la massima libertà. Ciascun volume è autonomo, unito agli altri solo dal cappello «Scrittori di Scrittura», dalla grafica e dalla struttura che prevede tre parti: il brano biblico scelto dall’autore, un commento al brano, scritto da un biblista, e la riscrittura d’autore.
Leggendo i volumetti si nota una grande diversità di approccio: qualche scrittore ha usato una modalità più tradizionale, simile ai midrashim (un’antica forma, spesso narrativa, di esegesi ebraica della Scrittura), producendo racconti i cui personaggi sono quelli biblici, ma narrando fatti, situazioni, psicologie che nel testo originale non sono presenti. «È il caso, ad esempio, di Silvana De Mari che ha riscritto l’annunciazione vista dagli occhi di Giuseppe, o di Elena Loewenthal che ha affrontato l’annunciazione a Sara, moglie di Abramo».
Altri hanno trasfigurato i personaggi biblici in personaggi contemporanei: «Ad esempio Elena Varvello racconta la storia di un Giobbe contemporaneo, un uomo tartassato dagli eventi che cerca un motivo di ripartenza, mentre Bruno Gambarotta rilegge il personaggio di Saul in chiave umoristica, di un umorismo drammatico». Altri ancora, come Gianluigi Ricuperati, hanno affrontato un tema attualizzandolo in una situazione odiea: «Lui ha scelto il tema della ricchezza raccontando di un prete che ha una comunità di recupero per persone dipendenti dall’uso del denaro».
«Il testo biblico si mostra un testo attuale, pieno di suggestioni interessanti anche per persone di oggi e per non credenti. Ad esempio Margherita Oggero si è sempre apertamente dichiarata agnostica, ma non ha avuto nessun problema a lavorare sulla Bibbia. Di Margherita non mi ha stupito la leggerezza di scrittura che ha avuto nel ripensare il personaggio di Isacco che è immaginato anziano, vicino alla morte, mentre ripensa a tutta la sua vita, mi ha colpito invece la sua competenza sulla Scrittura».
«Elena Loewenthal ci ha regalato anche una bella definizione della nostra iniziativa: infilarsi negli spazi bianchi della narrativa biblica. Partire da un testo sapendo che è volutamente lacunoso perché tu possa interagire con esso. Tutti i volumi sono un tentativo di risposta alla Parola che provoca».
La vita è una Bibbia apocrifa
Don Gian Luca crede nel senso ecclesiale e missionario di questa iniziativa culturale: «C’è un arricchimento spirituale in questi testi. I volumi di Scrittori di Scrittura sono utili per il credente perché lo aiutano ad avere un approccio differente alla Bibbia. I suoi protagonisti smettono di essere personaggi-tipo, e assumono una loro tridimensionalità. Prendiamo ad esempio il Giuseppe di Silvana De Mari: non è il classico Giuseppe vecchietto e un po’ passivo, ma un giovane passionale, innamorato della sua ragazza e anche geloso. Con una lettura di questo tipo sentiamo che la storia sacra è una storia vera. Quando siamo lettori passivi, diventiamo pigri e ronziamo attorno ai soliti concetti e idee. Quando invece proviamo a raffigurarci le scene, scatta un processo d’immedesimazione. La Scrittura ci parla anche attraverso questo. La storia sacra ci dice che anche la nostra storia è sacra, che noi viviamo un’esperienza in continuità con la Scrittura. Scherzando, abbiamo chiamato il nostro progetto una “Bibbia apocrifa”, e lo è, come di fatto lo è anche la vita stessa delle persone. Anche le nostre vite fanno parte di un progetto che non si è concluso con l’ultimo libro della Bibbia. Noi continuiamo a vivere vicende che sono guidate dallo stesso Spirito che ha animato la Scrittura. Le nostre esperienze sono un bacino per lavorare su ciò che il Signore ci ha detto tramite la Parola».
Una Chiesa in uscita
Chiediamo a don Carrega come, secondo lui, questo progetto si inserisca nel cammino della Chiesa: «Scrittori di Scrittura è il tentativo di metterci in ascolto gli uni degli altri: la Chiesa in ascolto dei “laici”, e viceversa. Ad alcuni è sembrato che volessimo svendere il patrimonio della Scrittura trattandolo come un libro qualunque. Il nostro punto di vista invece è accettare un confronto su dei testi che, siamo convinti, dicono qualcosa a tutti. La Scrittura può essere quel ponte su cui ci incontriamo grazie al suo valore narrativo. Io, da credente, farò vedere come essa aiuti la mia vita di credente. In quella parola c’è la Parola di Dio rivolta alla mia vita. Per il non credente è diverso. Da questo punto di vista penso che davvero il progetto svolga un servizio ecclesiale. Nel portarlo avanti siamo sereni, perché siamo consapevoli della forza della Scrittura. Non temiamo che possa essere “profanata”, anzi, in questo modo può trovare nuove vie che non avrebbe trovato se l’avessimo custodita troppo gelosamente».
È molto difficile dire quale sia la risposta dei lettori, don Carrega ipotizza che il pubblico di Scrittori di Scrittura sia composto prevalentemente da «curiosi»: «Nell’ottica della Chiesa in uscita, direi che è normale andare più verso chi è ai margini o fuori dalla Chiesa. Sono molte le persone curiose di sentire che cosa ha da dire la Chiesa, e che rimangono favorevolmente impressionate da questo atteggiamento di dare carta bianca agli scrittori senza condizionarli, da una Chiesa che non vuole dettare norme ma si mette in dialogo».
Favorire la diffusione culturale della Scrittura
Il fenomeno della riscrittura della Bibbia non nasce certamente con Scrittori di Scrittura: basterebbe prendere il catalogo di qualsiasi casa editrice per verificarlo, o semplicemente leggere la Bibbia stessa per accorgersi che numerosi brani sono riscritture di altri brani. «In generale mi sembra che il fenomeno della riscrittura sia esteso, soprattutto all’estero. In Italia si fa un po’ di fatica in più, secondo me perché non c’è una cultura della Scrittura. Un piccolo contributo in questo senso il nostro progetto lo dà: quando uno legge il libro di Gambarotta sul Saul, magari è spinto a leggere il testo originale nel Primo libro di Samuele».
Oltre alla funzione di invito alla lettura della Bibbia, però, il fenomeno della riscrittura ha, più profondamente, lo scopo di arricchire la lettura di fede della Parola. L’approccio narrativo alla Bibbia ha la sua specificità che lo affianca ad altri approcci come quello storico critico o teologico, quello psicologico o femminista. «Il metodo narrativo è un metodo tra molti, buono sia a livello tecnico per gli esegeti, che catechistico. Tra i suoi pregi vedo l’empatia suscitata nei lettori, utile per l’interiorizzazione della Parola. Questo infatti è un passo su cui, credo, tutti facciamo difficoltà: come arrivare a fare una lettura esistenziale della Bibbia? Come passare dal “cosa dice il brano” al “cosa mi dice il brano”? Scrittori di Scrittura, oltre a dirci quello che il brano ha suggerito allo scrittore, mostra che ognuno di noi può riscrivere il testo biblico applicandolo alla propria vita».
Luca Lorusso
Il progetto prevede altri futuri volumi. Intanto è consultabile il sito www.scrittoridiscrittura.it nel quale è possibile seguire un blog con riflessioni e approfondimenti sulle tecniche narrative dei Vangeli, sul rapporto che la Scrittura ha con arte, letteratura e cinema. Nel sito sono presenti anche i video delle presentazioni dei singoli volumi con gli autori.
Tre scrittori rispondono
Margherita Oggero
Come ha accolto la proposta di riscrivere un brano biblico?
Da non credente inquieta e riluttante, ho accolto con perplessità la proposta e ho spiegato le mie difficoltà nei confronti della fede. Mi è stato risposto che gradivano anche voci dissonanti e quindi ho accettato.
Perché ha scelto il personaggio di Isacco?
La figura di Isacco è in stretta relazione con quella di Gesù Cristo. È una vittima (mancata) delle imperscutabili scelte di Dio. Una figura tragica che vive un dramma più grande delle sue capacità di comprensione. Ho scelto di raccontare un uomo stanco sul limitare della morte, un uomo che non ha certezze granitiche, che è stato offeso dalla vita e tradito dai suoi cari, che chiede a Dio di concedergli la morte e che si rivolge a Lui con franchezza e coraggio, come i grandi personaggi del Vecchio Testamento.
Com’è la sua relazione con la Bibbia?
Amo molto la Bibbia, che è una delle mie letture ricorrenti. La amo perché è uno dei testi fondativi della nostra civiltà e perché è, letterariamente, uno dei più grandi.
Davide Longo
Come ha accolto la proposta di riscrivere un brano biblico?
L’ho accolta con curiosità e interesse, senza pregiudizi. Del resto, pur non essendo io credente, ho molte volte lavorato sui Vangeli per analizzae o spiegae, durante il mio lavoro di docente alla Scuola Holden, le strutture narrative.
Perché ha scelto il brano delle nozze di Cana?
Perché narrativamente è un momento potentissimo, dove l’autore lascia molti spazi bianchi che chiede al lettore di riempire. È una scena minimale, eppure cruciale. Assomiglia molto a certo cinema d’autore fatto di vuoti e silenzi.
Come ha scelto la sua modalità di riscrittura?
Ho stemperato la solennità e drammaticità del momento del primo miracolo pensando a un ribaltamento infantile. I miei ricordi di catechismo sono di una noia e di una retorica mostruosi. Ho sempre pensato che la Chiesa, potendo disporre di materiale narrativo così forte e riuscito, lo sprecasse nella maggior parte dei casi, proponendo ai ragazzi delle letture patetiche, smorte, incolore o di un moralismo avvilente, per nulla all’altezza dei ritmi e degli snodi narrativi della Bibbia o dei Vangeli. Così ho scritto per i bambini, divertendomi e per divertirli.
Com’è la sua relazione con la Bibbia?
Dal punto di vista delle tecniche stiamo parlando di materiali narrativi che sono all’origine del nostro modo di raccontare storie, di leggerle, di empatizzare con la parola scritta. È una miniera infinita, ogni scavo porta alla luce qualcosa di bello, che ci parla e ci spiega la nostra relazione con le storie.
Tiziano Fratus
Come ha accolto la proposta di riscrivere un brano biblico?
Inizialmente ero scettico, poi ho pensato che si trattava di una sfida come un’altra. Così ho ripreso in mano l’Antico Testamento e ho iniziato a rileggere alcuni profeti. Per anni ho lavorato ad un libro che partiva da Giona, e alla fine ho individuato la figura di Geremia.
Perché proprio Geremia?
Perché segue il suo Dio fino alle estreme conseguenze. Chi oggi abbraccia la poesia e la scrittura come scelta di vita compie una scelta molto complessa, che la nostra società non tende affatto a premiare. Quindi ero interessato a indagare le eventuali motivazioni che spingevano questo profeta a pagare fino in fondo per credere in una causa.
Come ha scelto la sua modalità di riscrittura?
Il frammento è parte della mia scrittura, sia in prosa sia in poesia. Ho inteso il racconto come una scelta di sette diverse rotazioni, o atti, dell’esistenza di questo personaggio, che è molto distante dalla fonte biblica anticotestamentaria. Non mi sono preoccupato di seguire una linea per così dire religiosa, ho soltanto cercato di dare ascolto al personaggio e di scrivere al mio meglio.
Com’è la sua relazione con la Bibbia?
In questi anni ho spesso navigato opere spirituali e religiose: i testi sacri indiani, i testi fondamentali del taoismo e di parte del buddismo, testi orfici, così come diari e opere di carattere metafisico e mistico. La rilettura di alcuni libri della Bibbia rientrava in questo percorso, il progetto di Effatà mi ha spinto a farlo entro certi tempi e per un motivo pratico che supera la mera conoscenza.
L.L.