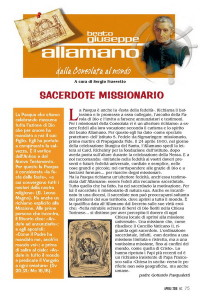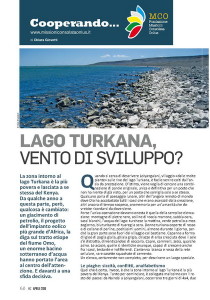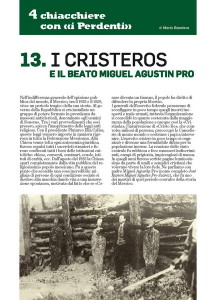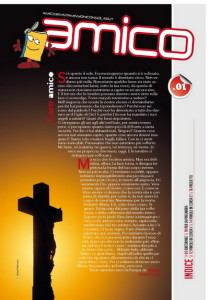Perdenti 14: Antonio Meucci
Alla fine la verità ha trionfato: l’inventore del telefono non è Alexander Graham Bell, come continuano a recitare i libri di testo nelle scuole degli Stati Uniti d’America, bensì l’immigrato fiorentino Antonio Meucci che morì in povertà a New York nel 1889 dopo essere stato defraudato del brevetto. Meucci nato a San Frediano, popolare quartiere di Firenze il 13 aprile 1808, emigrò giovanissimo nel Nuovo Mondo. Dopo alcuni anni passati a Cuba lavorando come tecnico di scena in una compagnia teatrale che si esibiva all’Avana, decise di trasferirsi negli Stati Uniti, anche per sfuggire il micidiale clima caldo-umido dell’isola caraibica che influiva negativamente sulla salute della moglie Ester.
Lasciata Cuba il 1º maggio 1850, i coniugi Meucci sbarcarono a New York, stabilendosi quasi subito a Clifton, un piccolo quartiere nell’isola di Staten Island, dove rimasero fino alla morte. Qui Antonio acquistò un cottage e aprì una fabbrica di candele, fatte secondo un progetto di sua concezione. La sua casa divenne ben presto un riferimento importante per gli immigrati italiani che arrivavano a New York. Anche Giuseppe Garibaldi venne ospitato da Meucci tra il 1850 e il 1853 e, per tutto il tempo della permanenza negli Stati Uniti, lavorò nella sua fabbrica.
La passione per le comunicazioni elettriche, che covava da sempre nella sua mente, gli fece trasformare ben presto la casa in un laboratorio: allestì un collegamento permanente con la stanza al secondo piano dove stava la moglie che soffriva di un’artrite deformante e per lunghe ore non poteva muoversi. Da quell’apparecchio costruito in maniera molto approssimativa, Meucci sognava di far giungere la sua voce il più lontano possibile. Era la sua idea fissa, quasi un’ossessione, che lo accompagnò per tutta la vita.
Il riconoscimento postumo e tardivo del suo genio, arriverà l’11 giugno 2002 quando il Congresso degli Stati Uniti, su iniziativa del deputato italoamericano Vito Fossella, ha riconosciuto Antonio Meucci come il primo inventore del telefono. Dopo la riabilitazione di Sacco e Vanzetti, i due anarchici ingiustamente condannati a morte per terrorismo negli anni ’20, questo è stato un altro trionfo per la generazione degli immigrati italiani che spesso furono vittime di pregiudizi e discriminazioni negli Stati Uniti d’America.
Caro Antonio, si può dire che nonostante le tue capacità e soprattutto la sorprendente genialità che avevi per la comunicazione, tu abbia avuto una vita tutt’altro che fortunata. Parlaci un po’ di te.
Cresciuto nel Gran Ducato di Toscana, dove le condizioni di vita della mia famiglia erano piuttosto grame e difficili, e coinvolto nei moti rivoluzionari del 1831 a causa delle mie convinzioni politiche e per le mie idee liberali, fui costretto ad andarmene dalla terra natia, per cui appena sposato presi la decisione di emigrare in America.
La tua prima tappa però non furono gli Stati Uniti d’America.
Infatti, dopo lunghe peregrinazioni nello Stato Pontificio e nel Regno delle due Sicilie, mi imbarcai per Cuba dove trovai lavoro come meccanico teatrale, fino ad essere responsabile di tutto l’impianto scenografico. Là ebbi la possibilità di approfondire le mie conoscenze in elettrotecnica e di fare esperimenti vari. Divenni anche uno dei primi a praticare la galvanostegia di oggetti (ricoprire cioè oggetti di metallo normale con oro o argento tramite un processo elettrico), è questo mi rese ricco e popolare. Fu proprio a Cuba che ebbi le prime intuizioni sulla possibilità di comunicare a distanza grazie all’elettricità.
Però non rimanesti a lungo nell’isola caraibica.
Nel 1850, scaduto il mio terzo contratto con il teatro all’Avana, su suggerimento di amici, mi trasferii negli Stati Uniti stabilendomi a New York dove aprii una fabbrica di candele steariche di mia concezione.
A New York in quegli anni incontrasti anche Giuseppe Garibaldi.
Proprio così. Fra me e Garibaldi sorse e si sviluppò una solida amicizia e lui per tutto il tempo che si fermò (1850-1853) negli Stati Uniti, fu ospite a casa mia e lavorò anche nella mia fabbrica. Purtroppo la fabbrica, pur unica nel suo genere, non ebbe molto successo. La trasformai prima in una fabbrica di birra e poi fui costretto a venderla, anche se il nuovo proprietario mi permise di viverci fino alla mia morte.
Fu in quel periodo che ti venne l’idea di un apparecchio che mettesse in comunicazione due persone che stavano in lontananza.
Avevo già fatto dei primi esperimenti in Cuba, ma il fatto che mia moglie fosse costretta a stare per lunghe ore della giornata a letto per colpa di una forma grave di artrite reumatornide, stimolò il mio ingegno. Allestii quindi un collegamento permanente tra il laboratorio, che era nello scantinato della casa, e la stanza di mia moglie situata al secondo piano.
Se eri un genio per quanto riguarda le comunicazioni, non avevi certamente talento per il lucro, né la sola simpatia della comunità italiana poteva fare molto per te.
Vero. Io continuai i miei esperimenti con il «telettrofono», come chiamavo la mia invenzione, e migliorai considerevolmente la comunicazione fra la mia adorata Ester, ormai paralizzata nella sua stanza, e il mio laboratorio. Negli anni tra il 1851 e il 1871 provai e riprovai fino a trenta modelli diversi e ottenni ottimi risultati. Il laboratorio era pieno di disegni e prototipi.
Poi ti dissanguasti economicamente, un po’ per pagare le cure sanitarie di tua moglie, un po’ per tanta sfortuna, e ti riducesti sul lastrico.
In fondo non desistevo, anche se mi riempivo di debiti, sognavo il giorno in cui non avrei più avuto problemi economici. Mi accorgevo sempre di più di essere un vecchio in miseria con la moglie ammalata e un’invenzione che, lo posso dire veramente, sarebbe stata al servizio dell’umanità, ma di cui, per colpa dei raggiri di cui ero vittima, non potevo godee i frutti.
Per colmo di sfortuna, il 30 luglio 1871, lo scoppio della caldaia del traghetto Westfield che mi stava riportando a casa a Staten Island da New York, causò l’incendio e l’affondamento dello stesso. Gravemente ustionato, finii in ospedale per mesi. Fu il tracollo finanziario. Per sopravvivere, mia moglie fu costretta a svendere i miei bozzetti e i prototipi di telettrofono per 6 dollari a un rigattiere. Una volta dimesso, ancora convalescente, provai a ricominciare da capo.
È vero che scrivesti anche in Italia alla ricerca di capitali per lanciare la tua invenzione sul mercato europeo?
Sì, ma non ottenni grandi risultati. Fondai anche una compagnia con altri italiani, ma non si venne a capo di nulla e si sciolse dopo un anno.
Tra tutte queste disgrazie non ci fu un momento in cui il vento della sfortuna modificò la sua direzione?
A fine dicembre 1871 riuscii a pagare i dieci dollari necessari per avere un caveat dall’ufficio brevetti a Washington. Il documento descriveva la mia invenzione, che avevo chiamato «Sound Telegraph». Purtroppo valeva solo un anno e non avevo i soldi necessari per il rinnovo né tanto meno per pagare il brevetto.
Ma accanto a queste vicissitudini, ce ne furono altre poco chiare e abbastanza disoneste che t’impedirono di accedere al brevetto.
Forte del caveat, nell’estate del 1872 andai a far vedere il mio prototipo e i miei progetti all’American District Telegraph Co. di New York, sperando mi lasciassero sperimentare il mio apparecchio sulle loro linee. La notizia venne anche pubblicata con un certo rilievo sul giornale italiano che in quegli anni si stampava a New York. Ma non abbi alcuna risposta dalla Company. Anzi continuarono a tergiversare, senza restituirmi i disegni. Alle mie insistenze, dopo ben due anni, mi dissero che li avevano smarriti. Consulente della compagnia era Alexander Graham Bell. Il che dice tutto.
Qualche anno dopo persi ogni speranza di un riconoscimento ufficiale da parte delle autorità degli Stati Uniti quando, dopo che il mio caveat era spirato nel 1874, nel 1876 lessi sui giornali di New York che Bell aveva «inventato» il telefono. Nel 1877 fondò la «Bell Telephone Co.».
Di fronte a questa defraudazione pura e semplice non ti difese nessuno?
La comunità italiana fece quadrato attorno a me e dopo un decennio di ricorsi ai tribunali, ci fu l’intervento del governo il quale decise di annullare temporaneamente il brevetto di Bell in quanto ottenuto per frode e dichiarazione del falso. Cosa che venne poi confermata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.
Allora aveva ragione Garibaldi, il quale diceva che tu eri un genio, ma nel fondo restavi un gran brav’uomo che in una società come quella capitalista americana eri come una colomba in una stanza piena di volpi!
Spiace dirlo, ma è proprio così. Quel volpone di Bell riprese i miei modelli, li mise in produzione, mentendo e truffando li fece passare per suoi e, avendo mezzi e appoggi di ogni genere, fece fortuna con il frutto della mie ricerche.
Per oltre un secolo, ad eccezione dell’Italia, è stato universalmente considerato inventore del telefono Alexander Graham Bell. Il fatto che il sistema legislativo degli Stati Uniti d’America abbia finalmente riconosciuto – sia pur con molto ritardo – che questa invenzione fosse da attribuire ad Antonio Meucci, è un postumo quanto doveroso risarcimento morale all’inventore fiorentino, che, gioverà ricordare, morì povero e dimenticato da tutti in una terra rimasta sempre straniera.
Don Mario Bandera – Missio Novara