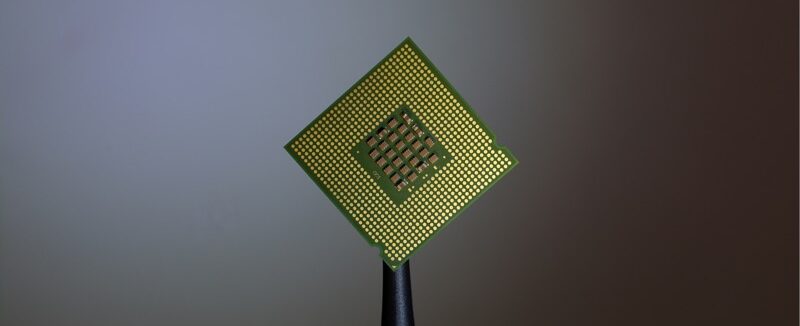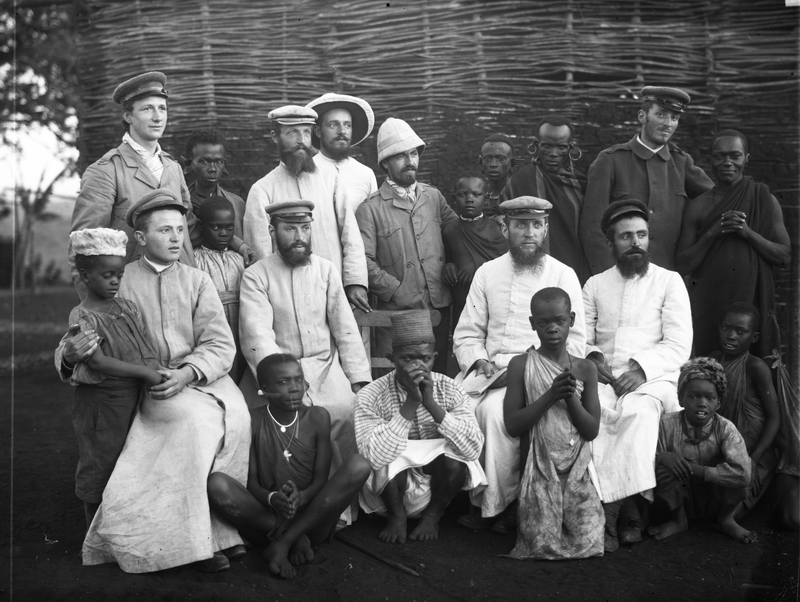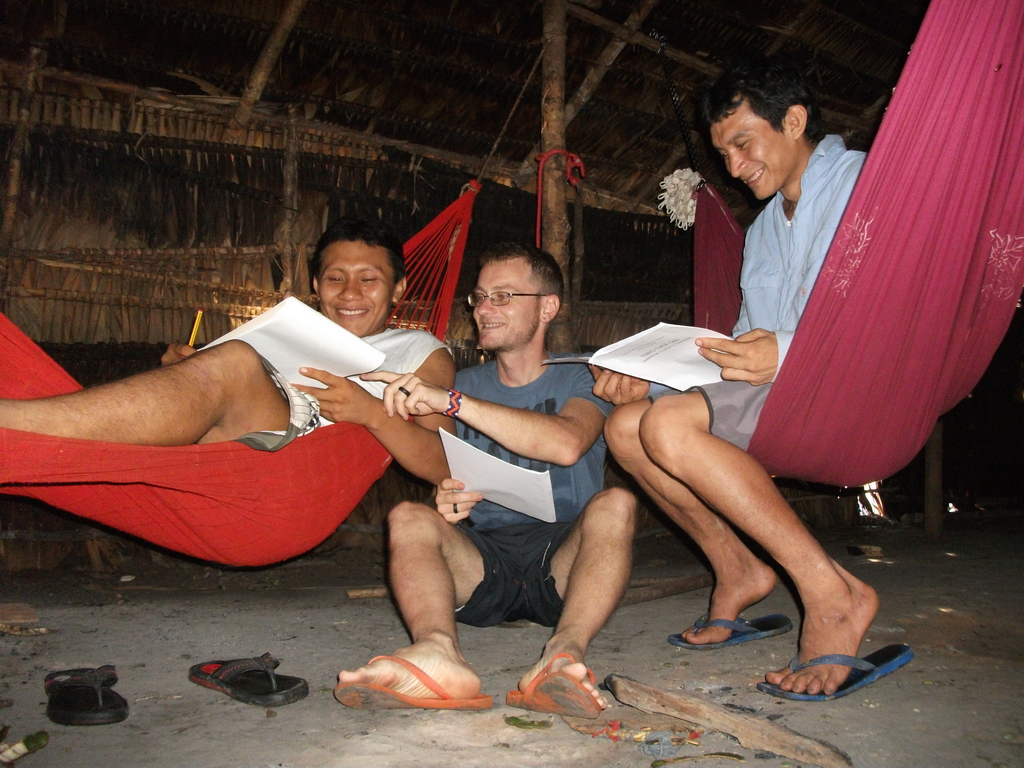Solo e in compagnia (Gv 6,1-59)
Con il sesto capitolo, il Vangelo di Giovanni ci stimola ad accelerare e approfondire il cammino. Lo fa innanzi tutto segnalando che ci troviamo a Pasqua (6,4), osservazione che può sembrare inutile se si dimentica che proprio a Pasqua dell’anno precedente Gesù aveva espresso il suo giudizio sul culto nel tempio (2,13-17) e che in quella dell’anno successivo morirà in croce.
Lo fa anche con un racconto, quello della moltiplicazione dei pani, che, a differenza dei Vangeli sinottici, qui fa da preludio a una riflessione sull’eucaristia che ci saremmo aspettati di trovare più avanti, ossia durante l’ultima cena (dove invece è assente).
Infine, l’evangelista inizia a parlare con insistenza del rapporto di Gesù con il Padre, e per la seconda volta nel suo percorso ricorre a un «Io sono» (6,20) su cui torneremo presto.
Si arriverà a un certo punto nel capitolo a esplicitare che nessuno ha visto Dio e solo Gesù lo può far conoscere (6,46), un tema che percorre sottotraccia tutto il Vangelo fin dall’inizio. Ciò che fa Gesù è ciò che farebbe il Padre. Guardare il Figlio, dunque, significa guardare anche chi lo ha mandato.
Diventa allora significativo il gioco di Gesù che un po’ si ritira in solitudine, un po’ si mostra ai suoi e alle folle.
Il capitolo 6 si apre con Gesù che si ritira con gli apostoli sul monte (6,2-3) per evitare le folle che lo seguono per le sue guarigioni. Ma da lì le vede venire verso di lui, e non solo non le scaccia, ma si chiede come fare a dare loro da mangiare. A quel punto Gesù intuisce che la gente vuole «prenderlo per farlo re» (6,15), quindi si ritira sul monte da solo. Mentre lui è sul monte, i discepoli passano senza di lui dall’altra parte del lago, ma vengono colti da una tempesta. D’improvviso Gesù compare camminando sulle acque, e li porta a destinazione invitandoli a non avere paura (6,16-21).
Infine, Giovanni si avventura in una descrizione abbastanza contorta dello stupore della gente, che cerca Gesù faticando a trovarlo (6,22-25). Il fatto che la descrizione non sia lineare non è un errore dell’evangelista. Anzi, egli, proprio in questo modo attira lì la nostra attenzione, perché ci rendiamo conto ancora una volta che Gesù, che è cercato, potrebbe sottrarsi alla folla, e un po’ lo fa, ma si lascia anche trovare, per commozione e perché vede che gli altri hanno bisogno di lui.
Il volto del Padre
Abbiamo già detto che l’«Io sono» è uno degli elementi che ci suggeriscono un «cambio di marcia» di Giovanni. Il momento è quello in cui Gesù, camminando sulle acque, compare ai discepoli che stanno faticando a gestire la barca nel mare in tempesta. Loro, come è comprensibile, al vederlo si spaventano, ma Gesù li rassicura dicendo «Io sono» (6,20). Si tratta di una formula che potrebbe essere banale, il nostro «sono io», ma già nel Primo Testamento sono parole che richiamano la rivelazione del nome divino a Mosè: «Dirai agli israeliti: “Io sono mi ha mandato a voi”» (Es 3,14). Nel Vangelo di Giovanni la formula diventa solenne. Gesù, infatti, dice molte volte «io sono»: il pane di vita (nel capitolo 6), la luce del mondo (8,12), la porta delle pecore (10,7.9), il buon pastore (10,11.14), la risurrezione e la vita (11,25), la vera vite (15,1.5). Addirittura, in alcuni casi non aggiunge nulla, ma si limita a dire «Io sono» (8,24.28.58; 13,19), che sicuramente ha un tono solenne e divino.
Già una volta Gesù nel Vangelo aveva usato questa formula, parlando con la samaritana (4,26), ma là poteva sembrare un uso più semplice e «banale»: la donna parla del messia, Gesù le svela «Sono io, che parlo con te». Nell’episodio di Gesù che cammina sulle acque in tempesta, invece, le stesse cominciano a sembrare qualcosa d’altro, anche perché sono dette da chi sta compiendo un’impresa sovrumana.
In queste righe del Vangelo di Giovanni, Gesù inizia ad alludere alla propria dignità divina, e nello stesso tempo continua a dichiararsi inferiore e in comunione con il Padre, del quale è la visibilità.
Quello che mostra in questo capitolo è allora il volto di un Padre che non avrebbe bisogno della compagnia degli umani, eppure sceglie di mettersi a disposizione, di lasciarsi trovare, sapendo che sono loro ad aver bisogno di lui. Il volto di un Dio che è padrone degli elementi (moltiplica i pani, calma la tempesta facendo arrivare subito a riva), ma non si sostituisce alla libertà e alla fatica degli esseri umani: sfama cinquemila persone, ma a partire non dal nulla, bensì da cinque pani d’orzo e due pesciolini (pasto scarno anche per chi lo aveva portato, ma che intanto deve essere messo a disposizione, deve essere perduto per essere ritrovato), e fa giungere a riva marinai che però intanto avevano provato a remare. Un Dio al servizio degli uomini, ma senza sostituirsi a loro.
Quello che Gesù mostra è un Dio che non usa mai gli elementi di cui è Signore per arrecare un danno, ma sempre e soltanto per il bene.
Un Padre che, come Gesù, sarebbe autosufficiente, ma sceglie di non stare da solo. E un Padre che interviene poco, per salvaguardare la libertà degli umani, ma quando lo fa interviene solo salvando, sfamando, mai punendo.
![]()
Che cosa dobbiamo fare? (Gv 6,26-35)
Negli Atti degli Apostoli la reazione al primo discorso di Pietro in cui si racconta la vicenda di Gesù è «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» (At 2,37). Al versetto 28 del capitolo 6 di Giovanni, anche la folla che cerca Gesù sull’altra riva del lago e lo trova, gli domanda: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». È comprensibile, umano e anche ammirevole: di fronte alla scoperta di una interpretazione diversa della nostra vita, chiedersi in che cosa cambiare è generoso e onesto. Gli interlocutori di Gesù, insomma, non sono né superficiali né ipocriti. Ma la risposta di Gesù spiazza, sulla linea di ciò che aveva lasciato intuire nel dialogo con la donna di Samaria (Gv 4,23-24): «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato» (6,29).
A essere significativi e sorprendenti sono almeno due aspetti. Il primo è che il «da fare» non sia qualcosa che deve essere fatto. Se è vero che le parole senza azioni sono vuote, è però ancora più vero che a essere significative nelle relazioni umane sono le intenzioni: il bambino che vuole aiutare la mamma provando a farle trovare al rientro a casa una pietanza che però è immangiabile non verrà rimproverato, ma probabilmente la farà commuovere. E orientando il rapporto con Dio non nel fare, ma nel credere (pisteuete), nell’affidarsi, nel confidare (questo è il senso profondo di un verbo che resta un po’ ambiguo), Gesù riorienta il rapporto degli esseri umani con Dio sull’unica cosa che conta, ossia la relazione. Vuoi fare l’opera di Dio? Fidati di lui, affidati a lui, vivi in una relazione di amicizia, di affetto, dove a essere decisivo non è ciò che fai, ma l’intenzione con cui vivi. Questo sembra essere per Gesù il cuore della morale religiosa: vivere una relazione autentica, profonda, di affetto con Dio. Quello che si fa, di conseguenza, è frutto di questa relazione.
Ma c’è anche un altro aspetto decisivo, perché in realtà Gesù non invita a credere in Dio, ma «in colui che egli ha mandato», ossia in Gesù stesso. In modo chiaro si afferma ciò che era già stato intuito prima e che ora diventa più esplicito: il Dio invisibile si può vedere e incontrare in Gesù.
Di fronte alla comprensibile perplessità degli interlocutori («Che segno compi perché ti crediamo?»), Gesù, alludendo alla manna del deserto, donata ogni giorno da Dio al suo popolo nel tempo dell’Esodo, parla del pane. Non solo i pani moltiplicati, ma un cibo che possa nutrire. Gesù, cioè, non si limita a dire: «Guarda che miracoli faccio, guarda come sono potente!», ma invita a cogliere che quello che lui fa è al servizio della vita di chi incontra, è destinato a nutrire, a sfamare. Gesù mostra un Padre che non vuole essere adorato e riverito, ma che si dona perché i suoi amici non patiscano fame o sete. Colui che può sfamare e dissetare, sulla linea dell’incontro con la donna samaritana, è Gesù. Poi, dalla dimensione fisica siamo invitati a passare a quella esistenziale, perché non viviamo soltanto di pane, ma di relazioni e senso della vita che sono ciò di cui abbiamo più bisogno.
Non si tratta di qualcosa a cui Gesù arrivi marginalmente o di recupero: «La volontà del Padre mio è che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna» (6,40).
Si parla della risurrezione nell’ultimo giorno, ma se ne parla al presente. Perché Gesù e il Padre vogliono la vita degli esseri umani, e questo desiderio non distinguerà tra il futuro e l’adesso.
Il cristiano non faticherà a capire che qui in fondo si parla dell’eucaristia, ma, persino più che nei sinottici, è chiaro che non la si potrà più intendere semplicemente come rito, bensì come gesto che rimanda a tutta l’esistenza di Dio: l’eucaristia raccoglie in un punto ciò che il Padre e Gesù fanno sempre, donare la vita per far vivere gli esseri viventi.
Figlio di Giuseppe o del Padre? (Gv 6,36-59)
Quello che Gesù afferma è pesante, intenso. Svela un volto di Dio che forse fatichiamo a immaginre: talora abbiamo la tentazione di pensare a un Dio giudice severo che castiga in modo durissimo chi si comporta male (cioè, gli altri). Invece, qui Giovanni ci mostra un Dio amante della vita e pronto a donarsi per nutrire l’umanità. Ma svela anche un Gesù che pretende di far conoscere il Padre, che si pone come tramite indispensabile: «Il pane della vita sono io!» (6,35).
Anche noi avremmo probabilmente reagito come gli interlocutori: «Costui non è Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre?» (6,42). C’è un primo livello di contestazione che capiamo immediatamente: «Chi ti credi di essere? Sappiamo chi sei!». Ma questo tradisce un sottinteso più profondo: ci aspettiamo che Dio sia completamente diverso dall’uomo, non abbia rapporti con la nostra quotidianità. È un pensiero che percorre gran parte dell’umanità, non solo cristiana: vedendosi limitati e imperfetti, gli uomini pensano che Dio sia completamente diverso da loro. Ecco perché ci sembra convincente che Dio non si capisca, parli lingue strane, si nasconda misteriosamente in riti incomprensibili, dietro a muri o fumi di incenso. Quello che Gesù ha suggerito, che il Padre sia visibile in lui, e che Dio sia interessato a fare vivere e nutrire l’umanità, invece, contraddice questa lontananza e divisione.
Gesù mostra un divino che poteva anche rimanere lontano dall’umano, ma che ha voluto abbattere le distanze, è entrato nell’umanità fino in fondo, si occupa degli esseri umani non per farsi servire e riverire ed è pronto a farsi cibo e bevanda, per farli vivere, di bene (6,55-56).
Questo è possibile a Gesù perché a tale scopo è stato inviato dal Padre, di cui è immagine (6,57). Gesù è così perché è il Padre a essere così, pronto a donare se stesso perché gli esseri umani abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza. Non a caso Gesù può dire che chi si nutre di questo cibo, vivrà in eterno (6,58).
Angelo Fracchia
(Il volto del Padre 07- continua)