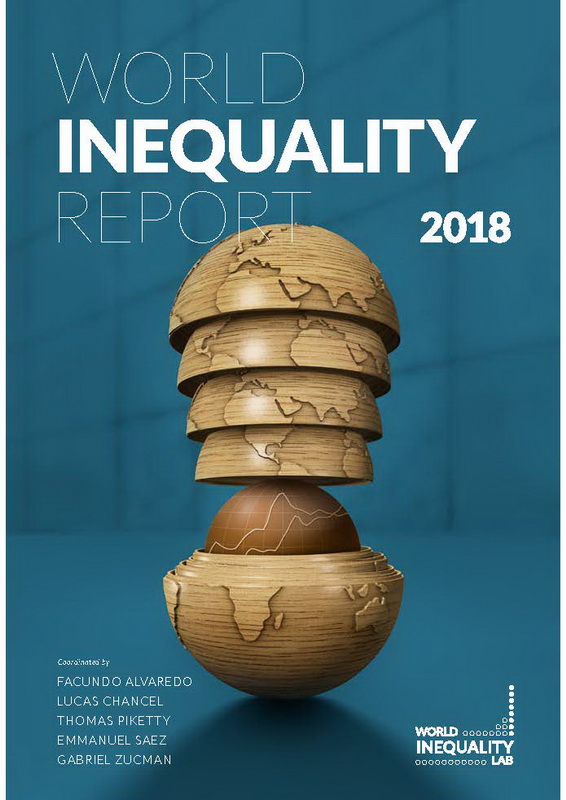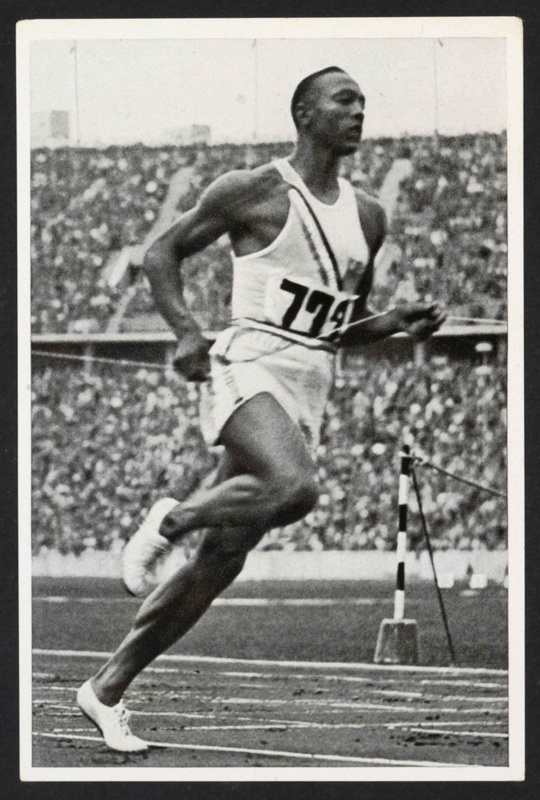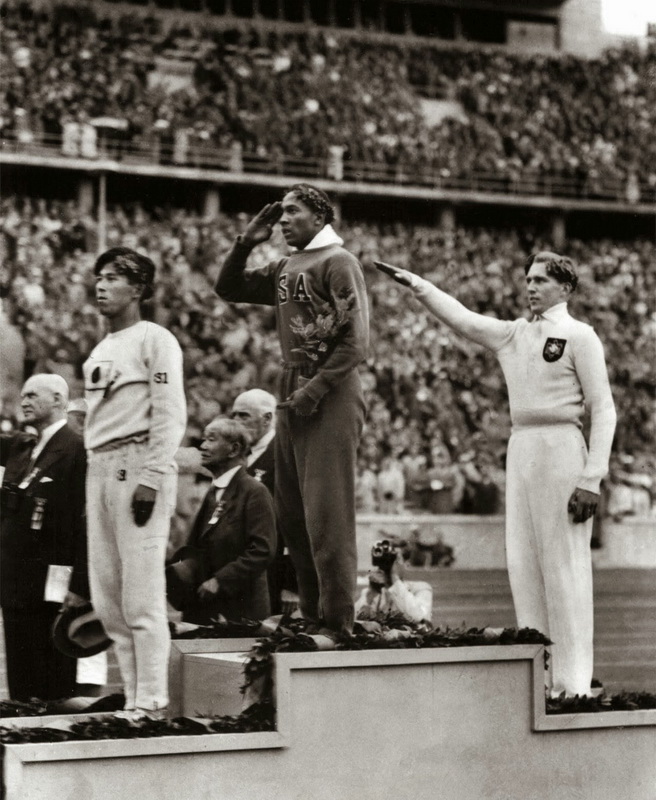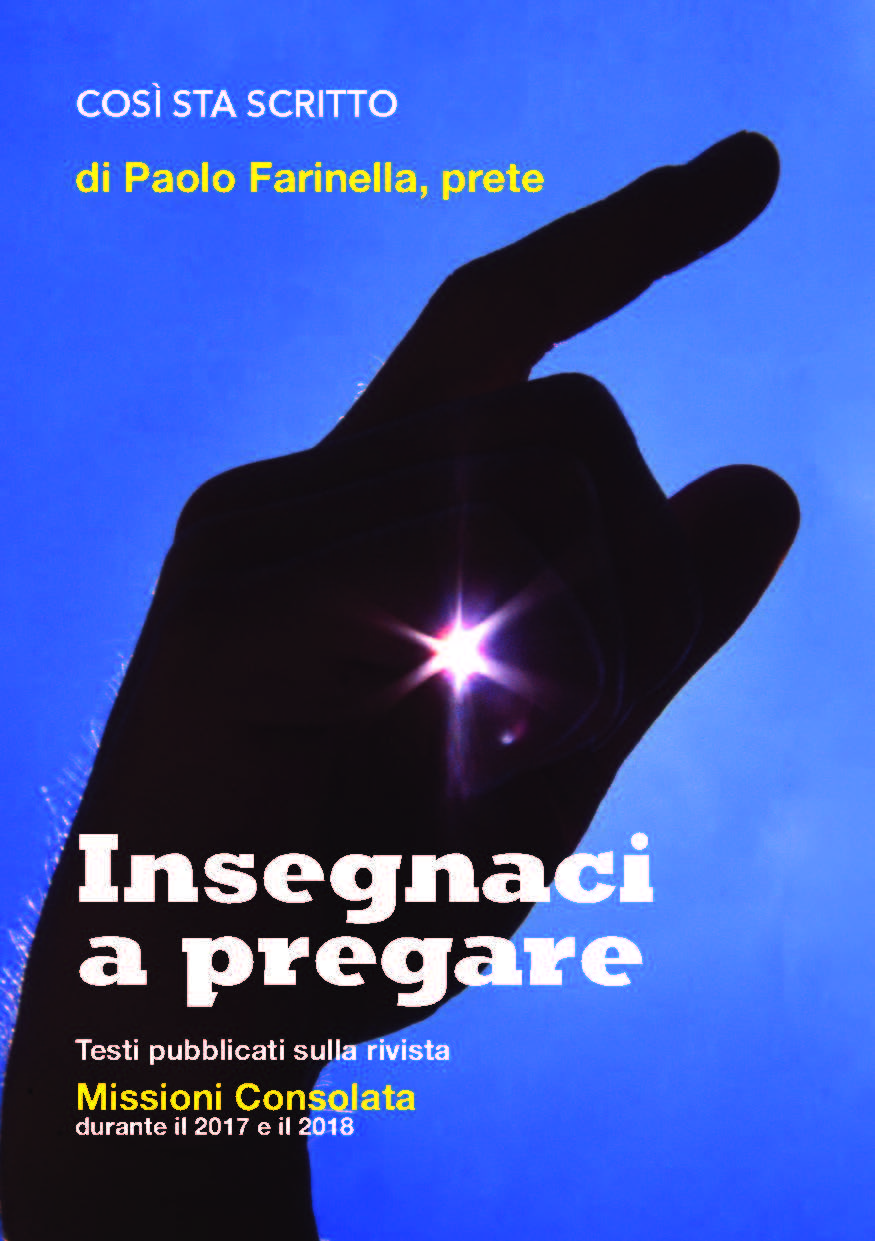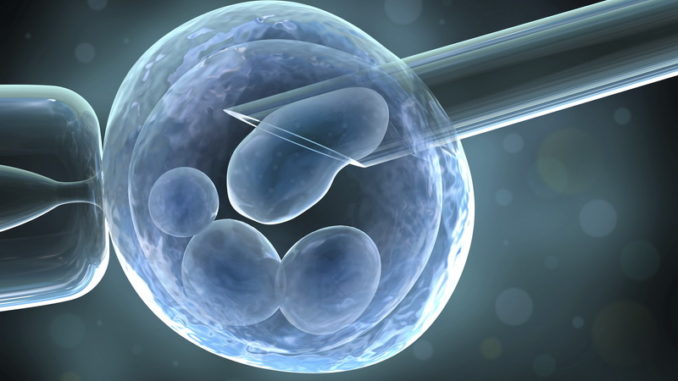Atti degli Apostoli:
il nostro libro
Tempo di novità
Spesso si dice che viviamo in tempi di trasformazione, di cambiamento.
Probabilmente non esiste nessun tempo che non sia di cambiamento, ma è vero che
certi passaggi storici sembrano stravolgere tutto ciò che trovano, e il nostro
è uno di quelli. È comprensibile lo sconcerto dei credenti in Cristo che si
chiedono come continuare a nutrirsi della fede quando tanto sembra contestarla
e spingerla a rinnovarsi. La paura del cambiamento, ovviamente, è quella di
perdere qualcosa di fondamentale. Nello stesso tempo è certo che, restando come
ci si era abituati a essere, si rischia di morire, ossia che il rapporto con
Gesù diventi insignificante innanzitutto per noi, il che sarebbe una grave
perdita per la nostra vita.
Come fare a mantenere equilibrio tra conservazione dell’essenziale e
rinnovamento vitale?
Può confortare che il primo libro nel quale si parla della Chiesa, gli
Atti degli Apostoli, sia situato su uno sfondo simile al nostro. Anche nel I
secolo d.C., infatti, c’era un «grande mondo» che affascinava perché ricco,
luccicante, abbagliante: il potere politico romano, con i suoi commerci e la
facilità dei viaggi, che grazie alla cultura greca metteva a disposizione una
lingua con cui farsi capire ovunque (come oggi l’inglese) e un modello
culturale attento all’essere umano, alla sua intelligenza, alla sua autonomia,
al suo farsi da solo con la forza del cervello e della propria forma fisica. Il
divino sembrava più formale e trascurabile. Accanto, c’era un «mondo antico»
ebraico fatto di regole minuziose che però rimandavano a una saggezza
interiore, di fedeltà al rapporto con un Dio unico, senza statue né quadri, un
mondo che in fondo affascinava gli stessi romani. Gesù non era quasi mai uscito
da questo mondo ebraico, ma i cristiani si troveranno presto sfidati a
entrarvi: come farlo senza perdere la propria anima?
In queste pagine, cercheremo di percorrere il libro degli Atti tenendo
sempre sullo sfondo la nostra situazione e la nostra vita, per provare a
cogliere che cosa quella vicenda di duemila anni fa insegna a noi. Proveremo a
lasciarci guidare dall’ordine del libro biblico, senza essere noi a imporgli
temi o questioni: sia lui a portarci dove ritiene opportuno.
La copertina
Un libro non si dovrebbe giudicare dalla sua copertina, anche se già
questa ci dice qualcosa sul suo contenuto: non solo il titolo o l’immagine sul
frontespizio, ma anche quanto è spesso, quanto è scritto fitto, quante immagini
ha al suo interno, sono elementi che già ci fanno capire se il libro potrà
interessarci o no.
Gli Atti degli Apostoli sono la seconda parte di un’opera che
comprende il Vangelo secondo Luca: questo vuol dire che l’autore pensava al
Vangelo, che pure è autonomo, come un testo in qualche modo da completare con
gli Atti, i quali a loro volta sono autonomi ma non possono essere capiti
appieno senza il Vangelo. Anche se negli Atti non si cita esplicitamente il
Vangelo di Luca, la vicenda di Gesù resta assolutamente il contesto nel quale
comprenderli: pur avendo la vita della Chiesa delle logiche e dei tempi suoi, è
Gesù a renderla sensata.
Nel leggere in greco gli Atti, si resta colpiti dalla trasformazione
della lingua che avviene nel corso dei capitoli: i primi sembrano essere
redatti da qualcuno che, pur scrivendo in greco, continua a pensare con una
testa ebraica (come succede a chi vuole scrivere un bell’inglese pur
continuando a pensare in italiano). Qualcosa del genere succedeva in effetti
anche nel Vangelo, benché nei primi due capitoli di Atti questo avvenga in modo
più marcato. Poi, poco per volta, nel corso della narrazione, la lingua si
purifica, si fa più elegante, più «greca». Dalla metà circa del libro in poi,
siamo davanti a un discorso puro, sciolto, affascinante. È come se anche il
modo di scrivere progressivamente si facesse più internazionale. Non a caso i
primi capitoli si svolgono tutti a Gerusalemme, ma poi un po’ per volta la
geografia si allarga, e nelle ultime righe la storia si sviluppa a Roma, la
grande capitale, il centro del mondo.
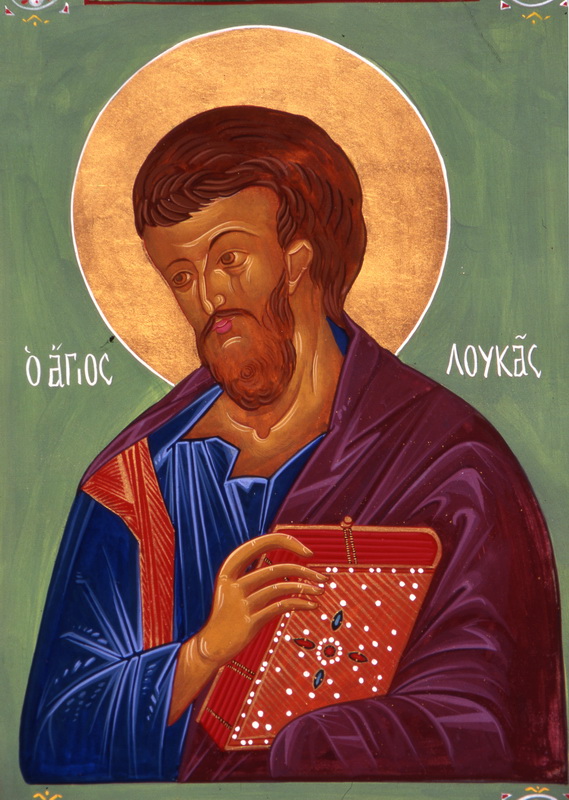
L’introduzione (At 1,1-2)
Luca è uno storico che conosce bene il suo mestiere. Gli storici del
nostro tempo dimostrano di fare un buon lavoro quando usano bene le fonti,
fanno vedere di aver consultato gli archivi e danno prova di aver letto le
opere degli altri storici. Al tempo di Luca, un bravo storico mostrava di
essere tale innanzitutto con due strumenti: i discorsi, che non dovevano
necessariamente essere fedeli parola per parola a come erano stati pronunciati,
ma che servivano a spiegare il senso del momento raccontato, a chiarire che
cosa c’era in ballo, e poi l’introduzione, dove lo storico faceva sfoggio della
propria lingua. Il sottinteso era che chi scriveva bene doveva aver studiato
tanto, e quindi essere anche capace di applicare lo studio nella ricerca e
nell’interpretazione dei fatti. E Luca mostra eccome di saper scrivere.
In pochissime parole, nei primi due versetti, dice tantissimo. Intanto
indirizza la sua opera a Teofilo. Chi sia questa persona, non lo sappiamo.
Anzi, potrebbe non essere una persona reale, dal momento che il nome significa
«amico di Dio»: può darsi che Luca intenda dire che qualunque amico di Dio è il
destinatario del suo lavoro. Era indirizzato alla stessa persona anche il
Vangelo (basta guardare Lc 1,3). Per rendere chiaro, fin dall’inizio, che i due
libri vanno letti insieme.
Luca dice poi che nel Vangelo ha
esposto quello che Gesù «iniziò a fare ed insegnare»: con queste parole vuole
dirci che la vicenda storica di Gesù non è finita con la sua ascensione. Il
Signore si identifica con la sua Chiesa, come farà intuire anche a Saulo di
Tarso quando lo incontrerà sulla strada di Damasco: «Io sono Gesù, che tu
perseguiti» (At 9,5), gli dirà, anche se, a essere pignoli, Saulo era convinto
di perseguitare non Gesù ma i cristiani. Nel prologo degli Atti, quindi, Luca
dice che quello che Gesù ha fatto nella sua vita non è finito, ma prosegue
nell’opera dei cristiani. E come Gesù non ha soltanto insegnato, ma ha agito,
così anche il cristianesimo non è questione di conoscenza sola, né solo di
azione, ma di agire consapevole, di intuizione che si fa vita vissuta.
Quindi Luca fa notare che l’opera di Gesù nel mondo è finita (ascende
al cielo) ma non per caso o incidente: egli dà disposizioni ai suoi, organizza
la sua partenza, e infine non è più fisicamente presente ma solo dopo aver
lasciato lo Spirito. Insomma, Gesù continua a esserci ma in una modalità nuova,
che aumenta la responsabilità dei suoi discepoli.
Gesù in cielo (At 1,3-11)
Gesù risorto non resta nel mondo. Lo sappiamo. Anche perché Luca lo
aveva già detto alla fine del Vangelo (Lc 24,51). Là, però, sembra che tutto
sia successo in un giorno solo, qui si parla di un tempo di quaranta giorni tra
la risurrezione e l’ascensione al cielo. Possibile che Luca si sia contraddetto
da solo? A partire da ciò che abbiamo già intuito sulla sua precisione, è
improbabile. Piuttosto, la contraddizione è uno dei trucchi degli scrittori,
soprattutto nell’antichità, per suggerire al lettore quali sono gli aspetti più
importanti cui fare attenzione. Se nel Vangelo ci dice che Gesù è asceso dopo
un giorno e poi, negli Atti, dopo quaranta, significa che la durata non è
importante. E che quindi il dato temporale vuole indicare altro, è un dato
simbolico. Gesù nel Vangelo ascende al cielo il giorno della risurrezione
perché il suo essere il Vivente e il suo essere alla destra del Padre
coincidono. Gesù negli Atti ascende al cielo quaranta giorni dopo la
resurrezione, perché comunque c’è un distacco tra i due elementi, la
risurrezione di Gesù non è soltanto un modo per dire che in qualche modo lui
vive ancora, spiritualmente o nel ricordo: no, lui è davvero il Vivente,
davvero il suo corpo ha lasciato il sepolcro. Ma non è più fisicamente tra noi.
La tentazione di aggrapparci alla nostalgia è umana e Dio la capisce
bene, infatti due angeli, dice Luca in At 1,10, arrivano a scuotere i
discepoli: «Perché state a guardare il cielo?». Andate, agite. Gesù tornerà, ma
adesso non è qui; c’è lo Spirito Santo che vi accompagnerà, ma dovrete metterci
del vostro.
Di nuovo in dodici (At 1,15-26)
Cosa fanno i discepoli appena rispediti nel mondo? Può stupirci, ma
iniziano prima di tutto a recuperare le proprie radici. Innanzitutto, si
trovano nel cenacolo, ossia là dove avevano celebrato l’ultima cena con Gesù.
Con loro ci sono la madre e i fratelli di lui (At 1,13-14): è chiaro che tutto
rimanda a colui che sembra assente. E poi ricostituiscono il numero dei dodici.
Dodici rimandava al numero dei patriarchi, alle dodici tribù d’Israele. Giuda
non c’è più, ma il numero non va perso. È un rimando importante alla storia che
c’è alle loro spalle, a quello che noi chiamiamo tempo dell’Antico Testamento.
Tutto è nuovo, ma non dimentica le proprie radici.
È poi curioso come procedano a scegliere il dodicesimo: selezionano
chi è stato testimone della vicenda di Gesù (At 1,21-22), e ne trovano due. Uno
dei due ha una bella presentazione, più ampia («Giuseppe, detto Barsabba,
soprannominato Giusto»), l’altro ha solo il nome, Mattia. Tra questi si tira a
sorte. Era il modo con cui in Israele si affidava la scelta a Dio. Ancora una
volta si ricorre a modalità «antiche», tradizionali, che stanno alle spalle,
per impostare il nuovo che va costruito. E Dio, stranamente (ma come ha già
fatto tante volte nell’Antico Testamento), sceglie colui che potevamo ritenere
svantaggiato. Fin dall’inizio, si tratta di collaborare noi con Dio per
costruire il nuovo che abbiamo davanti senza dimenticare ciò da cui veniamo.
Angelo Fracchia
(1 – continua)

Iniziamo in queste pagine la collaborazione con Angelo Fracchia che ci accompagnerà alla scoperta del libro degli Atti degli Apostoli, il libro della missione.
Ecco come lui stesso si presenta:

«Ci vuole coraggio per subentrare a un maestro come don Paolo Farinella nel tentativo di far conoscere e affascinare ai testi biblici. Coraggio, o incoscienza. Più probabilmente la seconda. Forse la stessa incoscienza che si mette in campo nel far crescere un figlio, avventura per la quale, a pensarci, non possiamo che dirci incapaci (nel mio caso, poi, quell’incoscienza si è ripetuta quattro volte). O l’incoscienza che ci vuole nel pronunciare un per sempre, quale che esso sia. Potrebbe essere l’incoscienza di chi ama. Che quindi si apre semplicemente in un grazie, nel mio caso a don Paolo, a padre Gigi che – incosciente anche lui – mi ha chiamato a questa bella avventura. Che lo Spirito mi aiuti a dire di lui cose rette, come Giobbe (Gb 42,7), rimproverato per la sua incoscienza ma lodato per come di Dio si era fidato, anche quando se ne lamentava».
Chi è Angelo Fracchia?
Padre di quattro figli, amante della musica, ha studiato all’Istituto biblico di Roma e collaborato come traduttore con l’editrice Paideia. Guadagna il pane quotidiano per sé e la sua numerosa famiglia facendo l’insegnante di religione in due scuole superiori a Saluzzo e Dronero nella provincia di Cuneo. Ma la sua vera passione e missione è far conoscere e amare la Parola di Dio.
Perché gli Atti degli Apostoli?
Uno degli inviti pressanti di papa Francesco a tutta la Chiesa è quello di essere «una Chiesa in uscita». Il libro degli Atti, continuazione del cammino di Gesù nella storia dell’umanità attraverso la sua Chiesa, non è certo un semplice libro di storia, ma è piuttosto una fonte di ispirazione, un paradigma di vita. Il mandato degli Apostoli diventa allora il nostro mandato. Il loro stile di dare la bella testimonianza di Gesù è ispirazione e modello per noi. Non per ripetere quello che gli apostoli hanno fatto, ma per acquisire il loro stesso spirito e imparare e riconoscere l’azione dello Spirito nel nostro oggi.