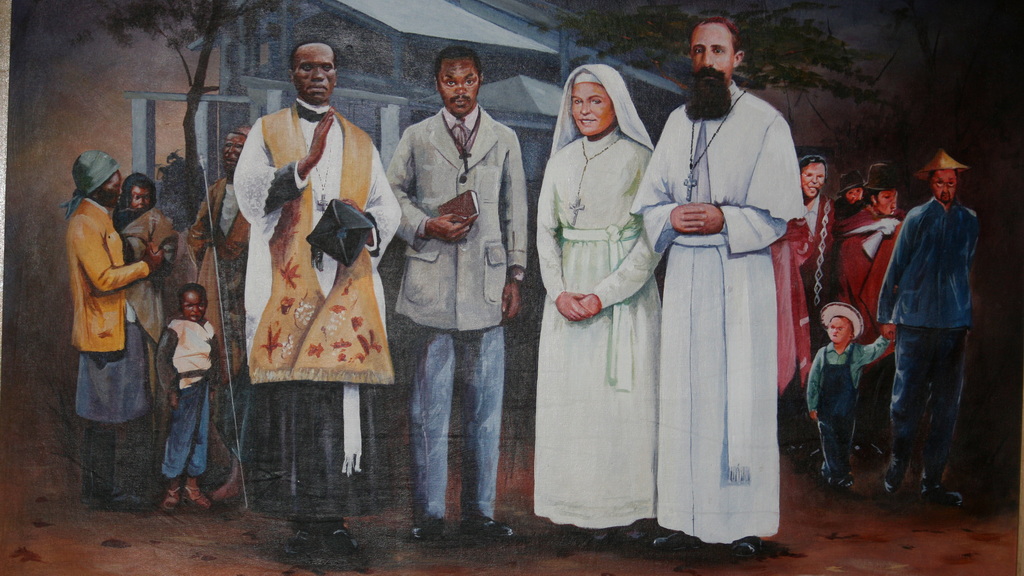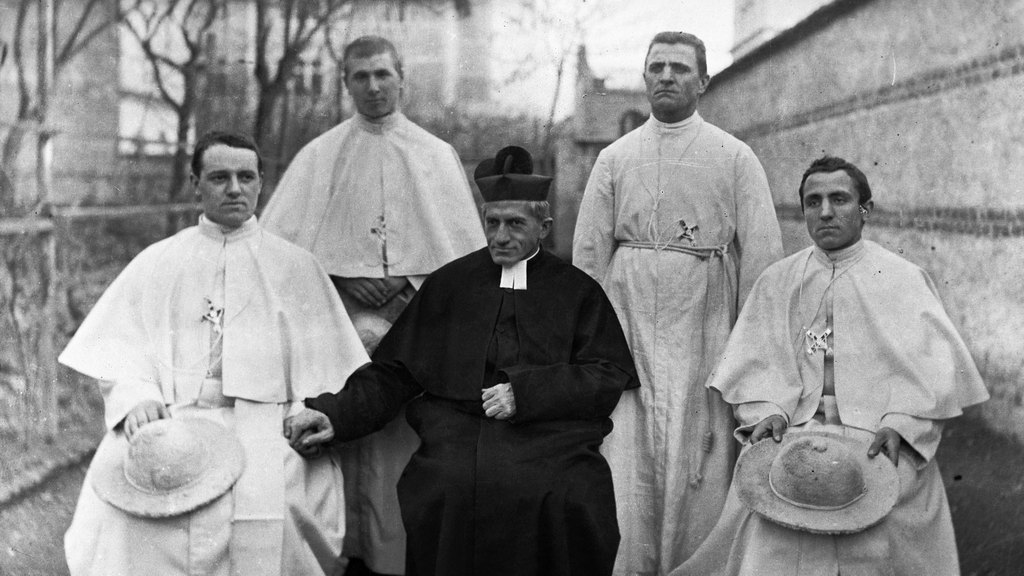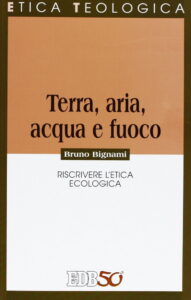Angelelli e Gerardi
Il tempo delle giunte militari in America Latina ha visto fiorire molte esperienze di lotta nonviolenta per la giustizia. Tra queste, quelle del vescovo argentino Enrique Angelelli (1923-1976) e del vescovo guatemalteco Juan Gerardi (1922-1998), entrambi per una Chiesa dei poveri. Entrambi ammazzati dai regimi.
Anselmo Palini, insegnante e saggista di San Giovanni di Polaveno, Brescia, attivo sui temi dei diritti umani e della nonviolenza, ha pubblicato diverse biografie, quasi tutte per l’editore Ave, di testimoni del nostro tempo impegnati per la giustizia e la pace.
Tra questi, ci sono, oltre ai più noti Oscar Romero e Hélder Câmara, altri due vescovi latinoamericani, assassinati dalle giunte militari dei loro Paesi perché testimoni scomodi del Vangelo.
Sono l’argentino Enrique Angelelli (1923-1976) e il guatemalteco Juan Gerardi (1922-1998).
Enrique Angelelli
![]() Enrique Ángel Angelelli Carletti, rettore del seminario di Cordoba, Argentina, e assistente della Joc (gioventù operaia cristiana) e della Juc (gioventù universitaria cristiana), diventa vescovo ausiliario della diocesi nel 1960 schierandosi subito a fianco di campesinos (contadini) e operai.
Enrique Ángel Angelelli Carletti, rettore del seminario di Cordoba, Argentina, e assistente della Joc (gioventù operaia cristiana) e della Juc (gioventù universitaria cristiana), diventa vescovo ausiliario della diocesi nel 1960 schierandosi subito a fianco di campesinos (contadini) e operai.
Durante il Concilio Vaticano II, che lo segna profondamente, è uno dei firmatari del «Patto delle
Catacombe» (16/11/’65), nel quale «i vescovi si impegnano a vivere in povertà, rinunciare ai simboli del potere, mettere i poveri al centro del loro ministero pastorale, operare per la giustizia e per un nuovo ordine sociale».
Nel 1968, la seconda Conferenza dell’episcopato latinoamericano a Medellin, in Colombia, conferma questa direzione di impegno e, quando viene nominato vescovo di La Rioja, celebra la messa nel barrio Cordoba Sud, uno dei più poveri della città.
A causa delle sue denunce, le autorità proibiscono la trasmissione per radio della messa. Viene allora diffuso un documento nel quale si afferma: «È possibile far tacere una trasmissione radiofonica, ma non la Chiesa, perché la forza e la ragione stessa della sua esistenza sono radicati nella presenza misteriosa dello Spirito di Cristo, che è vivo in ciascun uomo di questa terra, bagnata dal sangue dei suoi figli, versato per difendere la propria dignità».
Nel 1973, durante la festa in onore di Sant’Antonio, nella parrocchia di Anillaco, Angelelli viene aggredito a sassate da sicari dei latifondisti. Il papa Paolo VI gli fa sentire il suo sostegno attraverso una visita del superiore dei Gesuiti, Pedro Arrupe, e di Jorge Mario Bergoglio.
Già prima dell’avvento della giunta militare, gli squadroni della morte della Tripla A (la neofascista Alleanza anticomunista argentina) uccidono preti e laici impegnati, finché, nel 1976, il golpe militare instaura la dittatura che durerà fino al 1983.
Dopo l’ennesimo assassinio di due preti, padre Gabriel Josè Rogelio Longueville e fratel Carlos de Dios Murias, nell’orazione funebre Angelelli invoca: «Mi rivolgo a coloro che hanno preparato, organizzato ed eseguito l’assassinio dei due sacerdoti: aprite gli occhi, fratelli, se vi chiamate cristiani! Rendetevi conto del sacrilegio e del crimine che avete commesso».
Nei giorni successivi raccoglie dai parrocchiani testimonianze e prove di quanto accaduto e prepara un rapporto da trasmettere alla Conferenza episcopale, per evitare che tutto sia insabbiato.
Il 4 agosto 1976, mentre ritorna a La Rioja accompagnato dal vicario episcopale, Arturo Pinto, la sua auto è affiancata da un’altra che la spinge fuori strada facendola ribaltare.
Nonostante i tentativi di farlo passare per un incidente stradale, la verità del crimine non potrà essere nascosta a lungo.
Dopo l’assassinio del vescovo Angelelli, la repressione in Argentina continua. Migliaia di persone sono arrestate e scompaiono, sono rinchiuse nelle caserme, torturate, gettate in mare con i voli della morte. I familiari non riescono ad avere notizie.
Il 30 aprile 1977 un gruppo di quattordici donne, le Madres de Plaza de Mayo, si presentano davanti alla Casa Rosada, il palazzo del Governo, in silenzio e con le foto di figli, mariti, fratelli scomparsi, per avere notizie.
Tutte le settimane, per anni, queste donne saranno lì, con la loro muta presenza, a denunciare l’orrore della dittatura, inaugurando una protesta nonviolenta che risuonerà in tutto il mondo.
Un colpo per la giunta golpista sarà il riconoscimento del Premio Nobel per la pace nel 1980 all’attivista nonviolento cattolico Adolfo Perez Esquivel, che è imprigionato per quattordici mesi e liberato nel 1978.
Dopo la fine della dittatura, nel 1985, il rapporto Nunca Mas, che ricorda anche l’assassinio del vescovo Angelelli, consentirà di avviare i processi contro i militari accusati di gravi violazioni dei diritti umani e porterà alla condanna all’ergastolo dei generali Videla, Massera e altri.
Il 27 aprile 2019 monsignor Enrique Angelelli viene beatificato da papa Francesco.
![]()
Juan Gerardi
Il testo di Palini su Juan José Gerardi Conedera riporta nel sottotitolo: «Nunca mas. Mai più».
Anche il Guatemala, infatti, come altri stati latinoamericani, ha vissuto sul proprio territorio la stagione delle dittature militari sostenute dagli Stati Uniti.
Richiamandosi alla dottrina Monroe del 1823 che affermava la supremazia degli Stati Uniti sul continente americano, a partire dagli anni Sessanta del Novecento, la politica statunitense guarda all’America Latina come al «cortile di casa», da controllare contro il pericolo comunista rappresentato dalla rivoluzione cubana del 1959.
![]() Anche in Guatemala si crea così una stretta alleanza tra gli interessi dell’oligarchia terriera latifondista e le multinazionali statunitensi come la United fruit company, per controllare le monocolture di caffè e banane contro le rivendicazioni contadine e la riforma agraria realizzata dall’unica esperienza democratica guatemalteca, tra il 1945 e il 1954, sotto i governi di Juan José Arevalo (1945-52) e Jacobo Arbenz Guzman (1952-54).
Anche in Guatemala si crea così una stretta alleanza tra gli interessi dell’oligarchia terriera latifondista e le multinazionali statunitensi come la United fruit company, per controllare le monocolture di caffè e banane contro le rivendicazioni contadine e la riforma agraria realizzata dall’unica esperienza democratica guatemalteca, tra il 1945 e il 1954, sotto i governi di Juan José Arevalo (1945-52) e Jacobo Arbenz Guzman (1952-54).
Durante questa breve parentesi viene varata una Costituzione democratica e creato un Codice del lavoro, nasce il Partito guatemalteco del lavoro e la riforma agraria aiuta 100mila famiglie contadine.
Nel 1954, però, un’invasione dall’Honduras guidata dal colonnello guatemalteco Carlos Alberto Castillo Armas, con un gruppo di mercenari e con il diretto aiuto della Cia per respingere il «pericolo rosso», costringe alle dimissioni il presidente Arbenz Guzman.
La giunta militare che si instaura elimina tutte le conquiste democratiche, ripristina il lavoro gratuito degli indigeni, incarcera tutti i sospetti di «comunismo», inaugura un nuovo periodo di repressione e di violazioni dei diritti umani, soprattutto nei confronti delle popolazioni native.
Se in un primo periodo la Chiesa guatemalteca sostiene la dittatura, in seguito, soprattutto dopo il Concilio e la citata Conferenza di Medellin, si diffonde l’«opzione preferenziale per i poveri», di cui Gerardi diventa uno degli esponenti più autorevoli.
Ordinato prete nel 1946, vive tutta l’esperienza del passaggio da una Chiesa schierata con le forze conservatrici a una Chiesa conciliare, attraverso il contatto con le popolazioni rurali, lavorando con le comunità dei popoli indigeni, promuovendo l’uso delle lingue locali nell’alfabetizzazione e nel movimento dei «delegati della parola». Perché, osserva Gerardi, il fatto che esistano culture distinte è una manifestazione della diversità in cui Dio si rivela e agisce all’interno di tutta la cultura umana.
È presidente della Conferenza episcopale del Guatemala dal 1972 al 1976, e poi dal 1980 al 1982. Nel 1976 è il primo firmatario di un documento nel quale i vescovi «denunciano le situazioni di violenza istituzionalizzata, caratterizzate da strutture sociali ingiuste, da emarginazione e miseria».
Per far fronte a tutto ciò, la Chiesa indica la necessità di una radicale riforma agraria, e imputa alle profonde disuguaglianze sociali l’estendersi della rivolta armata, che a sua volta determina l’inasprirsi della repressione. Dunque una spirale di violenza senza fine. Denuncia poi l’esistenza di gruppi paramilitari, l’uso sistematico della tortura, la violazione dei più elementari diritti umani.
Anche la radio diocesana denuncia le violenze e gli assassinii, come lo stesso Gerardi ricorderà: «In quel periodo eravamo vittime di una persecuzione continua. La radio della diocesi era stata accusata dall’esercito di fiancheggiare la guerriglia. Un giorno trovammo un cadavere davanti all’ingresso della radio, con un cartello sul quale era scritto “Padre Lans è morto. Così moriranno tutti gli altri della radio”».
In un anno, dal 1977 al 1978, sono assassinati 143 leader contadini, preti e catechisti.
Nel 1980, anno dell’assassinio in El Salvador di monsignor Oscar Romero, le forze di sicurezza del regime del generale Fernando Romeo Lucas Garcia compiono il massacro all’ambasciata di Spagna: 37 vittime tra contadini e studenti che ne hanno occupato i locali, compresi quattro diplomatici spagnoli.
Lì perde la vita anche il padre di Rigoberta Menchù, futura premio Nobel per la pace nel 1992.
La diocesi di Santa Cruz, guidata da Gerardi, da cui provenivano i contadini che avevano occupato l’ambasciata, emette un duro comunicato di condanna: «Da quattro anni il Quichè sopporta il peso di una violenza estrema, aggravato dall’occupazione militare della zona nord e da altre misure che, di fatto, colpiscono il popolo a beneficio di una minoranza. Come causa di fondo scopriamo uno schema di sviluppo economico, sociale e politico che non tiene conto degli interessi dei poveri e si appoggia alla Dottrina della sicurezza nazionale, che sottomette le persone a un regime di terrore. […] Per questa ragione facciamo nostra la denuncia dei contadini che sono morti per il popolo del Quichè, nell’ambasciata di Spagna».
Ma le uccisioni di dirigenti sindacali, preti, operatori pastorali continuano, compresa la madre di Rigoberta Menchù, rapita, torturata e lasciata agonizzante per giorni.
Sfuggito a un attentato, nello stesso anno Gerardi decide di chiudere la diocesi per mettere al riparo sacerdoti e catechisti, e si rifugia presso vari conventi, mentre molte famiglie contadine vanno in montagna, dove formano le Comunità di popolazione in resistenza (Cpr) «che sviluppano forme di convivenza e sistemi di lavoro collettivi e che, grazie alla perfetta conoscenza del territorio, sono in grado di difendersi dall’esercito».
Dopo un viaggio a Roma, a colloquio con papa Giovanni Paolo II, monsignor Gerardi, per sicurezza, non rientra in Guatemala (si scoprirà in seguito, infatti, che era è stato preparato un attentato contro di lui), e si rifugia in Costa Rica fino al 1982.
Nel 1981, una missione di Pax Christi internazionale, guidata da monsignor Luigi Bettazzi, visita Nicaragua, El Salvador, Honduras e Guatemala. Nel rapporto che ne segue si legge: «Sono gli interessi dell’economia occidentale a spingere i sedicenti Paesi liberi e democratici a tenere in piedi quei regimi dittatoriali che assicurano vendite di materie prime e scambi economici in termini vantaggiosi per i Paesi industrializzati che dominano il mondo. Che in questi Paesi del Centroamerica non esista la democrazia, che piccoli gruppi di famiglie straricche dominino e sfruttino la maggioranza della popolazione in miseria, questo non sembra avere molta importanza. Così l’assurda e spietata dittatura del Guatemala serve da punto di riferimento e di ritrovo degli interessi economici e militari di diversi Paesi dagli Stati Uniti a Israele».
Nel 1983, sia il Tribunale permanente dei popoli in seduta a Madrid, sia Amnesty international, condannano le gravissime violazioni dei diritti umani compiute dalla dittatura guatemalteca, in particolare dopo il colpo di stato di Efrain Rios Montt del 1982, che persegue l’annientamento delle comunità Maya, facendo terra bruciata intorno a loro e reclutando a forza i ragazzi per contrastare la guerriglia. Prima di essere deposto da un ennesimo colpo di stato nell’agosto 1983, i suoi diciassette mesi di governo sono tra i più sanguinari della storia del Guatemala.
Il mutato clima internazionale induce ad avviare un processo di transizione politica che consegni il potere ai civili: nel 1985 si svolgono elezioni generali che portano alla vittoria del democristiano Vinicio Cerezo Arévalo, ma il Paese è ancora dilaniato dalla guerra tra esercito e gruppi della guerriglia.
Il vescovo Gerardi, nel 1986 fa parte della Commissione nazionale di riconciliazione, frutto dei primi passi verso un processo di pace nel Paese.
Nel 1989 l’arcivescovo di Città del Guatemala, Prospero Penado del Barrio, gli affida il compito di creare un Ufficio per i diritti umani nella diocesi.
Nella veste di coordinatore di questo ufficio, negli anni parteciperà alla Commissione Onu per i diritti umani, con sede a Ginevra, denunciando l’impunità che regna nel suo Paese.
Dopo il Premio Nobel per la pace a Rigoberta Menchù nel 1992, anche Gerardi riceve diversi riconoscimenti internazionali.
Nel 1994 a Oslo viene sottoscritto un accordo tra il governo del Guatemala e la Unidad Revolucionaria nacional guatemalteca (Urng), che prevede l’istituzione di una Commissione di indagine sulle violenze perpetrate nel Paese. Gerardi propone di integrarla con il progetto Remhi (Recuperacion de la memoria historica), un lavoro da lui coordinato, che si concluderà con la pubblicazione di quattro volumi dal titolo Guatemala. Nunca mas, per documentare le uccisioni, le sparizioni, la repressione e le violazioni dei diritti umani tra il 1956 e il 1996.
L’arcivescovo Penado del Barrio, nella Presentazione del rapporto scrive: «Con questa guerra in cui si è torturato, si è assassinato e si sono fatte scomparire intere comunità, che sono rimaste terrorizzate e indifese in questo fuoco incrociato, in cui si è distrutta la natura, che nella cosmovisione indigena è sacra, la madre terra, è anche stata spazzata via, come un uragano impetuoso, la parte più viva dell’intellighenzia del Guatemala. Il Paese è rimasto improvvisamente orfano di cittadini autorevoli».
Nel 1995 Gerardi partecipa in Italia alla Marcia Perugia-Assisi.
Nel 1996 è firmato finalmente l’accordo di pace, e nel 1998 il rapporto Nunca mas è consegnato a Rigoberta Menchù.
Due giorni dopo la presentazione dei risultati del progetto Remhi, il vescovo Gerardi è assassinato nel suo garage.
Per il delitto saranno condannati il colonnello Byron Lima Estrada, suo figlio, il capitano Byron Lima Oliva, il soldato Obdulio Villanueva e il viceparroco Mario Orantes in qualità di complice, ma i mandanti, gli alti vertici militari e politici, rimarranno liberi.
Angela Dogliotti
Centro studi Sereno Regis
I LIBRI DI ANSELMO PALINI
- Hélder Câmara. «Il clamore dei poveri è la voce di Dio», Ave, Roma 2020, pp. 240, 14,00 €.
- Don Pierino Ferrari. «Vestito di terra, fasciato di cielo», Ave, Roma 2020, pp. 304, 14,00 €.
- Teresio Olivelli. Ribelle per amore, Ave, Roma 2018, pp. 318, 20,00 €.
- Oscar Romero. «Ho udito il grido del mio popolo». Ave, Roma 2018, pp. 290, 20,00 €.
- Una terra bagnata dal sangue. Oscar Romero e i martiri di El Salvador, Paoline, Milano 2017, pp. 224, 16,00 €.
- Marianella Garcìa Villas. «Avvocata dei poveri, difensore degli oppressi, voce dei perseguitati e degli scomparsi», Ave, Roma 2014, pp. 272, 12,00 €.
Primo Mazzolari. Un uomo libero, Ave, Roma 2009, pp. 304, 16,00 €.