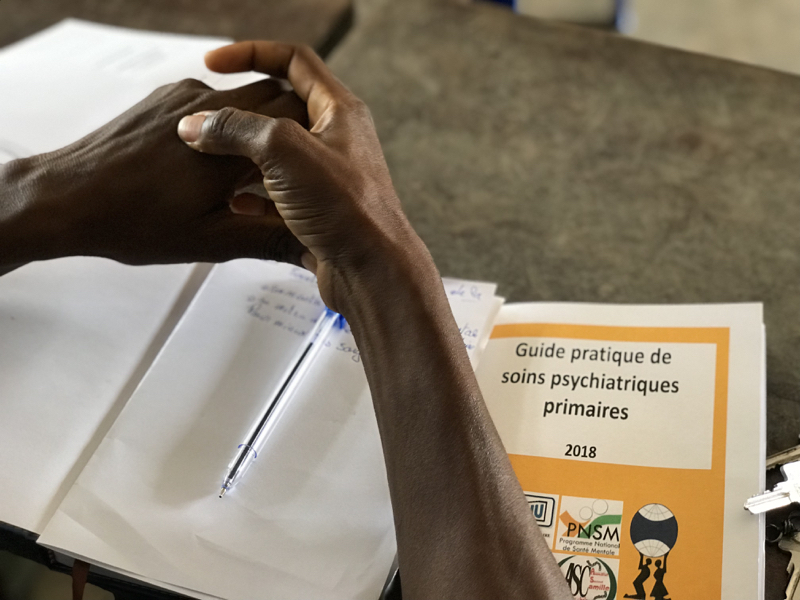Sognando e annunciando
Inserto a cura di Sergio Frassetto |
Originale, poetica e… breve! Così si presenta l’Esortazione apostolica post sinodale «Querida Amazonia», che ci fa intravedere i quattro «sogni» di papa Francesco sull’amata Amazzonia. Leggendo e gustandone gli appassionati paragrafi, colpiscono alcune affermazioni che, pur rivolte ai popoli della grande foresta, insaporiscono – rinvigorendola – la vocazione missionaria di tutta la Chiesa.
Così, ad esempio: «Di fronte a tanti bisogni e tante angosce che gridano dal cuore dell’Amazzonia… come cristiani non rinunciamo alla proposta di fede, che abbiamo ricevuto dal Vangelo. Pur volendo impegnarci con tutti, fianco a fianco, non ci vergogniamo di Gesù Cristo. Per coloro che lo hanno incontrato, vivono nella sua amicizia e si identificano con il suo messaggio, è inevitabile parlare di Lui e portare agli altri la sua proposta di vita nuova» (n. 62).
Se diamo la nostra vita per gli altri, per la giustizia e la dignità che meritano, non possiamo nascondere ad essi che lo facciamo perché riconosciamo Cristo in loro e perché scopriamo l’immensa dignità concessa loro da Dio che li ama infinitamente. «Senza questo annuncio appassionato, ogni struttura ecclesiale diventerà un’altra Ong, e quindi non risponderemo alla richiesta di Gesù Cristo: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura”» (n. 64).
Il papa, poi, invita a non «bollare con troppa fretta come paganesimo o superstizione, alcune espressioni religiose che nascono spontaneamente dalla vita della gente».
Il beato Giuseppe Allamano lo aveva anticipato di «qualche anno», quando ai suoi primi missionari in Kenya, un po’ troppo zelanti a condannare danze e riti indigeni, scriveva: «Letto il diario, vedo che il missionario si scagliò contro i goma (balli)… Per carità, si vada adagio, come qui tra noi per il ballo, sebbene sia più cattivo. Dobbiamo dissimulare il male, perché è impossibile ora vincere la cosa e sarebbe di pregiudizio alla conversione il combatterlo di fronte».
Sarà proprio grazie all’inculturazione del Vangelo, fatta con rispetto e senza fretta, che «potranno nascere testimonianze di santità con volto amazzonico, che non siano copie di modelli da altri luoghi; santità fatta di incontro e dedizione, di contemplazione e di servizio, di solitudine accogliente e di vita comune, di gioiosa sobrietà e di lotta per la giustizia… Immaginiamo una santità dai lineamenti amazzonici, chiamata a interpellare la Chiesa universale» (n. 77).
Avanti, allora, su questa strada come cristiani, tanto più come missionari: sarebbe triste che i poveri e i dimenticati non ricevessero da noi «il grande annuncio salvifico, quel grido missionario che punta al cuore e dà senso a tutto il resto».
padre Giacomo Mazzotti
G. Allamano e G. Alberione
L’amicizia tra sacerdoti santi
Tra Giuseppe Allamano e Giacomo Alberione (1884-1971), il fondatore delle Famiglie Paoline, nonostante una differenza di 33 anni di età, sorse una buona intesa sacerdotale. Espressamente ne parla anche padre Candido Bona, missionario della Consolata e storico riconosciuto: «I suoi contatti con l’Allamano, di persona e per lettera, non si limitarono a casi sporadici, per quanto di particolare importanza, ma rivestirono il carattere di vera direzione, dalla quale attingeva lumi soprannaturali, conforto e direttive. La cosa desta ammirazione, se si tiene presente che l’Alberione risiedeva ad Alba e non a Torino».
![]() Reciproca collaborazione. Probabilmente la collaborazione tra i due uomini di Dio si espresse soprattutto negli incoraggiamenti dell’Allamano all’Alberione per la fondazione della Pia Società di S. Paolo. Fu una collaborazione speciale, che dimostrò la stima e la fiducia reciproche. Non c’è dubbio che l’Allamano si fosse reso subito conto che il progetto dell’Alberione era una vera ispirazione che proveniva da Dio. Fu lo stesso Alberione, parlando in terza persona, a confidare come l’Allamano lo avesse incoraggiato fin dall’inizio. In una bella testimonianza inviata da Alba il 29 gennaio 1933, in vista della prima biografia che si stava scrivendo sull’Allamano, scrisse: «So di un sacerdote [non c’è dubbio che si tratti dell’Alberione stesso] che ricorse al can. Allamano prima di ritirarsi dalla santa opera di zelo a cui stava intento [in quel periodo era direttore spirituale del seminario], per consacrarsi ad altre opere cui un interno movimento di grazia sembrava invitarlo [cioè la comunicazione sociale attraverso la stampa]. L’Allamano sentì e pregò: poi rispose con poche, ma decisive parole. Il caso era difficilissimo, ma le prove di una ventina d’anni gli diedero del tutto ragione. Eppure, bisogna dire che in quel momento erano molti i pareri contrari». Questa testimonianza è confermata dallo stesso Alberione in un incontro con padre Giuseppe Caffaratto: «Lei è della Consolata, dell’Istituto del canonico Allamano. Io conservo sempre tanta riconoscenza al canonico Allamano perché agli inizi della mia congregazione, mentre quasi tutti i sacerdoti mi erano contrari e mi dicevano: “Pianta lì, con i tuoi giornali e la tua stampa!”, lui mi diceva: “Vai avanti, vai avanti!”. E mi fu di grande incoraggiamento».
Reciproca collaborazione. Probabilmente la collaborazione tra i due uomini di Dio si espresse soprattutto negli incoraggiamenti dell’Allamano all’Alberione per la fondazione della Pia Società di S. Paolo. Fu una collaborazione speciale, che dimostrò la stima e la fiducia reciproche. Non c’è dubbio che l’Allamano si fosse reso subito conto che il progetto dell’Alberione era una vera ispirazione che proveniva da Dio. Fu lo stesso Alberione, parlando in terza persona, a confidare come l’Allamano lo avesse incoraggiato fin dall’inizio. In una bella testimonianza inviata da Alba il 29 gennaio 1933, in vista della prima biografia che si stava scrivendo sull’Allamano, scrisse: «So di un sacerdote [non c’è dubbio che si tratti dell’Alberione stesso] che ricorse al can. Allamano prima di ritirarsi dalla santa opera di zelo a cui stava intento [in quel periodo era direttore spirituale del seminario], per consacrarsi ad altre opere cui un interno movimento di grazia sembrava invitarlo [cioè la comunicazione sociale attraverso la stampa]. L’Allamano sentì e pregò: poi rispose con poche, ma decisive parole. Il caso era difficilissimo, ma le prove di una ventina d’anni gli diedero del tutto ragione. Eppure, bisogna dire che in quel momento erano molti i pareri contrari». Questa testimonianza è confermata dallo stesso Alberione in un incontro con padre Giuseppe Caffaratto: «Lei è della Consolata, dell’Istituto del canonico Allamano. Io conservo sempre tanta riconoscenza al canonico Allamano perché agli inizi della mia congregazione, mentre quasi tutti i sacerdoti mi erano contrari e mi dicevano: “Pianta lì, con i tuoi giornali e la tua stampa!”, lui mi diceva: “Vai avanti, vai avanti!”. E mi fu di grande incoraggiamento».
Il pensiero dell’Allamano sull’Alberione.
Non si possiede documentazione scritta su questo punto, ma è facile intuire la stima dell’Allamano per l’Alberione dal fatto, come si è detto, che fu uno dei pochi a sostenerlo per la fondazione dei Paolini. Dai frequenti incontri a Torino, quando l’Alberione veniva appositamente da Alba per consultarlo, certamente l’Allamano si rese conto del valore di quel giovane sacerdote. Ecco perché lo sostenne sempre e lo incoraggiò, dandogli opportuni consigli. È lo stesso Alberione a rivelare quanto l’Allamano gli suggeriva.
Il pensiero dell’Alberione sull’Allamano.
![]() Sulla stima che l’Alberione aveva per l’Allamano non ci sono dubbi. In un’omelia ai chierici ad Alba nell’autunno del 1924 disse: «Volete incontrare dei santi viventi? Andate a Torino e visitate il canonico Allamano e don Rinaldi; andate in Liguria e troverete padre Seteria; spingetevi in Sicilia e ancora potete incontrare il canonico Di Francia». Sapeva individuare i santi senza sbagliarsi.
Sulla stima che l’Alberione aveva per l’Allamano non ci sono dubbi. In un’omelia ai chierici ad Alba nell’autunno del 1924 disse: «Volete incontrare dei santi viventi? Andate a Torino e visitate il canonico Allamano e don Rinaldi; andate in Liguria e troverete padre Seteria; spingetevi in Sicilia e ancora potete incontrare il canonico Di Francia». Sapeva individuare i santi senza sbagliarsi.
Così inizia la testimonianza, citata sopra, del 29 gennaio 1933: «Stimavo e stimo come santo il can. Allamano; seguii il suo consiglio in momenti importanti e me ne trovo contento; anzi ai chierici io riporto spesso il suo esempio, nelle esortazioni e meditazioni».
L’Alberione si dilunga a riportare diverse espressioni dell’Allamano, da lui ascoltate, che lo hanno impressionato per la loro semplicità e concretezza.
Eccone alcune: «Diceva ad un giovane sacerdote: “Lavorare al confessionale, nella predicazione, nella scuola; ma prima riservare il tempo necessario per l’anima propria. Vi sono persone che si rendono inutili, per sé e per gli altri, col troppo fare per gli altri, trascurando se stessi; spesso mi vidi costretto a chiudere la stanza e non rispondere, e declinare inviti ad opere buone… per riservare il tempo per la preghiera, lo studio…”. Al superiore di un Istituto religioso diceva: “Se volete gli istituti religiosi fiorenti, fate una porticina per entrarvi, un portone per uscire; cioè assicuratevi bene della vocazione vera prima di accettare; quando poi non danno prove chiare, licenziate con coraggio”.
Era ammirabile il suo intuito e la sicurezza del suo giudizio; quando andavo da lui non mi lasciava finire di parlare, gli bastavano poche parole, rispondeva con semplicità, brevità e sicurezza tali che infondeva coraggio ad operare e pace di spirito. Avevo sempre l’impressione che in lui fosse qualche cosa di più che l’ordinario lume; tanto più che sempre vidi nella pratica essere stato buono il suo consiglio. Ciò parecchie volte si è ripetuto.
Lo osservavo con diligenza tutte le volte che ebbi occasione di avvicinarlo: ritenendo prezioso ogni momento che potessi vederlo: la sua presenza mi sembrava un libro parlante, una regola; mi pareva spargesse un po’ di quella grazia che certamente portava nel cuore, perché mi pareva che ogni suo atto, ogni sua parola, persino gli atteggiamenti e i movimenti più trascurabili fossero ispirati a quello spirito soprannaturale, tanto Egli viveva di fede e sempre padrone di tutto se stesso: parole, disposizioni, sensi, azioni.
Il can. Allamano parlava con semplicità; non si turbava se altri diceva diversamente e anche se il suo consiglio veniva messo da parte, lasciando la cura di tutto alla Provvidenza. Come parlava per motivo di carità, così per motivo di carità taceva: conservando l’indifferenza dei santi anche riguardo le cose più delicate, o che toccavano più direttamente la sua persona».
In data 4 marzo 1943, dieci anni dopo avere mandato la sua prima testimonianza, l’Alberione scrisse al postulatore della causa di beatificazione dell’Allamano che lo aveva nuovamente interpellato: «Ho ancora esaminato diligentemente l’attestazione scritta da me e data a suo tempo. Non ho da togliere o da aggiungere altro».
padre Francesco Pavese
Giuseppe Allamano: fedeltà e novità
Il 5 luglio 2019, la signora Emanuela Costamagna ha conseguito, a pieni voti, la Laurea magistrale presso l’Istituto superiore di scienze religiose di Torino, difendendo la tesi dal titolo: «Beato Giuseppe Allamano. Fedeltà e novità nel suo pensiero teologico e nella sua attività missionaria».
La prima parte di questo articolo è stata pubblicata su «Missioni Consolata» di gennaio. In questo numero ne pubblichiamo la seconda e ultima parte.
Il quarto capitolo è la «perla» della tesi sull’Allamano, scritta con passione dalla signora Emanuela Costamagna, e va considerato come una spinta in avanti.
L’autrice esamina dal punto di vista teologico alcuni degli aspetti più importanti individuati nei primi tre capitoli e fa emergere che l’Allamano può essere considerato «figlio del suo tempo» perché viveva appieno la visione teologica del suo periodo storico.
Tuttavia, pensando che il suo scopo era formare giovani uomini e donne che presto sarebbero stati inviati lontano con lo stesso spirito missionario, ha insistito su alcuni aspetti particolari portando delle sue originalità che potrebbero racchiudersi nelle sue stesse parole: «amare e farsi santi è la stessa cosa».
Alla fine della tesi c’è un’interessante conclusione. Ecco qualche tratto ripreso alla lettera: «Al termine del percorso che mi ha portato alla stesura di questa tesi, posso dire che, sebbene già conoscessi la figura del beato Allamano e alcuni missionari e suore della Consolata, ho avuto la possibilità di approfondirne il carisma e il pensiero.
Nel corso della tesi ho avuto modo di analizzare come maturò il suo carisma ricevuto dallo Spirito e quali novità introdusse con le sue riflessioni. Anzitutto si può constatare che l’Allamano fondava il suo pensiero su solide basi: da una parte il messaggio del Vangelo con il suo annuncio della salvezza portata da Cristo e del ruolo di corredentrice di Maria e dall’altra una importante attenzione al prossimo, mettendo insieme il comando di Cristo “andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni” (Mt 28, 19) con quello di “amerai il prossimo tuo come te stesso” (Mt 22,38).
L’Allamano trasferì la sua grande attenzione per il prossimo nello spirito dei missionari. La sensibilità che richiedeva verso gli indigeni era molto particolare, portava avanti delle istanze che al suo tempo non erano sempre comprese da tutti. Sicuramente la fede che richiedeva doveva essere vissuta pienamente nella vita pratica attraverso le opere, perché era conscio che in missione una scuola, un ospedale, un orfanotrofio avrebbero fatto del bene agli indigeni e preparato la strada alla conversione. Ecco perché insisteva sulla necessità di elevare l’ambiente.
Anche la valorizzazione dei sacerdoti e dei catechisti locali, da lui fortemente sostenuta, ebbe come base la necessità di far crescere una Chiesa con pastori e collaboratori originari del luogo, il che è uno dei fini della missione e, oggi, di estrema attualità.
Come si è visto, l’Allamano pur non essendo un innovatore, sicuramente fece delle riflessioni e diede delle direttive ragguardevoli e talvolta coraggiose per il suo tempo e che, ancora oggi, costituiscono lo spirito dei membri dei due istituti. Iniziando da quel piccolo gruppo di due sacerdoti e due fratelli coadiutori partiti per il Kenya nel 1902, ora i missionari e le missionarie della Consolata operano in Europa, Africa, Asia ed America.
Ciò che ho potuto constatare, avendo anche visitato parecchie loro missioni in Africa e in America Latina ed avendo vissuto un anno e mezzo in una missione in Etiopia, è che lo spirito e gli insegnamenti che l’Allamano impartiva sono ancora attuali e seguiti».
L’autrice della tesi, oltre che per la serietà dello studio, va lodata per la stima e la fiducia nell’Allamano. Questa è la confidenza fatta al missionario cui si riferiva, all’inizio del lavoro: «La mia tesi sarà buona perché fatta con rispetto verso l’Allamano che a me ha dato tanto! Potevo avvicinarmi ad altri istituti, per andare in missione. Ma il mio cuore ha scelto la casa madre di corso Ferrucci e l’Allamano. Per cui glielo devo al caro Beato, e mi impegno a fare meglio che posso la tesi su di lui». Un particolare molto significativo: durante la discussione della tesi la signora Emanuela, ogni volta che nominava l’Allamano, lo chiamava sempre «Fondatore», manifestando, forse senza accorgersene, il suo sincero legame con lui.
Il piccolo gruppo che ha accompagnato la signora Emanuela durante la discussione era formato dal marito Fabio e due figlie (Elia,
il bimbo di un anno e mezzo è rimasto con i nonni), dai genitori, alcuni amici e missionari. Al termine della difesa, rientrati nella sala, si attendeva l’esito con curiosità, non disgiunta da comprensibile apprensione. Il presidente ha pronunciato queste parole:
«Il giudizio unanime della commissione
è che la tesi ha le seguenti qualità: accuratezza, profondità, ampiezza. Votazione: 30 lode!». L’applauso felice e fragoroso è scoppiato istantaneo. (Fine)
![]()