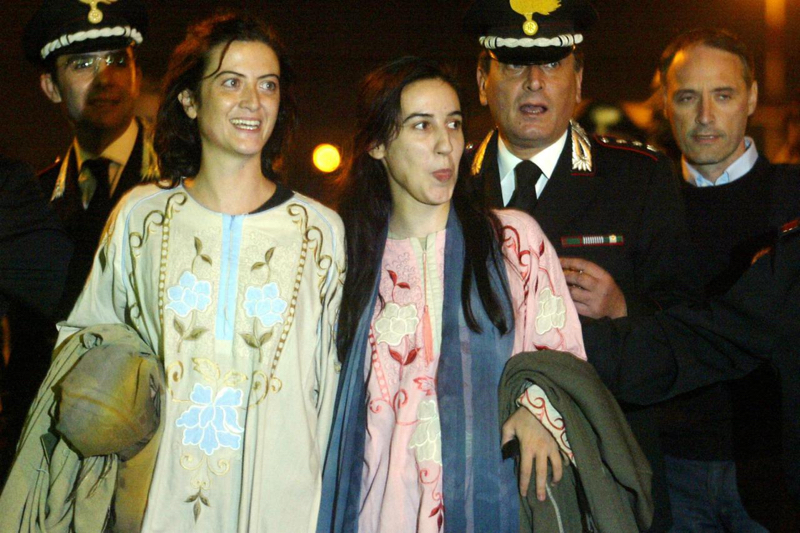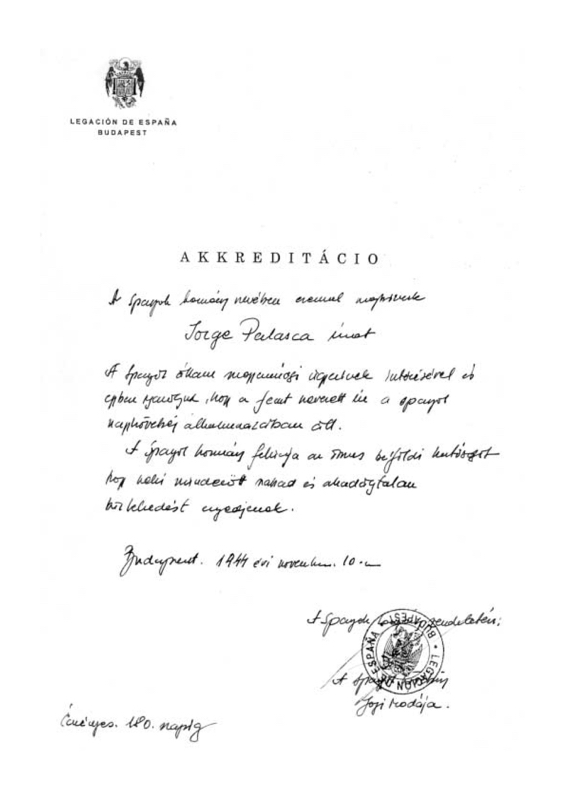Paolo a Corinto ed Efeso (At 18-19)
testo di Angelo Fracchia |
Alla fine del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, Paolo si allontana deluso e schernito da Atene e si rifugia a Corinto, dove si fermerà per circa un anno e mezzo. Poco dopo si fermerà altri due anni a Efeso. Non erano città semplici.
Corinto, a cavallo tra due porti, era città di commercianti, di gente magari grezza ma astuta. La città evocava una vita dissoluta, costosa, dove gli ingenui venivano facilmente depredati. Efeso era la capitale di una delle regioni più ricche dell’impero, nessun tempio riceveva più offerte del suo, dedicato ad Artemide, considerata una divinità potentissima, affascinante e terribile.
In queste due città, Paolo predica per più tempo, perché lo Spirito gli garantisce che lì un popolo numeroso è chiamato a incontrare Gesù (At 18,10). Evidentemente il cristianesimo accetta le sfide impegnative.
Siccome Luca sceglie di raccontarci solo alcuni episodi sparsi di questi anni, anche noi non procediamo in ordine cronologico ma riprendiamo alcuni dei temi da lui sollevati.
Uno storico accurato
Partiamo da un aspetto che potrebbe sembrare marginale.
Luca definisce «proconsoli» sia Gallione per l’Acaia (18,12) che il governatore di Efeso. Proconsoli, non procuratori, come ci si poteva attendere (cfr. At 23,24; 26,30), e a Efeso cita correttamente gli «asiarchi» (19,31), pur avendo parlato di «politarchi» per Tessalonica (17,6: nella traduzione italiana sono «capi della città»). Questi usati da Luca, sono i titoli corretti, confermati da iscrizioni o testi antichi. L’evangelista è inoltre informato dell’editto di espulsione da Roma dei giudei (18,2), che, al di là dei proclami, aveva in realtà coinvolto ben poche persone.
Noi abbiamo in mente una realtà imperiale molto compatta e omogenea, sul modello degli imperi del xvii secolo. I romani però distinguevano, separavano, privilegiavano gli uni a detrimento dei vicini, utilizzando titoli diversi per rendere ancora più difficile l’omologazione. L’unico modo per utilizzare i titoli corretti era avere una grande cultura o una precisa conoscenza derivata dall’esperienza.
Certo, si potrebbero imputare a Luca alcuni silenzi: come è possibile che non parli (quasi) mai della chiesa di Alessandria, che meno di un secolo dopo sarebbe emersa come una delle più grandi, strutturate e colte? Già in At 6, sulla vicenda degli ellenisti e dei diaconi, aveva glissato su problemi che pure lascia intuire. Non è una critica: gli storici contemporanei di Luca erano enormemente più disinvolti nel manipolare la storia. Lui non lo fa, anche se, narrando solo qualcosa, ci presenta l’ideale. Pur lasciandoci intuire una realtà non così perfetta. Prestiamo quindi ancora più attenzione a ciò che ci racconta. Con un occhio a ciò che tace.

I collaboratori
Gli Atti si muovono ormai intorno a Paolo, che però non viaggia da solo. Il cristianesimo non sopporta gli attori solisti, è sempre comunità. Paolo, quindi, è sempre circondato da altre persone: che siano collaboratori stretti (Gaio e Aristarco, di cui non sappiamo altro: 19,29; e i ben più noti Sila e Timoteo: 18,5) o supporti quasi casuali, come Tizio Giusto (18,7) e Tiranno (19,9) che ospitano a lungo Paolo, o Alessandro (19,33), che è un ebreo ma intende parlare a difesa anche dei cristiani. Oppure vere e proprie colonne, come Apollo e la coppia Aquila e Priscilla.
Questi ultimi sono ebrei di Roma, dai nomi latini, anche se grecizzati, e vengono sempre citati insieme. Marito e moglie, fabbricanti di tende, non si fanno deprimere dall’espulsione da Roma (probabilmente motivata già dalle discussioni su Gesù), ma ne approfittano per farsi evangelizzatori anche altrove. Priscilla (la «piccola Prisca», suo vero nome) sembra la vera guida di una coppia che si muove con coraggio («Essi per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa»: Rom 16,4) e acume. Infatti, quando ascoltano Apollo e colgono l’imperfezione della sua predicazione, non pensano di tarpargli le ali, ma gli spiegano meglio come stanno le cose e poi lo raccomandano, inviandolo là dove può fare bene, a Corinto. A volte tendiamo a rendere astratto l’amore cui sono chiamati i cristiani, ma ciò che questa coppia fa è esattamente amare il prossimo, fare il suo bene; e, insieme, anche quello della chiesa.
Apollo è un’altra figura estremamente affascinante. Ebreo dalla profonda cultura biblica ma dal nome greco e di lingua greca, viene da Alessandria d’Egitto e annuncia il vangelo con generosità, anche se con una preparazione imperfetta. A Corinto ci sarà chi vorrà contrapporlo a Paolo (cfr. 1 Cor 3,4-7), che però mostra di apprezzarlo.
A margine, possiamo addirittura fantasticare un poco. Nel canone del Nuovo Testamento è compreso un testo, la cosiddetta Lettera agli Ebrei, che è una specie di trattato teologico composto da qualcuno che conosce molto bene il greco e l’Antico Testamento. Ma lo stile dell’intera lettera non è paolino, anche se si chiude con una specie di firma autografa di Paolo (Eb 13,22-25), la cui posizione è però strana perché sembra più un’aggiunta che parte della lettera stessa, un biglietto d’accompagnamento scritto da Paolo e inserito alla fine. Alcuni ipotizzano che l’autore possa essere Apollo, ottimo retore e approfondito conoscitore della scrittura ebraica. Paolo, lungi dal sentirsi sfidato, potrebbe aver aiutato questo testo a girare nelle proprie chiese.
Formazioni incomplete
Proprio Apollo ci può servire per cogliere un altro aspetto di ciò che Luca, probabilmente, vuole insegnarci. Priscilla e Aquila lo sentono predicare, si accorgono delle lacune, gliele colmano, e poi lo raccomandano a Corinto (At 18,26-27). Paolo, all’inizio della sua missione a Efeso, trova altri fratelli che annunciano il Vangelo, senza neanche conoscere lo Spirito Santo (19,1-7). Anche in questo caso, la loro formazione viene completata, e Paolo vede scendere su di loro lo Spirito, e li inserisce nella chiesa.
In un caso e nell’altro abbiamo persone con una formazione incompleta, segno, evidentemente, di una chiesa vivissima, creativa, originale e non ancora imbrigliata da tradizioni intoccabili e normative codificate. Per certi aspetti, il contrario di quello che spesso è la chiesa nostra. Ma in alcune dimensioni e scelte di fondo ci ritroviamo. Luca sembra suggerire tre atteggiamenti, nel rapportarsi con le differenze dentro la chiesa.
Intanto la correzione degli errori e l’approfondimento della conoscenza. Probabilmente è l’aspetto meno importante, ma pure rimane. Non ci si limita ad apprezzare e lodare la buona volontà di Apollo o dei fratelli che non conoscono lo Spirito Santo: li si istruisce, li si corregge, li si migliora.
Poi, più importante, l’apertura di fondo alla fiducia. Abbiamo già detto che forse, nel nostro contesto ecclesiale, una coppia di commercianti/imprenditori come Aquila e Priscilla non avrebbe trovato modo di incidere così tanto nell’annuncio, perché probabilmente ritenuta poco affidabile. E sicuramente una figura come Apollo susciterebbe sospetti e invidie (pensiamo a quante cattiverie leggiamo nei nostri social, soprattutto verso chi prova a impegnarsi, sia pure senza tutte le carte in regola!). La prima chiesa cristiana, che, come abbiamo visto, non è senza difetti, su questo sa restare aperta, convinta che solo lasciando spazio all’iniziativa umana si dà spazio allo Spirito Santo.
Il terzo aspetto è il più significativo: la relazione personale con Dio. Questa è fondamentale e ineliminabile, e si ottiene (al tempo degli Atti, ma anche nel nostro xxi secolo) solo con l’apertura allo Spirito. Se con Apollo basta integrare la sua formazione, con gli altri fratelli occorre battezzarli perché conoscano e ricevano lo Spirito, perché senza quello non si è cristiani. E chiunque sia nato dallo Spirito, che non si sa da dove venga o dove vada (Gv 3,8), è una continua scoperta e sorpresa. Perché lo Spirito dà il dono della vita, la quale è arricchente e appagante se solo si accetta di non ingabbiarla.
Una forma di ingabbiamento, ad esempio, è quella di ridurre il Vangelo a formule e magia. Senza relazione con Dio, con lo Spirito, si è fuori strada. È quello che, pur con un tono un po’ favolistico, si racconta dei figli di un certo Sceva, esorcisti itineranti (At 19,13-17). Dio è per la vita, e per la vita piena, ma solo in una relazione con lui che sia autentica e sincera, personale e quindi senza usare Dio come un amuleto.
Rapporto con i poteri

Il Vangelo non è astratto, atemporale. La vita della chiesa è incarnata. Paolo e la chiesa tutta devono fare i conti con i poteri che, storicamente, si trovano davanti.
In particolare, devono rapportarsi con il potere civile, che è costituito dai rappresentanti dell’Impero Romano, e con quello religioso, che ancora passa da una chiesa centrale in Gerusalemme che vorrebbe esercitare un certo dominio sulle altre chiese e che non guarda con enorme favore l’impostazione teologica di Paolo.
Probabilmente anche con la chiesa di Antiochia il rapporto non è più idilliaco come in passato. Luca, pur cercando di smussare la realtà, infatti, deve ammettere che la missione paolina verso i non ebrei, con la messa in discussione della legge mosaica, ha inquietato diversi cristiani della prima ora, che si sentono ancora innanzitutto «ebrei» (come abbiamo visto leggendo At 15).
Come dicevamo sopra, anche ciò che non si dice è significativo. Paolo, già guida di Antiochia (At 13,1) e capofila della missione ai non ebrei, torna da un viaggio che lo ha tenuto impegnato per almeno due anni, e tutto quello che Luca ha da dire è che: «Salì a Gerusalemme a salutare la Chiesa e poi scese ad Antiochia. Trascorso là un po’ di tempo, partì» (At 18,22-23). Luca dice troppo poco, e noi non possiamo fare a meno d’insospettirci. Paolo sente freddezza intorno a sé. Forse per questo motivo, prima di arrivare a Gerusalemme trova il tempo di «sciogliere un voto» (18,18), adempiendo una consuetudine ebraica che «sapeva di vecchio»: consisteva nell’astenersi dal radersi (almeno i capelli) e dal bere vino per un certo tempo, come invocazione o ringraziamento a Dio. Si direbbe quasi che Paolo si impegni in questa devozione come gesto di buona volontà verso i cristiani più conservatori. Forse inutilmente.
E intanto deve continuare ad affrontare le sfide di coloro che si sentono infastiditi dal suo modo di fare. Anche a Corinto ed Efeso, infatti, c’è chi cerca di bloccare «dall’esterno» la sua predicazione. A Corinto, come era già successo in tanti luoghi, sono gli ebrei a cercare di denunciarlo, con dei risultati tragicomici e non del tutto comprensibili (18,12-17). A Efeso è invece un orafo a sobillare la folla (19,23-40): la predicazione cristiana inizia a dare fastidio anche al paganesimo, e in uno dei suoi centri più rinomati e ricchi! In entrambi i casi non riescono a fermare l’annuncio: a Efeso è il cancelliere della città a invitare gli agitatori a calmarsi, a Corinto è lo stesso governatore a sancire che in ballo c’è solo una questione religiosa, interna agli ebrei.
Se questo da una parte dice, soprattutto a noi, che almeno per gli osservatori esterni cristianesimo ed ebraismo non erano ancora ben distinti, dall’altra indica, soprattutto ai lettori del tempo di Luca, che le autorità romane sono state più volte chiamate a prestare attenzione al nuovo movimento, e ad analizzarlo sono stati i loro rappresentanti più alti, senza che questi trovassero nulla di legalmente inquietante. Il cristianesimo disturba, agita, tocca interessi economici, ma non è contro l’ordine costituito. Per chi cresceva nell’Impero Romano, imparando ad apprezzarne l’ordine, era un particolare significativo.
Angelo Fracchia
(17-continua)