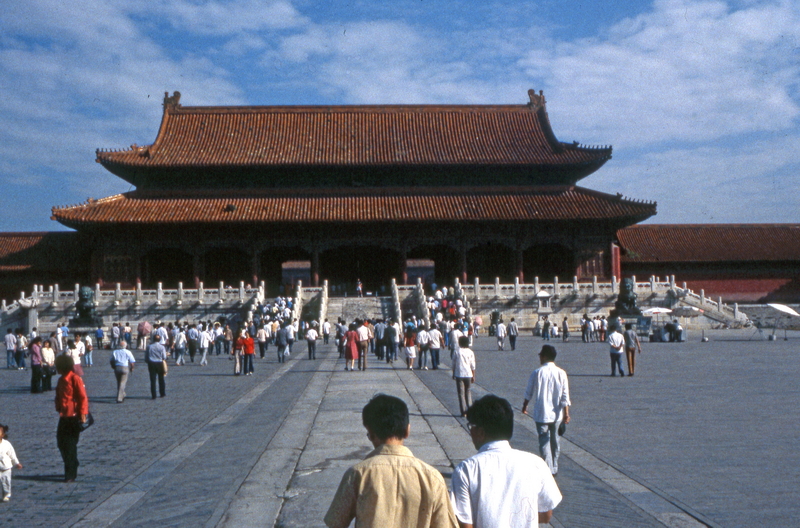Se scomparissero (anche) le api
testo di Rosanna Novara Topino |
Le attività umane stanno determinando la sparizione o la riduzione di molte specie viventi (animali e vegetali). Questa perdita (silenziosa) della biodiversità ha conseguenze molto preoccupanti per la nostra vita e per quella del pianeta.
Il surriscaldamento del pianeta (global warming) è quasi ovunque oggetto di attenzione, nonché di iniziative tese a rallentarne l’aggravamento. Questo perché sono già ben visibili gli effetti in termini di alterazioni del clima, sotto forma di alluvioni, uragani, valanghe che lasciano spesso una scia di morte e devastazione. A questi fenomeni si aggiunge lo scioglimento del ghiaccio ai poli, con l’aumento del livello del mare che, in futuro, rappresenterà un serio problema per molte popolazioni costiere e la scomparsa di molti ghiacciai montani, con la conseguente perdita di grandi quantità di acqua dolce. Si parla invece un po’ meno della perdita della biodiversità, probabilmente perché avviene in modo più silenzioso e questo non ci aiuta a renderci conto di quali gravi conseguenze essa comporti per il genere umano. Sicuramente essa eguaglia e probabilmente supera per importanza e urgenza la crisi dovuta ai cambiamenti climatici. Peraltro, i due fenomeni sono strettamente connessi tra loro.
Antropocene e tassi d’estinzione
L’estinzione delle specie è un fenomeno sempre esistito, ma i tassi attuali sono di gran lunga superiori a quelli naturali. Si stima che, dalla comparsa dell’uomo sulla Terra, i tassi di estinzione di uccelli e di mammiferi siano da 100 a 1.000 volte superiori rispetto a prima. Il tasso di estinzione globale per tutte le specie animali e vegetali è circa 10mila volte superiore a quello naturale, e il numero di estinzioni è aumentato soprattutto negli ultimi due secoli nei quali le attività umane hanno causato in molti modi la scomparsa o la riduzione di diverse specie. Secondo gli scienziati, siamo di fronte alla sesta estinzione di massa nella storia della Terra, questa volta per cause antropiche e con proporzioni superiori persino a quella che causò la scomparsa dei dinosauri 65 milioni di anni fa.
Il peso delle attività umane sul pianeta è tale che si parla dell’era geologica attuale come di Antropocene, perché l’essere umano non solo si è adattato all’ambiente, come fanno tutte le specie viventi di successo, ma lo ha modificato a suo favore, a scapito spesso delle altre forme di vita.
Per capire cosa stiamo perdendo, è necessario soffermarsi un attimo su cosa sia la biodiversità. Questo concetto comprende ogni manifestazione della vita, a tutti i livelli di organizzazione biologica. Si va dal livello molecolare a quello del patrimonio genetico, dalle specie alle comunità biologiche, quindi la biodiversità è una componente essenziale dell’ambiente naturale nel quale è comparsa e si è evoluta anche la specie umana. Gli esseri umani hanno bisogno della biodiversità per la loro sopravvivenza e ne fanno parte. La biodiversità è l’insieme dei patrimoni genetici e delle conoscenze apprese dalle specie nei loro processi evolutivi che da milioni di anni permettono loro di sopravvivere e adattarsi a condizioni ambientali estremamente variabili.

I benefici della biodiversità
I vantaggi della salvaguardia della biodiversità sono molteplici. In primo luogo essa garantisce la qualità della vita delle future generazioni per il suo valore economico, attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali. C’è poi il suo valore scientifico, che si traduce nella conoscenza e nella conservazione delle specie. Non meno importanti sono i valori estetico, ricreativo, culturale e spirituale. La biodiversità, infine, svolge un’azione regolatrice fondamentale dei cicli biogeochimici della terra, stabilizzando il clima, regolando i deflussi delle acque e rinnovando il suolo. In pratica, la biodiversità è per il pianeta quello che per noi è il sistema immunitario.
Se veniamo aggrediti da agenti patogeni, il nostro sistema immunitario, alla base del quale sta un’enorme variabilità legata al patrimonio genetico, è in grado di scegliere, tra infinite possibilità, il tipo di anticorpo più adatto a neutralizzare il patogeno di turno. La variabilità anticorpale, tra l’altro, risulta inferiore nei legami tra consanguinei, perché il patrimonio genetico dei loro figli è impoverito, cioè presenta meno diversità.
La stessa cosa avviene con la biodiversità. È la differenziazione tra le specie, che assicura ad un ecosistema equilibrio e capacità di rispondere ai parassiti. Le monocolture, ad esempio, sono quasi sempre tendenti ad essere aggredite da parassiti, e possono essere mantenute solo dall’intervento dell’uomo con l’uso di pesticidi, di erbicidi e di fitofarmaci.
In un ecosistema naturale esiste, invece, un equilibrio tra parassiti e predatori naturali, come uccelli, vespe, ragni, mosche e funghi, che con la loro azione antagonista riducono la vulnerabilità delle singole specie. Da questo si capisce che è indispensabile mantenere una grande variabilità genetica a livello di popolazione per conservare le specie e, più in generale, gli ecosistemi.
Una pluralità di cause
Quali sono le cause principali dell’estinzione delle specie e quindi della perdita della biodiversità? Sicuramente una delle principali cause è la sostituzione degli ecosistemi naturali con agroecosistemi o con ecosistemi urbani. Altre cause molto importanti sono il bracconaggio, la pesca intensiva, le pratiche agricole intensive con l’uso di pesticidi, erbicidi e fitofarmaci, l’introduzione di specie esotiche in contesti a loro estranei, con conseguente diffusione di agenti patogeni, la frammentazione degli habitat naturali, l’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’atmosfera. Molto spesso più fattori agiscono simultaneamente nella riduzione della biodiversità.
Talvolta le alterazioni ambientali prodotte localmente hanno conseguenze su scala continentale. Possiamo pensare alla plastica dispersa in acqua nei fiumi e nei mari di tutto il mondo, soprattutto laddove si trovano grandi insediamenti urbani. Essa si frammenta in microplastiche e viene ritrovata nelle acque artiche e antartiche, anche dove non esistono villaggi, oppure alle piogge acide, che inquinano i grandi laghi del Nord America e dell’Europa continentale e settentrionale e che prendono origine dalle emissioni atmosferiche prodotte a migliaia di chilometri di distanza.
A causa dell’acidificazione delle acque, è stato calcolato che sono scomparse più di 200mila popolazioni di pesci e un milione di popolazioni di invertebrati (dove per «popolazione» si intende l’insieme degli organismi di una data specie in un dato luogo).

La deforestazione e l’Amazzonia
Per quanto riguarda la sottrazione di habitat, basta pensare che, secondo il Wwf, negli ultimi trent’anni sono stati deforestati 420 milioni di ettari di terreno, cioè una superficie equivalente a quella dell’Unione europea, la maggior parte dei quali in zone tropicali. Mediamente, ogni anno vanno persi almeno 10 milioni di ettari di foreste, che vengono convertiti in terreni agricoli. Nel solo 2018 sono andati persi 3,6 milioni di foresta pluviale primaria, una superficie grande quanto il Belgio. Le foreste pluviali primarie sono le più vecchie, mai modificate finora dall’attività antropica. Hanno un ruolo fondamentale sia nella preservazione della biodiversità, sia nella limitazione delle emissioni di gas climalteranti.
Le foreste tropicali rappresentano inoltre la più grande farmacia del pianeta. La deforestazione comporta quindi la perdita di specie sia vegetali, che animali, che potrebbero tornare molto utili per le sostanze in esse presenti, soprattutto in campo farmaceutico.
Solo in Amazzonia, che ha un’estensione di 6,7 milioni di chilometri quadrati, tra il 1988 e il 2017 sono stati persi ogni anno mediamente 12mila chilometri quadrati con dei picchi fino a 28mila. La tecnica maggiormente usata in questa regione per deforestare ed espandere le aree destinate a coltivazioni, allevamenti ed estrazioni minerarie è l’utilizzo del fuoco. Nel 2018 sono stati contati circa 73mila roghi.
Se non si interviene urgentemente, il terreno bruciato va incontro a dilavamento, erosione e desertificazione, amplificando i rischi prodotti dai cambiamenti climatici. Si calcola che, se si perdesse tutta l’Amazzonia, andrebbe perso il 10% di tutta la biodiversità mondiale, oltre all’habitat per 34 milioni di persone. Se poi consideriamo che le foreste assorbono globalmente 2,4 miliardi di tonnellate di carbonio all’anno e l’Amazzonia vi contribuisce per un quarto, è evidente che essa rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’equilibrio climatico terrestre.
Biodiversità e fame (il caso del grano)
La perdita di biodiversità significa anche aumento della fame nel mondo, insorgenza di intolleranze alimentari e perdita di molecole utilizzabili a scopo farmaceutico.
La biodiversità può aiutare a contrastare la fame nel mondo, perché la disponibilità di diverse specie utilizzabili a scopo alimentare è senz’altro più sicura dei prodotti delle monocolture e degli allevamenti intensivi, che più facilmente possono soccombere all’aggressione di agenti patogeni o alle avversità climatiche, essendo caratterizzate da una minore variabilità genetica, rispetto alle specie selvatiche.
Recenti studi hanno portato alla conclusione che l’aumento dell’intolleranza al glutine potrebbe derivare dall’uso diffuso, che si fa attualmente, di sole quattro varietà di grano per la panificazione e la produzione di pasta, con il quasi totale abbandono delle antiche varietà. Le varietà di grano usate fino alla metà del secolo scorso erano circa una cinquantina, ma con l’avvento dell’agricoltura meccanizzata e l’introduzione delle monocolture è stata data la preferenza alle specie selezionate successivamente agli anni Settanta, con un’altezza ottimale per l’uso della mietitrebbia e dalla maggiore resa. Questo ha però comportato una disassuefazione del nostro organismo alle diverse varietà di grano e quindi di glutine, con conseguente possibile insorgenza dell’intolleranza. Inoltre, i grani antichi presentano un tipo di glutine con una diversa struttura e più facilmente assimilabile, rispetto a quello delle cultivar moderne.
Formare una coscienza collettiva
Come fare quindi a difendere la biodiversità? Oltre alle azioni intraprese a livello internazionale dai vari governi, o a quelle di organizzazioni come il Wwf o Greenpeace, oltre alla realizzazione di strumenti di difesa della natura come i bioparchi e di conoscenza come gli ecomusei, è indispensabile una continua informazione ed educazione della popolazione, e dei giovani in particolare, attraverso la scuola e i media, per creare una coscienza collettiva capace di rendersi conto delle gravi conseguenze che la distruzione dell’ambiente ha sul genere umano.
Rosanna Novara Topino

I numeri
A rischio estinzione
Secondo un rapporto congiunto del Wwf e della Zoological Society of London del 2016, tra il 1970 e il 2012, le popolazioni di animali selvatici al mondo si sono dimezzate. Secondo la «lista rossa» dello Iunc (Unione internazionale per la conservazione della natura) sono minacciati di estinzione:
- ●︎ 1.199 specie di mammiferi (il 26% delle specie conosciute);
- ● 1.957 di anfibi (41%);
- ● 1.373 di uccelli (13%);
- ● 993 di insetti (0,5%).
Sicuramente queste stime sono per difetto, perché la nostra conoscenza del numero reale delle specie viventi è alquanto approssimativa.
Basta pensare che, alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, si sospettava che una percentuale compresa tra l’83 e il 98% di specie fosse ancora da scoprire. Questo significa che, con le nostre attività, portiamo all’estinzione specie di cui non siamo nemmeno a conoscenza, soprattutto per quanto riguarda le specie che vivono ai tropici (si stima che il loro numero sia compreso fra 3 e 30 milioni).
Attualmente in tutto il pianeta sono state descritte 1.371.500 specie animali, ma si pensa che il loro numero possa variare tra 2 e 11 milioni. I funghi conosciuti sono circa 100mila, ma il loro numero dovrebbe essere compreso tra 600mila e 10 milioni di specie. Le piante conosciute sono 307.700, ma il loro numero potrebbe essere di 450mila specie. Dei batteri probabilmente conosciamo solo l’1%. Ciò che sappiamo per certo è che ogni specie vivente rappresenta un tassello indispensabile dell’ecosistema in cui vive e la sua perdita porta senz’altro all’alterazione di un equilibrio tra esseri viventi.
RTN
Le cause della moria
I nemici delle api

La moria delle api è un esempio di forte riduzione di popolazione all’interno di una specie. Essa è dovuta all’azione di varie concause, tra cui sicuramente l’uso di pesticidi, la presenza di agenti patogeni e l’introduzione di specie aliene. Il fenomeno preoccupa fortemente dagli anni 2000, quando si è iniziata a registrare una vera e propria sparizione di intere colonie. Il fatto però è antecedente a quegli anni, poiché in Usa tra il 1947 e il 2005 è andato perso il 59% delle colonie di api, mentre in Europa tra il 1985 e il 2005 il 25%. Ci sono ben 29 agenti patogeni che attaccano le api, il principale dei quali è il Varroa destructor, un acaro parassita dell’Apis mellifera e dell’Apis cerana, ma una grande responsabilità per la moria è dei pesticidi neonicotinoidi. Oltre a questo è stata introdotta in Europa e in Italia in particolare una specie aliena carnivora, che aggredisce le api durante il loro ritorno all’alveare, cibandosene. Si tratta della Vespa velutina, un calabrone di origine asiatica. Oltre alla riduzione delle api, si calcola che solo in Europa il 9,2% delle 1.965 specie di insetti impollinatori stia per estinguersi, mentre un ulteriore 2,5% potrebbe essere minacciato nel prossimo futuro. Considerando che l’80% delle piante esistenti dipende, per la riproduzione, dall’impollinazione per mezzo di insetti, possiamo capire quale sia la portata di questo fenomeno. È celebre, a tal proposito la frase di Einstein: «Se le api scomparissero dalla Terra, per l’uomo non resterebbero che quattro anni di vita».
RTN