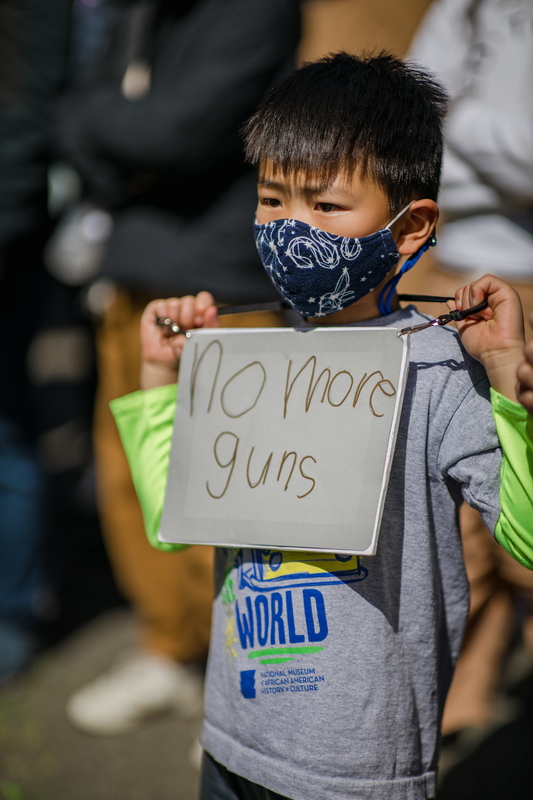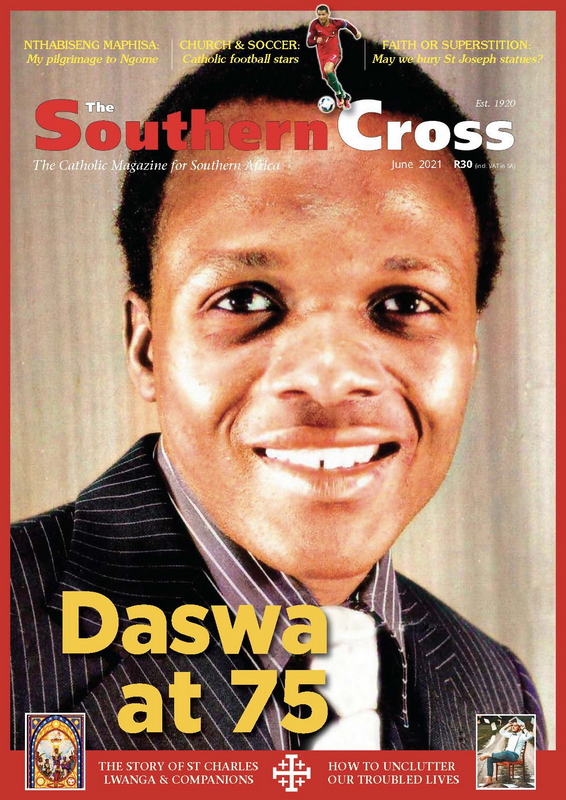Più cuore e più spazio
L’ospedale di Neisu, in Congo, si è arricchito di un reparto di cardiologia, mentre in Costa d’Avorio il centro di salute di Marandallah avrà presto una nuova farmacia e il centro di Dianra potrà contare su un reparto per il ricovero di pazienti.
Le malattie cardiovascolari (Mcv) sono la principale causa di morte sul pianeta: secondo i dati riferiti al 2019 dello studio Global burden of disease (Gbd) dell’Institute for health metrics and evaluation (Ihme) dell’Università di Washington (Usa). Queste patologie hanno, infatti, provocato 18,5 milioni di decessi su un totale mondiale di 56,5 milioni, un decesso su tre. Si tratta di cardiopatie ischemiche nella metà dei casi, di ictus in un caso su tre e di altre patologie nel restante 17% dei casi. Oltre l’80% di queste morti avvengono in paesi a basso e medio reddito.
Il paese numericamente più colpito è la Cina, con oltre 4,5 milioni di decessi, che rappresentano però il 43% del totale dei decessi nel paese. Ad avere il primato in termini percentuali è l’Ucraina, le cui 449mila morti causate da malattie cardiovascolari sono il 64% del totale nazionale@.
In Africa subsahariana, nel 2019 le morti per Mcv sono state un milione, quasi raddoppiate rispetto alle 564mila del 1990. Anche a livello globale si è verificato un aumento, ma è pari a circa il 50%, dai 12 milioni del 1990 a 18,5 milioni attuali, mentre nell’Unione europea vi è stata una lieve diminuzione, passando da 2,3 milioni a due.
Un rapporto pubblicato nel 2014 dall’Organizzazione mondiale della sanità sottolineava come una delle cause dell’aumento di queste patologie in Africa subsahariana fosse l’invecchiamento della popolazione. La regione aveva anche la più alta prevalenza – cioè persone malate sul totale della popolazione – di ipertensione al mondo: 38,1% tra i maschi, 35,5% tra le femmine con alcuni paesi – Capo Verde, Mozambico, Niger, São Tomé e Principe – che riportavano tassi di prevalenza del 50% o superiori.
C’erano circa 80 milioni di adulti con ipertensione nell’Africa sub-sahariana nel 2000, si legge ancora nel rapporto, e le proiezioni del 2014 suggerivano che questa cifra salirà a 150 milioni entro il 2025. Fra le cause che il rapporto indicava, vi era la frequente assunzione di sale a dosi elevate: il sale viene infatti utilizzato per conservare gli alimenti ma anche aggiunto per rendere più gustosi i cibi@.
![]()
La situazione in Congo
Nel 2019 in Repubblica democratica del Congo sono morte 564mila persone, di cui quasi 90mila – il 16% – per malattie cardiovascolari. Per 31mila e settecento persone – circa una su tre – si è trattato di cardiopatie ischemiche e 33mila – di nuovo un terzo – sono state colpite da ictus, mentre delle restanti 25mila, oltre la metà è deceduta a causa di una cardiopatia ipertensiva.
Vale per la Rd Congo la stessa tendenza segnalata sopra per l’Africa subsahariana: le morti da malattie cardiovascolari sono raddoppiate, da poco più di 45mila del 1990 alle attuali 90mila.
A complicare le cose vi è la scarsa disponibilità di personale sanitario nel paese che conta 30.768 medici generalisti e 778 specialisti per una popolazione di quasi 90 milioni di persone, un rapporto di 0,4 medici ogni mille abitanti, che sale a 1,5 ogni mille se si considera anche il personale infermieristico@. Per avere un termine di paragone, secondo i dati Istat più recenti, del 2019, in Italia il rapporto è di 4 medici ogni mille abitanti considerando generalisti e specialisti insieme, e sale a 10 ogni mille abitanti se si aggiunge il personale infermieristico@.
All’ospedale Notre Dame della Consolata (Hndc) che i missionari Imc gestiscono a Neisu, provincia dell’Alto Uélé, Nordest della Rd Congo, nel 2020 le malattie cardiovascolari sono state la causa di otto su 49 decessi (16%) fra i ricoverati in terapia intensiva, sette per insufficienza cardiaca e uno per ipertensione, mentre in medicina generale 20 delle 39 morti (51%) sono state causate da insufficienza cardiaca.
Quanto ai ricoverati, sui 908 ricoveri in medicina interna, 193 avevano patologie cardiovascolari – circa un paziente su cinque – nella maggior parte dei casi (174) un’insufficienza cardiaca, mentre in terapia intensiva, su 309 ammessi, 32 avevano una Mcv, circa uno su dieci. In 29 casi si trattava ancora una volta di insufficienza cardiaca.
![]()
Un reparto cardiologia per Neisu
L’ospedale Notre Dame de la Consolata di Neisu è nato all’inizio degli anni Ottanta come dispensario, per iniziativa di padre Oscar Goapper, medico e missionario poi scomparso nel 1999. Oggi la struttura sanitaria consiste di un ospedale centrale e 12 centri periferici, di cui il più lontano si trova a 55 chilometri dalla struttura centrale, in una zona che può richiedere un’intera giornata per essere raggiunta perché le strade non sono asfaltate e spesso sono dissestate: durante la stagione delle piogge, infatti, acqua e fango le rendono impraticabili.
L’ospedale ha oggi 210 posti letto e il personale è composto da 5 medici generalisti, 46 infermieri all’ospedale più 11 nei centri periferici, e 32 dipendenti tra impiegati dell’amministrazione, inservienti e addetti alla manutenzione. Nel 2021 i parti sono stati 599 e le visite esterne quasi 6.200.
La struttura, fino a pochi mesi fa, non disponeva di un reparto di cardiologia, né poteva riferire i pazienti ai centri sanitari del capoluogo provinciale, Isiro, non solo per le distanze, ma soprattutto perché nemmeno in città esisteva un reparto in cui assistere le persone con Mcv. «Ricoveriamo i malati in medicina interna o terapia intensiva», spiegava Ivo Lazzaroni, missionario laico responsabile dell’ospedale, «causando loro ulteriore stress e disagio alla vista di altri ammalati in condizioni difficili o, a volte, già in stato terminale. Era chiaro che serviva un nuovo padiglione solo per malati cardiaci, dove potessero essere loro garantite cure adeguate e riposo. Per questo abbiamo pensato di costruire un reparto con due stanze da dieci posti letto l’una, un ambulatorio e due stanze private con toilette».
Grazie alla generosità di diversi donatori privati e aziende, i lavori strutturali sono iniziati nella primavera del 2021 e si sono conclusi nei primi mesi di quest’anno, mentre è ora in corso l’acquisto di equipaggiamento, attrezzature e arredamento: ecografo o ecodoppler, letti e altro mobilio essenziale. Era inoltre necessario formare il personale sanitario in modo che si specializzasse sulle Mcv: grazie a un’altra donazione privata è stato possibile inviare la dottoressa Michèline e le infermiere Mariamo e Marie Noelle a Kinshasa, capitale del paese, a frequentare un corso di formazione di tre mesi.
![]()
Costa d’Avorio: piccoli centri, grandi servizi
In Costa d’Avorio i Missionari della Consolata gestiscono due centri sanitari nel Nord del paese: il Centre de santé Joseph Allamano (Csja) a Dianra e il Centre de santé Notre Dame de la Consolata (Csndc) a Marandallah.
A Dianra, ai servizi già presenti – dispensario, maternità, farmacia, laboratorio analisi – si sono aggiunti a partire dal 2019 un servizio odontoiatrico, un programma nutrizionale e un servizio di accompagnamento alle persone affette da patologie mentali. Grazie al sostegno di un donatore privato, si è poi avviato il servizio trasfusioni, con l’installazione di un frigo per la banca del sangue, portato avanti nel quadro della fruttuosa collaborazione con le autorità sanitarie locali.
Il servizio trasfusioni, rivolto specialmente a bambini affetti da anemia grave, ha ricevuto più richieste di quanto il responsabile del Csja, padre Matteo Pettinari, si aspettasse, e il numero di posti a disposizione nelle sale degenza si è presto rivelato troppo basso. Padre Matteo ha aggiunto materassi posati al suolo nelle sale degenza, ma è stato subito chiaro che non poteva trattarsi di una soluzione né sufficiente né definitiva. Per questo si sta ora completando la costruzione di un’ulteriore sala per l’ospedalizzazione, che permetterà di accogliere in spazi adeguati i pazienti che necessitano di una trasfusione tenendoli separati da quelli ospedalizzati.
![]()
Un altro intervento in corso a Dianra è quello della messa a norma del centro come richiesto dalle autorità sanitarie locali: si sta dunque provvedendo a tinteggiare o piastrellare le sale di visita e attesa, a dotare il centro di pattumiere a pedale, a sostituire le tende di stoffa con altre di un materiale plastificato per poterle più facilmente disinfettare e altri accorgimenti di questo tipo.
Presso il centro di salute di Marandallah, invece, grazie a diverse donazioni di privati e aziende, si sta procedendo alla costruzione di una farmacia più grande, poiché quella attuale – spiegava a inizio 2021 il responsabile padre Alex Likono – non aveva più spazio sufficiente né per lo stoccaggio dei medicinali né per permettere al personale di muoversi in modo agevole e trovare con rapidità i farmaci. Si stanno inoltre acquistando e installando ventilatori in ogni reparto – durante la stagione più calda, in questa zona della Costa d’Avorio si arriva a temperature intorno ai 40° – in modo da garantire una degenza il più possibile confortevole ai pazienti e un ambiente di lavoro gradevole al personale.
Chiara Giovetti
![]()
I numeri degli ospedali e dei centri sanitari:
Anno 2021 consulti parti posti letto personale
Hndc Neisu 6.191 599 210 94
Csja Dianra 3.850 175 8 25
Csndc Marandallah 3.286 91 18 25
Vaccino malaria, a che punto siamo
Lo scorso aprile l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riportava che era arrivato a un milione il numero di bambini fra Kenya, Malawi e Ghana che avevano ricevuto una o più dosi di RTS,S (noto come Mosquirix), il vaccino attivo contro il Plasmodium falciparum, il più letale dei parassiti che causano la malaria e quello più diffuso in Africa. Il vaccino non offre protezione contro il Plasmodium vivax, parassita diffuso invece in molti paesi non africani. L’efficacia del vaccino era stata confermata nello studio di fase 3 della sperimentazione clinica, avvenuta fra il 2014 e il 2019: tra i bambini di età compresa tra 5 e 17 mesi che hanno ricevuto tre dosi di RTS,S somministrate a intervalli di un mese, seguite da una quarta dose 18 mesi dopo, il vaccino ha ridotto la malaria del 39%, cioè l’aveva prevenuta in quasi quattro casi su dieci. Le quattro dosi hanno anche ridotto del 31,5% la malaria grave in questa fascia di età, riducendo i ricoveri e la necessità di trasfusioni di sangue. Tra i bambini che all’età di 5-17 mesi hanno ricevuto le prime tre dosi senza poi ricevere la quarta, il beneficio protettivo contro la malaria grave è andato perso, evidenziando l’importanza della quarta dose.
Tra i bambini più piccoli, invece, il vaccino contro la malaria non ha funzionato abbastanza bene da giustificarne l’ulteriore utilizzo in questa fascia di età.
Il programma vaccinale pilota è stato lanciato nell’aprile 2019 e si prevede finisca nel 2023: allora saranno disponibili i dati più consolidati sulla fattibilità della somministrazione, sul ruolo del vaccino nel ridurre le morti e sulla sua sicurezza nell’uso di routine. Questi risultati, spiega l’Oms, informeranno le future decisioni circa la possibilità di somministrazione su larga scala@.
Chi.Gi.
![]()