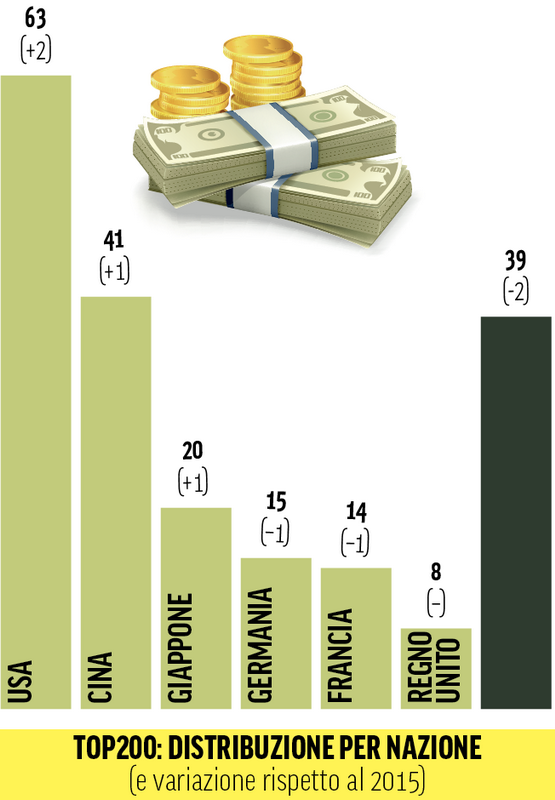Il falso anniversario della crisi (economica)
Si dice che (la crisi) sia iniziata il 15 settembre 2008. È un falso inventato per non ammettere che la crisi è nata dalla globalizzazione. Un processo che ha prodotto sfruttamento nei paesi del Sud, salari bassi e disoccupazione in quelli del Nord. Quando i consumi sono risultati insufficienti, il sistema ha pensato di uscirne con i mutui facili. Quello che poi è successo è storia recente.
L’anno appena trascorso è stato commemorato in tutto il
mondo come il decennale di una crisi da cui non siamo ancora realmente usciti. L’anniversario è dovuto alla
narrazione ufficiale che vuole fare coincidere l’inizio della crisi con la
caduta della Lehman Brothers, la
banca d’affari fallita il 15 settembre 2008. Tuttavia, se vogliamo capire
davvero come essa si sia prodotta e perché non si sia ancora esaurita,
nonostante le migliaia di miliardi di dollari messi in campo dalle principali
banche centrali, dobbiamo andare molto più indietro. Il decennio giusto da cui
partire è quello degli anni Ottanta del secolo scorso, quando a Punta del Este,
una località balneare situata su una stretta penisola nel Sud Est dell’Uruguay,
si tenne l’ultima tornata (round) di riunioni sotto l’egida di un accordo
commerciale internazionale nato nel 1947 e conosciuto come General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt, Accordo Generale
sulle Tariffe e il Commercio). L’Uruguay Round, avviato nel 1986, durò ben otto
anni e aveva come scopo la sepoltura del Gatt e la nascita al suo posto di un
nuovo organismo denominato World Trade
Organization (Wto, Organizzazione Mondiale del Commercio – Omc).
Arriva la globalizzazione

L’atto di nascita dell’Omc avvenne il 15 aprile
1994 a Marrakesh per volontà di 123 paesi. Questo organismo si può considerare
l’inizio ufficiale di ciò che chiamiamo «globalizzazione».
Nonostante le molteplici definizioni date al
termine, da un punto di vista economico la globalizzazione è riassumibile come
il tentativo di trasformare il mondo intero in un unico mercato, un’unica
piazza finanziaria, un unico villaggio produttivo. È il passaggio da un mondo
strutturato su mercati nazionali, ognuno con le proprie regole commerciali e
doganali, a un mondo strutturato come mercato unico con da regole comuni, per
permettere a merci e capitali di fluire senza ostacoli da un capo all’altro del
globo.
Un cambiamento non casuale, perché rispondente ai
bisogni dei nuovi padroni del mondo, le multinazionali, ormai con capacità di
vendita così ampie da far sì che nessuna nazione possieda un numero di
consumatori sufficienti ad assorbire i loro prodotti. Immaginarsi, ad esempio,
se una Coca-Cola, una Nestlé o una Volkswagen può accontentarsi dei consumatori
esistenti nel proprio paese di origine. Per le dimensioni raggiunte, ognuna di
esse aveva bisogno di rivolgersi ai consumatori di tutto il mondo e,
chiedendosi come fare per tagliare il traguardo, capirono che il vero ostacolo
da affrontare erano gli stati. Questi, in nome della difesa dei propri
consumatori, dei propri posti di lavoro, della propria sicurezza sociale,
pretendevano di definire in totale autonomia le regole di entrata e uscita di
beni e servizi. In effetti 150 nazioni, con 150 legislazioni, 150 regimi
doganali, l’uno diverso dall’altro, rappresentano una vera complicazione per i
mercanti globali che invece hanno bisogno di uniformità. Per questo è stata
istituita l’Organizzazione Mondiale del Commercio col compito di scrivere le
regole sovrannazionali, una sorta di «supercostituzione mondiale», che ogni
nazione deve impegnarsi a rispettare quando legifera su tematiche che hanno a
che fare col commercio internazionale. Disgraziatamente per noi, tali ambiti
sono molto vasti e vanno dalle questioni sanitarie a quelle ambientali, da
quelle culturali a quelle sociali. Immancabilmente, la supercostituzione
dell’Omc impone agli stati di ridurre al minimo, se non di eliminare, ogni
regola che si pone in contrasto con gli interessi commerciali. Basti pensare
che nel 1999 l’Unione europea è stata condannata dall’Omc per aver vietato
l’ingresso della carne proveniente da bestiame statunitense allevato con ormoni
ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori.
La corsa alla riduzione dei costi e dei salari
Proprio quando la globalizzazione ha cominciato a
materializzarsi, le imprese hanno scoperto che il grande mercato mondiale che
loro sognavano in realtà non esiste perché il numero di famiglie con soldi
sufficienti per entrare nell’olimpo dei consumatori non va oltre il 30% della
popolazione mondiale. Tutte le altre sono solo zavorra. Così milioni di imprese
di tutto il mondo si sono trovate l’una in guerra con l’altra per conquistarsi
un mercato mondiale tutto sommato piccolo senza possibilità di espansione
immediata. Ne è venuta fuori una concorrenza all’ultimo sangue combattuta non
solo con i mezzi moderni della tecnologia, del design, della velocità di
consegna, ma anche con le armi più tradizionali della pubblicità e
dell’abbassamento dei prezzi. Un insieme di misure che certo possono fare
aumentare le vendite, ma anche assottigliare i profitti se contemporaneamente
non vengono ridotti i costi. Così nel vecchio lupo capitalista è riemerso,
prepotente, l’istinto di risparmiare attaccando il lavoro con strategie
differenziate a seconda del settore di attività. In quelli ad alta tecnologia è
stata intensificata l’automazione per sostituire i lavoratori con robot, che
non pretendono contratti, non dichiarano sciopero e non si suicidano, come
invece fanno gli umani quando non ne possono più. Nei settori ad alta
manovalanza, invece, si è optato per la delocalizzazione, prima verso l’Asia,
poi anche verso l’Europa dell’Est, in ogni caso verso paesi dove salari e
diritti sono così ridotti da garantire costi di produzione anche venti volte più
bassi di quelli in vigore nei paesi di vecchia industrializzazione. Di colpo è
stata riscritta la geografia mondiale del lavoro con risultati drammatici:
sfruttamento e industrializzazione selvaggia nel Sud, aumento della
disoccupazione e riduzione dei salari nel Nord. Un attacco al lavoro in piena
regola che ha prodotto come risultato finale la riduzione della massa salariale
a livello globale.
In Europa, ad esempio, l’Ocse ha certificato che
la quota di prodotto interno lordo per i salari è scesa dal 72%, nel 1975, al
63% nel 2014. Una perdita di 9 punti percentuali che, nel caso specifico
italiano, è stata addirittura di 13 punti. Un fenomeno purtroppo non confinato
ai soli paesi di vecchia industrializzazione, ma che coinvolge anche i paesi
emergenti. In Cina, ad esempio, nel periodo 1995-2012 la quota di Pil andata ai
salari è scesa del 7%, in Turchia addirittura del 17%.
I guasti della globalizzazione
Che la globalizzazione abbia aggravato le
disuguaglianze lo dice non solo la diversa distribuzione del Pil fra salari e
profitti, ma anche la distribuzione della ricchezza patrimoniale. Per
intendersi il possesso di case, aziende, depositi bancari. Nel 2000 l’1% più
ricco della popolazione mondiale deteneva il 40% della ricchezza privata
mondiale. Oggi ne detiene il 50%. Dolce musica per i detentori di capitale, ma
al tempo stesso rumore sordo di tempesta: se i salari scendono, chi comprerà
tutto ciò che il sistema produce? In effetti l’ombra della crisi da scarsità di
mercato si è manifestata fin dall’inizio della globalizzazione con l’arrivo di
due cavalieri. Il primo: l’espansione della finanza, un fenomeno che fa
capolino ogni volta che aumentano i profitti, ma ci sono basse prospettive di
vendite. Il secondo: l’espansione del debito, che si affaccia ogni volta che i
magazzini si ingolfano di materiale invenduto.
La strada maestra per sbloccare la situazione
sarebbe stata la crescita salariale, ma non sentendoci da quell’orecchio il
sistema ha cercato di fare crescere le vendite spingendo le famiglie a
consumare oltre le proprie possibilità tramite l’indebitamento. Strada che gli
Stati Uniti hanno imboccato a piene mani a inizio anni Duemila utilizzando come
esca l’acquisto della casa.
L’imbroglio dei mutui
Complessivamente fra il 2000 e il 2007 vennero
concessi mutui per 18.000 miliardi di dollari, ma un buon 15% erano subprime, ossia scadenti nel senso che
erano a rischio di non ritorno perché concessi a famiglie così povere da non
poterli restituire. Così successe che gli stessi agenti che, un paio di anni
prima, erano passati casa per casa per strappare una firma sotto un contratto
per l’accensione di un mutuo, ora passavano per pignorare le abitazioni degli
insolventi e metterle sul mercato al fine di recuperare le somme prestate. Ma
le case pignorate e messe in vendita erano tante. L’effetto fu un crollo del
prezzo del mercato immobiliare che impediva il pieno recupero delle somme
impegnate.
La cosa strana, tuttavia, fu che quando il marcio
venne a galla, non furono le banche che avevano stipulato i mutui a
preoccuparsene, ma tutte le altre. E qui si scoprì che la concessione di mutui
a famiglie troppo povere per poterli ripagare non era stato il frutto di errori
di valutazione, ma di disonestà. Il fatto è che le banche che concedevano i
mutui non avevano nessun interesse a valutare la solidità delle famiglie perché
sapevano che avrebbero scaricato la patata bollente su altri.
Il trucco su cui si reggeva l’intero castello
stava nel fatto che le banche concessionarie di mutui avevano trovato il modo
di dare prestiti alle famiglie e riscuoterli subito, non dalle famiglie che già
erano in difficoltà a restituirli in trent’anni, ma da altri soggetti disposti
a subentrare come creditori al posto loro.
In fin dei conti avevano messo in piedi un
gigantesco meccanismo di vendita dei mutui che trovava clienti soprattutto fra
banche, fondi pensione e assicurazioni. Per di più quegli stessi mutui erano
stati utilizzati come base di scommesse complicatissime che si rivelarono tutte
perdenti quando trapelò la notizia che molte famiglie americane non pagavano più.
Il terremoto fu mondiale e a rimanere sotto le macerie furono soprattutto le banche di qua e di là dell’Atlantico che si ritrovarono i cassetti pieni di titoli che ormai non valevano niente. La Lehman Brothers forse venne lasciata fallire appositamente per fare conoscere al mondo quanto fosse grave la situazione delle banche che, trovandosi piene di debiti e un capitale altamente svalutato, non erano più in grado di svolgere la loro funzione istituzionale di concedere prestiti. Così la crisi finanziaria si estese al sistema produttivo con fabbriche che chiusero e investimenti che non vennero realizzati. Una vera tragedia sul piano occupazionale che, secondo le Nazioni Unite, comportò la perdita di 30 milioni di posti di lavoro.

Serve più salario e più lavoro
Di chi è la colpa di tutto questo? L’accento è
stato posto sulla mancanza di regole che ha consentito al sistema bancario e
finanziario di avventurarsi per strade insane e piene di azzardi. Una diagnosi
verissima, purtroppo ancora valida per responsabilità della politica che non ha
saputo intervenire per metterci al riparo da nuove crisi bancarie che magari
possono avere come nuovo epicentro la crisi dei prestiti per mantenersi agli
studi piuttosto che ai consumi. La mancanza di regole è però solo una parte
della storia. A monte di tutto c’è l’ingiusta distribuzione della ricchezza che
provoca povertà e indebitamento.
Il sistema deve capire che l’equilibrio può essere
ritrovato solo in due modi: aumentando i salari e permettendo a tutti di avere
un lavoro. Che non significa automaticamente produrre più beni per il mercato,
ma ridurre l’orario di lavoro e rilanciare l’economia pubblica. Ricette
semplici e possibili ma che attueremo solo se cambieremo mentalità.
Francesco Gesualdi