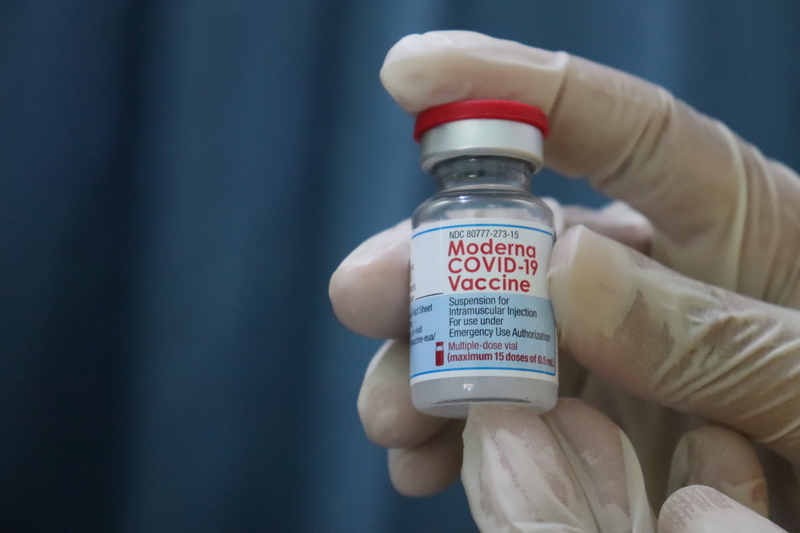Ucraina, tempo di deporre le armi
L’aggressione della Russia all’Ucraina rientra nella prassi delle grandi potenze. In questo caso, a causa del pericolo nucleare, la situazione è ancora più rischiosa. La domanda da porsi è la seguente: è possibile difendersi da arroganza, soprusi e violenza senza ricorrere alle armi?
L’aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia di Putin è l’ennesimo esempio di come le grandi potenze si sentano autorizzate a utilizzare la forza delle armi ogni volta che non trovano altro modo per imporre la propria volontà. Per quanto riguarda la Russia, era già successo negli anni passati con l’aggressione alla Cecenia (1999-2009) e alla Georgia (2008). Per quanto invece riguarda l’Occidente, possiamo citare l’invasione dell’Iraq e dell’Afghanistan. Ovviamente una giustificazione è fornita sempre, possibilmente nobile. Ad esempio: la difesa della libertà, l’esportazione della democrazia, la liberazione delle donne. E, naturalmente, la sicurezza, ragione principe invocata anche dalla Russia per giustificare l’invasione dell’Ucraina.
Crimea e Donbass
![]() Fino al 1991, l’Ucraina era una delle Repubbliche dell’Unione Sovietica. Poi, quando l’Urss si disgregò, divenne una nazione indipendente, al pari della Russia. Con una popolazione di 44 milioni di persone, il 70% dei residenti in Ucraina parla ucraino, l’altro 30% russo, porzione collocata soprattutto nella parte meridionale e orientale del paese, in particolare nelle regioni della Crimea e del Donbass. Da vari anni in queste regioni si erano sviluppati movimenti separatisti, che, nel 2014, diedero alla Russia il pretesto per invadere e annettersi la prima. E non è un caso se, nel febbraio 2022, l’invasione dell’Ucraina è cominciata proprio con l’invio di truppe in Donbass, dove, va detto, il conflitto che dura da oltre un lustro ha già provocato all’incirca 14mila vittime da ambedue le parti, le milizie filo russe e l’esercito ucraino.
Fino al 1991, l’Ucraina era una delle Repubbliche dell’Unione Sovietica. Poi, quando l’Urss si disgregò, divenne una nazione indipendente, al pari della Russia. Con una popolazione di 44 milioni di persone, il 70% dei residenti in Ucraina parla ucraino, l’altro 30% russo, porzione collocata soprattutto nella parte meridionale e orientale del paese, in particolare nelle regioni della Crimea e del Donbass. Da vari anni in queste regioni si erano sviluppati movimenti separatisti, che, nel 2014, diedero alla Russia il pretesto per invadere e annettersi la prima. E non è un caso se, nel febbraio 2022, l’invasione dell’Ucraina è cominciata proprio con l’invio di truppe in Donbass, dove, va detto, il conflitto che dura da oltre un lustro ha già provocato all’incirca 14mila vittime da ambedue le parti, le milizie filo russe e l’esercito ucraino.
La Crimea venne occupata sostenendo che lo chiedeva la popolazione locale. In realtà interessava alla Russia per la sua posizione strategica: affacciata sul Mar Nero, essa permette alle fregate russe di raggiungere il Mediterraneo attraverso il Bosforo e lo stretto dei Dardanelli. Ma l’invasione avvenne nel febbraio 2014, una data che, collegata ad altri eventi, mostra come l’annessione della Crimea avesse anche un altro scopo, al tempo stesso punitivo e intimidatorio. Da tempo fra Ucraina e Unione europea erano in corso trattative per stipulare un accordo di libero scambio (in vista di una piena adesione all’Ue), ma quando arrivò il tempo della firma, nel novembre 2013, il presidente in carica, Viktor Janukovyč, si rifiutò di farlo. Immediatamente nel paese si svilupparono vaste proteste represse nel sangue dalla polizia ucraina. Esse, però, alla fine ebbero come risultato la fuga e la messa in stato di accusa di Janukovyč. Le proteste popolari mostrarono chiaramente che una larga fetta della popolazione voleva e vuole un processo di avvicinamento all’Unione europea, ma questo alla Russia non è mai piaciuto. E qui sta il vero nodo del contendere: la Russia non tollera di avere un paese confinante deciso ad orbitare attorno a un altro centro gravitazionale. Non lo tollera per ragioni economiche e per ragioni militari.
Ucraina e Unione Europea
Come c’era da aspettarsi, nella fase iniziale di spezzettamento dell’Unione Sovietica, le relazioni economiche dell’Ucraina erano principalmente con Mosca. Tuttavia, un po’ alla volta, la Russia è stata sostituita con l’Unione europea che, oggi, assorbe il 43% delle esportazioni ucraine e contribuisce al 41% delle sue importazioni. I settori forti dell’economia ucraina sono la siderurgia, l’agricoltura, il settore minerario. Settori che la rendono importante perfino a livello mondiale. In campo agricolo, ad esempio, l’Ucraina è il primo esportatore mondiale di olio di girasole, il terzo produttore al mondo di patate e il quinto esportatore di grano. In ambito minerario è il primo paese europeo per riserve di uranio, il secondo paese del mondo per riserve di ferro, l’ottavo al mondo per riserve di carbone, minerale tornato tristemente in auge.
L’Ucraina svolge un ruolo importante anche come paese di transito del gas russo. Ruolo che tuttavia si è andato attenuando da quando nel 2012 è entrato in funzione il Nord Stream, il gasdotto che porta il gas direttamente in Germania passando per il Mar Baltico. Tant’è che oggi solo il 30% del gas russo diretto all’Europa passa per l’Ucraina, con danno evidente per l’economia del paese che si vede ridurre gli introiti per questo servizio. Pur con questo neo, nell’ultimo decennio l’economia ucraina è cresciuta costantemente. Con i suoi 44 milioni di consumatori, molti servizi pubblici privatizzabili, abbondanza di terre agricole, vasti giacimenti da sfruttare, l’Ucraina esercita un forte appeal sull’Unione europea che, pur di averla come 28° membro, ha anche deciso di spenderci. Dal 2014 a oggi, l’Unione europea ha sborsato all’Ucraina 17 miliardi di euro, parte a fondo perduto, parte sotto forma di prestiti, per consentirle di portare avanti le riforme necessarie a poter entrare nell’Unione. La Russia, da parte sua non ha speso neanche un rublo, ma vorrebbe tanto che l’Ucraina divenisse il sesto membro dell’«Unione economica euroasiatica», l’alleanza economica instituita nel 2014 fra Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Armenia.
![]()
Il ruolo della Nato
Più dello smacco economico, a innervosire la Russia è però la questione militare. Quando il mondo comunista cominciò a disgregarsi, sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, esistevano due alleanze militari: da una parte il Patto di Varsavia, dall’altra l’Alleanza Atlantica, in sigla Nato.
Il Patto di Varsavia era stato istituito nel 1955 e, oltre all’Unione Sovietica, comprendeva altri sette paesi del blocco comunista: Polonia, Cecoslovacchia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Bulgaria, Ungheria e Albania. Il Patto Atlantico, invece, era stato istituito nel 1949 e oltre a Stati Uniti e Canada, comprendeva un’altra decina di stati europei del blocco capitalista. Le due alleanze avevano entrambi lo scopo di permettere ai paesi aderenti di sostenersi a vicenda nel caso uno di loro fosse stato attaccato da un paese del blocco opposto. Con il disgregarsi del blocco comunista e il conseguente sfaldamento del Patto di Varsavia, molti si dissero che la Nato non aveva più ragione d’esistere, ma invece di dissolversi si rafforzò perché molti paesi ex comunisti chiesero di farne parte. E oggi la Nato è un’alleanza militare formata da 30 paesi, che complessivamente spendono in armamenti oltre 1.000 miliardi di dollari all’anno, oltre le metà della spesa mondiale per armamenti che, nel 2021, è stata pari a 1.981 miliardi. In testa gli Stati Uniti che da soli hanno speso 778 miliardi, il 39% della spesa mondiale. La Cina, seconda in classifica, spende 252 miliardi, mentre la Russia si attesta a 62 miliardi dietro l’India che ne ha spesi 73. In termini di spesa pro capite fa 2.364 dollari per gli Usa e 430 per la Russia.
Oltre a chiedere di entrare nell’Unione europea, l’Ucraina chiede di entrare anche nella Nato. Il processo di ammissione è in atto in entrambi i casi. Per l’entrata nell’Alleanza, un tavolo di consultazione permanente è stato istituito nel 1997. Nel frattempo, sono possibili piani di collaborazione, come l’invio di istruttori militari da parte della Nato o la messa a disposizione di truppe da parte del nuovo candidato, per operazioni militari che coinvolgono la Nato. Ad esempio, nel 2003 l’Ucraina ha inviato in Iraq qualche migliaio di soldati che ci sono rimasti fino al 2008. Scelta ripetuta nel 2007 con l’invio di truppe in Afghanistan. Gli Stati Uniti hanno ringraziato, inviando 2,7 miliardi di dollari dal 2014 a oggi per il rafforzamento dell’esercito ucraino.
Intanto, nel 2017, un nuovo atto del parlamento ucraino ha confermato la richiesta di ingresso nella Nato, permettendo al presidente Zelensky di proseguire con le procedure di ammissione. La Russia però si oppone strenuamente a questa prospettiva, perché non gradisce l’idea di avere basi e truppe Nato a ridosso dei propri confini. Da un trentennio Mosca si oppone all’allargamento dell’Alleanza Atlantica, chiedendo all’Ucraina di scegliere la strada della neutralità, come fanno vari altri paesi in Europa: Moldova, Svezia, Finlandia, Austria, Irlanda, Svizzera. E, fra tutti, il riferimento è la Finlandia, paese nordico che confina con la Russia. La Finlandia fece la scelta della neutralità nel lontano 1955 come contropartita dello smantellamento della base militare russa a Porkalla, un porto navale a pochi chilometri da Helsinki. Un precedente storico che dovrebbe far riflettere.
![]()
Tra sanzioni e armi
Fortunatamente, la scelta effettuata dall’Occidente come contromisura contro le ripetute aggressioni russe è stata quella delle sanzioni economiche, anche se, in controtendenza, in occasione dell’aggressione di febbraio è stato deciso di inviare anche armi alle forze ucraine. Scelta che era meglio non fare, ricordandoci che, secondo l’articolo 11 della Costituzione, «l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Che non significa rinunciare a difenderci o tollerare qualsiasi sopruso e arroganza, ma rivedere il modo di opporci alle violenze. La politica perseguita fino a oggi dall’Occidente, Italia compresa, è l’attuazione del motto «Si vis pacem, para bellum», se vuoi la pace prepara la guerra. La cosa da fare è ribaltare questo postulato affermando che la pace si prepara con la pace. Che in concreto significa due cose.
La prima: prepararci a forme di difesa basate sulla non collaborazione. Ad esempio, nel caso ucraino piuttosto che armi avremmo dovuto inviare corpi civili di pace col duplice scopo di soccorrere la popolazione locale e mettere in difficoltà l’esercito invasore.
La seconda scelta è quella di smettere di intervenire a cose fatte, quando il vaso si è rotto e cercare invece di prevenire la rottura del vaso. Che, fuori di metafora, significa lavorare per la distensione invece che per la tensione. Oggi, un passo fondamentale in questa direzione sarebbe lo smantellamento della Nato e di qualsiasi altra organizzazione militare che crea blocchi militari. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è la chiara dimostrazione di come i blocchi militari generino paura e la paura generi violenza.
I vuoti proclami delle Nazioni Unite
L’unica strada per interrompere l’escalation militare è il multilateralismo. Il rafforzamento, cioè, di sedi internazionali all’interno delle quali portare i dissidi internazionali con l’intento di trovare soluzioni basate sulla mediazione e l’accordo, piuttosto che sulle armi. L’umanità aveva già fatto un tentativo in questa direzione tramite l’istituzione delle Nazioni Unite. Ma non ci ha creduto abbastanza e oggi le Nazioni Unite sono poco più di un luogo dove si pronunciano vuoti proclami. È arrivato il tempo di cambiare tutto questo.
Francesco Gesualdi