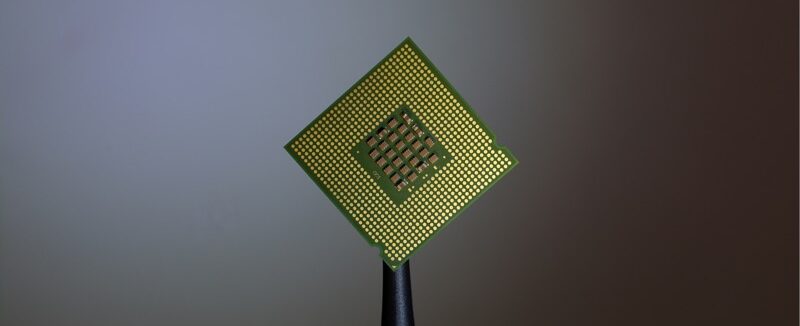Sfida alla dittatura del dollaro
Da gennaio 2025, il gruppo dei Brics, nato nel 2009, si è allargato all’undicesimo paese. Il gruppo si pone come alternativa economica ai paesi occidentali riuniti nel G7. Uno degli obiettivi dichiarati è porre fine alla supremazia del dollaro Usa.
Un nuovo soggetto si aggira per il mondo e innervosisce i paesi occidentali. Si chiama Brics, una sigla che sta per Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. L’acronimo venne usato la prima volta in una nota sullo stato dell’economia mondiale pubblicata nel 2001 da Jim O’Neill, responsabile dell’ufficio ricerche di Goldman Sachs, potente banca d’affari. La nota voleva avvertire i governi occidentali che altri paesi stavano emergendo sulla scena economica mondiale e che nessuna nuova decisione poteva essere presa senza di loro.
Sfida al forum dei «G7»
Consiglio pertinente, se si considera che, a partire dal 1976, i paesi occidentali più potenti – Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America – avevano preso a incontrarsi annualmente per concordare risposte comuni alle principali problematiche mondiali. Il forum era stato battezzato G7 – Gruppo dei sette – e si è consolidato come l’assise internazionale, esterna al sistema delle Nazioni Unite, nella quale i potenti decidono le politiche da imporre al mondo intero.
Nel 1997, il G7 divenne G8 per l’inclusione della Russia, che però ci sarebbe rimasta solo fino al 2014, anno in cui ne sarebbe stata esclusa per essersi impossessata della Crimea (Ucraina). Intanto, al G8 del 2003, presieduto dalla Francia, furono invitati come osservatori anche Brasile, India e Sudafrica. I tre ne uscirono contrariati rendendosi conto che erano lì per pura formalità.
Lula, presidente del Brasile, chiese: «A che serve essere invitati al banchetto dei potenti per mangiare solo il dessert?». E aggiunse: «Oltre al dessert vogliamo assaporare tutte le altre vivande».

Fatto sta che, solo tre giorni dopo, i ministri degli esteri dei tre paesi si ritrovarono a Brasilia e formalizzarono la nascita del «Forum di dialogo dell’Ibsa» con l’obiettivo principale di trovare una linea di condotta comune sui tanti temi che si stavano definendo all’interno dell’Organizzazione mondiale del commercio. In particolare, quello sui brevetti, tenuto conto che tutti e tre i paesi ospitavano industrie che producevano grandi quantità di farmaci generici al servizio di tutto il Sud del mondo.
Intanto, in Asia, andava prendendo forma l’Irc, un tavolo composto da India, Russia e Cina per confrontarsi con regolarità su temi di interesse comune, come sicurezza, migrazioni, terrorismo.
I due forum, l’Ibsa e l’Irc, si fusero nel settembre 2006, allorché Russia e Brasile, in occasione di una riunione all’Onu, promossero un incontro allargato a Cina e India, per discutere le problematiche connesse all’assetto finanziario internazionale. Tema più che mai azzeccato considerato che di lì a poco si sarebbe scatenata una delle peggiori crisi finanziarie a livello mondiale.
Fu proprio la crisi del 2008 a dare carattere di stabilità al gruppo dei Brics che formalizzò la propria alleanza durante un nuovo incontro organizzato nella cittadina russa di Yekaterinburg, il 16 giugno 2009, data del primo summit ufficiale.
Da allora i cinque paesi (il Sudafrica si unì nel 2011), s’incontrano ogni anno e progettano iniziative comuni. Una delle più importanti fu la creazione, nel 2015, di una banca internazionale denominata Nuova banca di sviluppo (Ndb, secondo l’acronimo inglese).
Il Pil dei Brics
Nel 2001, quando O’Neill alzò per la prima volta il sipario sui futuri Brics, il loro peso sulla scena mondiale corrispondeva all’8% del Pil e al 43% della popolazione. Nel tempo sono passati al 25% del Pil, mentre la popolazione si è ridotta al 41% del totale mondiale.
Dal gennaio 2024 sono però stati ammessi altri cinque membri (Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti). A gennaio 2025 è entrata l’Indonesia, mentre altre nazioni hanno mostrato interesse ad aderire. Fra esse Thailandia, Malaysia e la Turchia che pure fa parte della Nato.
In conclusione, ben presto il blocco dei Brics potrebbe rappresentare un terzo del Pil e dell’interscambio mondiale. Basti dire che all’ultimo vertice che si è tenuto in Russia, a Kazan, dal 22 al 24 ottobre 2024, erano presenti 37 paesi. Tutti molto diversi fra loro per collocazione geografica, regime politico, posizione economica, ma tutti interessati a rafforzare la propria economia senza subire condizionamenti da parte dei potentati economici, in particolare quello statunitense.
Non a caso il grande tema al vertice di Kazan è stato quello dei pagamenti internazionali.
Negli ultimi secoli, il commercio internazionale si è espanso a dismisura, ma la scelta della moneta con cui pagare è sempre stata un problema.
In maniera molto empirica, il vecchio Mao Zedong sosteneva che a deciderlo è la dimensione dei cannoni. Come dire che si è sempre imposta la moneta del paese più forte sia da un punto di vista economico che militare. La sterlina dominava quando gli inglesi possedevano un impero su cui non tramontava mai il sole, come il denarius aureus dominava quando a comandare era Roma.
L’egemonia del dollaro e la variabile Trump
Oggi, di paesi coloniali vecchia maniera non ce ne sono più. Ma il prodotto interno lordo e la spesa militare contano ancora. Tant’è che la moneta universalmente accettata è il dollaro, espressione degli Stati Uniti, che sono i primi sia per Pil (27mila miliardi di dollari), che per spesa militare (817 miliardi di dollari). Il risultato è che il dollaro è la moneta più richiesta al mondo ed è la più usata sia per gli scambi commerciali che per le operazioni finanziarie di livello internazionale.
I paesi Brics, e in particolare la Russia, stanno progettando di sfidare questa egemonia creando un sistema di pagamento alternativo, almeno nel loro circuito. Ma la battaglia si presenta ardua dal momento che Trump ha lanciato parole di fuoco quando ha saputo che qualcuno osava mettere in discussione la supremazia della moneta Usa.
Non ancora investito delle funzioni di presidente, il 1° dicembre 2024 ha rilasciato un comunicato stampa che suonava come una vera e propria dichiarazione di guerra: «Non credano i paesi Brics che noi ce ne staremo semplicemente a guardare se provano a sganciarsi dal dollaro». E proseguendo, ha aggiunto: «Noi li avvertiamo: se proveranno a creare un nuovo mezzo di scambio interno ai Brics o a sostenere la nascita di qualsiasi altro mezzo di pagamento che sfida la potenza del dollaro, saranno colpiti con dazi doganali fino al 100% affinché perdano ogni possibilità di vendere le loro merci nella meravigliosa economia americana».
Invettive confermate dopo l’insediamento (in un discorso del 22 febbraio 2025) e dettate non solo da spirito suprematista, ma anche dalla consapevolezza che essere titolari di una moneta a valenza internazionale offre vantaggi. Ad esempio, permette di vivere al di sopra delle proprie possibilità, ossia di poter godere della ricchezza altrui, oltre che di quella prodotta internamente. Il caso americano né un classico esempio.
![]()
Il debito degli Stati Uniti
Gli Stati Uniti vivono cronicamente in uno stato di debito commerciale, nel senso che importano più di quanto esportano. Nel 2023 la differenza in negativo è stata di 773 miliardi di dollari, ma nessuno ha protestato. Se qualsiasi altro paese avesse un deficit commerciale di questo livello verrebbe subito messo sotto sorveglianza del Fondo monetario internazionale e costretto a ogni forma di sacrificio finché non avesse portato la propria bilancia commerciale in pareggio.
Gli Stati Uniti, invece, continuano indisturbati nella loro navigazione in rosso, perché possono compensare il loro debito commerciale con le grandi masse di dollari che ricevono da tutto il mondo sotto forma di capitali. Tenendo a mente che, in caso di cattiva parata, i dollari possono essere ottenuti con la stampa di nuove banconote.
La rivoluzione di Nixon
Per la verità fino al 1971 questa possibilità era limitata dal fatto che ogni aumento di denaro esigeva un aumento di riserve di oro perché c’era l’impegno, da parte della Banca centrale statunitense, di convertire i dollari in oro qualora le istituzioni estere ne avessero fatto richiesta (era il sistema aureo o Gold standard). In quel 1971, constatando che ormai di dollari in circolazione ce n’erano troppi, il presidente americano Richard Nixon decretò la fine della convertibilità in oro lasciando molta più libertà all’emissione di nuova moneta (cioè alla stampa di nuovi biglietti). Come dire che il dominio del dollaro, oggi più che mai dipende dalla forza economica e militare degli Stati Uniti.
Eppure, già nel 1944, quando a Bretton Woods (negli Usa) si discuteva quale assetto finanziario dare al mondo che usciva dalla seconda guerra mondiale, l’economista inglese John Maynard Keynes aveva proposto un sistema di pagamenti internazionali che escludesse l’uso diretto di qualsiasi moneta nazionale.
Due i capisaldi della sua proposta. La prima: la creazione di una moneta interbancaria, il bancor, che avrebbe avuto una parità fissa con ogni moneta, da utilizzare esclusivamente come unità di conto, ossia per permettere a ogni paese di registrare il valore delle proprie importazioni ed esportazioni. La seconda: la creazione di una camera di compensazione con il duplice compito di verificare i saldi periodici di ogni nazione e concordare volta per volta le misure da adottare per permettere a debitori e creditori di ritrovare una situazione di pareggio. Un sistema ben diverso da quello in vigore oggi che costringe tutti i paesi del mondo a dotarsi di riserve in valuta forte (prevalentemente dollari o addirittura oro), per saldare le eventuali posizioni debitorie che possono venire a crearsi.
«R5», la valuta dei Brics

L’alternativa attorno alla quale stanno lavorando i Brics, per le loro relazioni commerciali, è simile a quella prospettata da Keynes. La proposta prevede la creazione di un’unità di conto, denominata «R5», il cui valore è determinato per il 40% dal prezzo dell’oro e per il rimanente 60% da un paniere di valute nazionali utilizzate all’interno dei Brics, che – di qui il termine – cominciano tutte per «R»: reais, rublo, renmimbi, rupia e rand, rispettivamente valute ufficiali di Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica.
La proposta è integrata dalla creazione di un circuito di comunicazione interbancario attraverso il quale le banche di tutti i paesi Brics possono comunicarsi in tempo reale i pagamenti che si fanno reciprocamente per le più svariate esigenze dei propri clienti.
Va detto che già oggi esistono vari circuiti di comunicazione fra banche a livello internazionale, ma quello predominante è lo Swift, con sede legale in Belgio e controllato dalle banche centrali di dieci paesi occidentali. Complessivamente, il circuito Swift comprende più di 11mila organizzazioni finanziarie e bancarie appartenenti a oltre 200 paesi e territori fra i quali fino al 2021 figurava anche la Russia, poi estromessa come ritorsione per avere aggredito l’Ucraina.
Considerata la sua posizione di paese sotto sanzioni, si capisce perché la Russia spinga più degli altri per la creazione di un sistema di pagamenti alternativo. Comunque la si metta, l’egemonia del dollaro rimane un problema perché getta sul mondo intero e, in particolare, sui paesi più deboli, le conseguenze di scelte operate per ragioni a esclusivo servizio degli Stati Uniti. Valga, come esempio, la decisione assunta negli ultimi anni dalla Banca centrale statunitense di aumentare il tasso di interesse per aggiustare la propria economia. L’effetto è stato la crescita del costo del debito a livello globale che ha obbligato molti governi del Sud a ridurre le spese sanitarie e sociali per pagare gli interessi più alti maturati sui prestiti esteri.
È troppo presto per dire se i Brics possono rappresentare una speranza di gestione alternativa dell’economia a livello mondiale, ma è salutare che qualcuno sfidi lo status quo.
Francesco Gesualdi