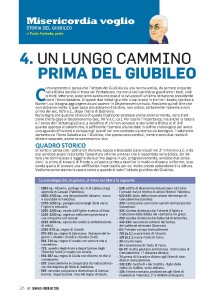Storia del Giubileo 6. Il Giubileo
Abbiamo già visto che tutto ruota attorno alla questione della proprietà della terra, dopo l’editto di liberazione del re Ciro (538 a.C.), contesa tra i possessori di fatto che non erano stati deportati e gli esiliati rientrati che vantavano il diritto legale alla proprietà.
Schiavi per debiti

Il rientro dall’esilio, quindi, non è stato quel trionfale e giornioso ritorno descritto dai testi sacri, ma un doloroso incidente che ha portato quasi a una guerra civile. Da un lato, per i residenti che non erano stati deportati, i nuovi arrivati erano intrusi, anzi «stranieri», venuti a scombussolare la loro tranquilla, anche se povera, esistenza. Erano passati cinquant’anni da quei fatti dolorosi e l’esilio era un ricordo nella memoria. Da parte loro, gli immigrati ritornati, pretendevano di rientrare in possesso di tutte le proprietà che erano stati costretti a lasciare per la violenza dell’invasore di allora. Si erano dunque creati due partiti contrapposti, di cui abbiamo un indizio forte nel capitolo 5 del libro di Neemia.
Quando una famiglia povera faceva un debito gravoso, dava in pegno un figlio o una figlia «come schiavo» che poteva essere trattenuto per sei anni, ma non oltre (cf Dt 15,12). Nella situazione di estrema povertà di quel tempo, i ricchi erano arrivati a prendere come ostaggi-schiavi molti ebrei, cioè fratelli dello stesso popolo e della stessa religione. Neemia aveva imposto il condono dei debiti e la libertà delle persone, proibendo in nome di Dio che un ebreo potesse essere schiavo di un ebreo. Qui troviamo già il primo nucleo di quello che si svilupperà in seguito e che prenderà il nome «Giubileo», che è dunque un istituto giuridico per rispondere ai problemi sorti con il ritorno degli esiliati nella terra d’Israele.
Il Giubileo è la risposta che Israele produce per la soluzione di questi problemi che apparivano senza apparente sbocco: due contendenti avanzavano diritti sulla stessa proprietà. Districare la matassa dopo cinquant’anni non era facile. Solo una scelta drastica poteva imporsi e allo stesso tempo essere stimolo per un progetto futuro. Nasce così il Giubileo che è lo sviluppo naturale dell’Anno Sabatico. Mentre questo riguardava un periodo relativamente corto (sette anni), per il Giubileo si prende la misura «cinquantenaria» che era il periodo di tempo che interessava nella disputa tra residenti e rientrati.
A circostanze nuove, nuova teologia
Oltre che ricostruire il tempio, Esdra e Neemia dovettero riorganizzare la religione, il culto annesso e le leggi che regolavano la vita cultuale del santuario, dimora di Dio. In questa prospettiva si raccolsero testi e tradizioni del passato, specialmente della tribù di Giuda, ma anche di alcune delle dieci tribù del regno del Nord, facendo una straordinaria opera di redazione finale della raccolta di «scritture» che divennero poi quello che oggi conosciamo come «Toràh» (ebraica) o «Pentateuco» (greco). Ciò avvenne intorno al 444 a.C. Si ripensò anche la cosmogonia, cioè l’origine dell’universo, inventato da Dio per creare lo scenario nel quale si sarebbe svolta la storia dell’alleanza tra il «Dio Onnipotente e Creatore» e il «più piccolo tra tutti i popoli» esistenti sulla terra.
La narrazione della creazione, che non è un racconto storico (anche il più sprovveduto se ne rende conto), ha anche uno scopo pedagogico perché l’autore vuole fare un’analogia: come Adamo è stato posto nel giardino di Eden in qualità di custode e servo, così, allo stesso modo, il popolo eletto è stato collocato nella terra promessa d’Israele perché la abiti, la coltivi e la custodisca come corpo prolungato dei Patriarchi e come segno della fedeltà di Dio. Anzi come corpo esteso di Dio perché la terra è «lo sgabello» del trono della sua gloria: «Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi» (Is 66,1). Questo testo è la conclusione del libro del Terzo Isaia, vissuto in esilio con i deportati. Egli, sviluppando la teologia universalistica del profeta Isaia storico, quello vissuto nel sec. VIII, consola gli esiliati e li incita al ritorno, facendo rivivere la loro storia attuale come una ripetizione di eventi antichi, come l’esodo e la creazione che vengono «ingigantiti» per motivi di natura teologica.
Nuovo concetto di «proprietà»
Il concetto di «popolo eletto» come «proprietà [di Dio] fra tutti i popoli» (Es 19,5), diventa una chiave teologica con la quale s’interpreta presente, passato e futuro. Tra il VI e il IV secolo in Babilonia e a Gerusalemme nasce un laboratorio in cui tutto si rinnova. Dalla storia passata, che viene riletta e ingigantita, nasce l’istituto del «sabato» come cuore della vita d’Israele e del culto, in sostituzione dei sacrifici; si crea il canone della Bibbia (intorno al 444 a.C.) nella forma dell’attuale Pentateuco (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio). E la storia «sacra», essendo «scritta», diventa «Sacra Scrittura», cioè testo normativo e immutabile della volontà di Dio.
Per dare «peso» alla« ricostruzione del futuro», fondato sulla religione e sull’appartenenza al «popolo eletto», tutto è ripensato e riformulato: i riti e i culti, la circoncisione, il sabato, le leggi di purità, i sacrifici, la Pasqua, il calendario e l’uso della terra. Tutto è proiettato «alle origini», trasformando una normale storia di tribù, spesso banale, in una grande epopea, una saga di natura «storica» rivisitata come in un fantasmagorico «kolossal» proiettato nella notte dei tempi. Esso legge la storia contemporanea (ritorno dall’esilio) come un processo che parte dall’iniziativa di Dio sul Sinai, e prima ancora dalla liberazione dalla schiavitù d’Egitto (assonanza con la schiavitù in Babilonia).
Nel primo racconto della creazione (Gen 1), scritto in ambienti sacerdotali, si afferma con chiarezza che nell’atto di creare Adamo ed Eva, Dio stesso li pose nel «giardino di Eden perché gli ubbidissero e lo custodissero» (Gen 2,15). Si ribalta il concetto di «proprietà»: non è l’uomo proprietario della terra, ma è la terra che indica come deve essere ascoltata e custodita. L’uomo diventa il custode, il servo del creato sul quale solo Dio esercita la sua autorità, mediata certamente dall’uomo che è «immagine di Dio» (Gen 1,27). Lo stesso concetto di «sottomettere la terra» (Gen 1,28) non è assoluto, perché è connesso alla luogotenenza esercitata da Adamo in nome di Dio di cui è plenipotenziario e da cui dipende. È Dio che controlla il comportamento dell’uomo.
L’esodo però è la risposta alla promessa fatta ai Patriarchi, che a loro volta sono l’esito della fedeltà che è il contrario della ribellione di Adamo ed Eva che a loro volta erano stati i protagonisti e i signori della creazione regalata loro da Dio come premessa e promessa della terra d’Israele, la terra dell’Alleanza e del tempio del Signore. Il raccordo tra i Patriarchi e la terra d’Israele è la figura di Mosè che ha il compito di dare compimento alla volontà di Dio. Mettendo l’istituto dell’anno sabatico tra le norme di Esodo e Levitico, facendolo risalire addirittura a Mosè, i redattori del Pentateuco stabiliscono il criterio «teologico» per risolvere il contenzioso sorto tra residenti e rimpatriati dall’esilio sul possesso della terra.
Nei libri di Levitico s’inseriscono le regole che riguardano il Giubileo, dando loro il valore di una norma antica proveniente direttamente da Dio, in base al principio, formulato in questo periodo, che la terra d’Israele è «esclusiva proprietà di Dio». Se la terra è di Dio nessuno può avanzare diritti e ciascuno deve avere la coscienza di essere solo un usufruttuario temporaneo. La terra di Palestina è per Israele «terra promessa» ai patriarchi, quindi terra di ospitalità su cui nessuno può avanzare diritti.
Il nome «Giubileo»

In ebraico l’anno giubilare si chiama «Shenàt jòbel» che tradotto alla lettera significa «Anno dell’Ariete» perché l’inizio e la fine dell’anno giubilare erano annunciati dal suono del «qéren jobèl – corno di ariete» che richiama uno degli eventi più importanti della Toràh e successivamente della tradizione giudaica: il sacrificio di Isacco sul monte Moria (Gen 18,1-19). Poiché il racconto è conosciuto, non ci attardiamo su di esso, ma rileviamo solo gli elementi che interessano il nostro discorso sul «Giubileo».
Dio chiede ad Abramo di sacrificargli il figlio unigenito. Abramo, uomo dalla fede indiscussa, non mette in dubbio l’intenzione di Dio e ubbidisce, perché Dio sa quello che fa, e si appresta a sacrificare il figlio, sebbene il suo cuore sanguini e le sue lacrime si mescolino a quelle del figlio. Secondo la tradizione giudaica, Isacco incoraggia il padre Abramo a ucciderlo rispettando tutte le regole prescritte per i sacrifici offerti a Dio per non rendere invalida, anche involontariamente, l’offerta della sua vita. Abramo quindi supplica Dio, in nome della fede di Isacco, che ha accettato liberamente l’aqedàh-legatura alla legna del sacrificio, che in futuro, quando i suoi discendenti, pregando, chiederanno qualunque cosa in nome dei meriti di Isacco, Dio li esaudisca in ogni loro richiesta. La tradizione cristiana ha visto in Isacco una prefigurazione di Cristo «legato al legno della croce»: come Isacco stava per essere immolato all’età di 37 anni (Gen R 55,4), così Gesù fu legato e sacrificato sulla croce alla stessa età (cf L. Ginzberg, Le leggende degli Ebrei, II. Da Abramo a Giacobbe, Adelfi Edizioni, Milano 1997, 97-102).
Il racconto ha un valore di contestazione dell’usanza diffusa dei sacrifici umani per motivi religiosi: infatti il Dio che apparentemente chiede la morte sacrificale del primogenito di Abramo, sospende la mano del padre obbediente che non osa discutere l’ordine di Dio e lo sostituisce con un «ariete» che Abramo scorge impigliato tra i rami. Il messaggio è chiaro: il Dio d’Israele non vuole la vita umana, lui che la crea e Abramo e Isacco, padre e figlio, ringraziano Dio con un olocausto che Dio stesso «ha provveduto sul monte».
Qui sta la ragione per cui si suona il «corno dell’ariete – qèren yobèl» sia per il Giubileo sia l’Anno Sabatico, sia al tramonto del venerdì per annunciare l’arrivo dello Shabàt, sia in tutte le feste importanti della vita d’Israele. Dio ha salvato Isacco, e il suono del corno di ariete ricorda a Israele che Dio salva il suo popolo, anche quando non lo merita. Il suono del corno diventa il simbolo, il segno della liberazione di Dio e viene proiettato indietro, fino alle pendici del Sinai, dove Dio parlava a Mosè al suono del corno di ariete (cf Es 19,13.19). Il suono del corno precede l’arca dell’alleanza e guida alla battaglia della presa di Gerico (Gs 6,4-6.13).
Il suono del corno squillerà ogni 49 anni per dare inizio al giubileo del cinquantesimo anno, anno di grazia e di liberazione, di salvezza e di perdono totale:
«10Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi toerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. 11Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. 12Poiché è un giubileo: esso sarà per voi santo; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. 13In quest’anno del giubileo ciascuno toerà nella sua proprietà. 14Quando vendete qualcosa al vostro prossimo o quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. 15Regolerai l’acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l’ultimo giubileo: egli venderà a te in base agli anni di raccolto. 16Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti. 17Nessuno di voi opprima il suo prossimo; temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore, vostro Dio. 23Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. 24Perciò, in tutta la terra che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per i terreni» (Lv 25, 10-17.23-24).
Questo è il punto di partenza dell’istituto del Giubileo che, in una fase di riforma religiosa e sociale, è codificato nella tradizione posteriore che però viene addirittura fatta risalire a Mosè, agli eventi del Sinai per dare a questa norma un peso di notevole importanza e coagulare attorno ad essa l’unità di tutto il popolo nuovo di Israele, composto dai residenti che mai lasciarono la terra di Palestina, ma anche dai rimpatriati che, liberati da Ciro, rientravano come stranieri nella «loro» terra che non avevano mai visto né conosciuto perché spesso erano nati e vissuti solo in terra d’esilio. La riforma non riguarda solo la terra, ma si presenta come una legge complessa che concee le persone, l’economia, il latifondo, la redistribuzione della ricchezza e il concetto di proprietà «privata», la quale nell’insegnamento biblico non ha mai attecchito.
In un tempo di crisi socio-religiosa (post esilio) nulla di più spontaneo che ritornare indietro, alle proprie origini, ripensarle alla luce dei nuovi eventi e «riscrivere» la storia come premessa per un nuova avventura, incastonata dentro un contesto ampio, antropologico, cosmico che si perde nella notte dei tempi e che raggiunge il cuore di Dio creatore che come all’inizio creò l’universo, ora crea di nuovo il suo popolo. Sacerdoti e classi dirigenti si servono della religione che ripensano e riformulano rivisitando narrazioni, tradizioni, epopee e preghiere del passato per dare risposta ai nuovi problemi che la Storia di «oggi» pone, imponendo una soluzione. Il Giubileo è un momento di questo processo che appartiene a un passaggio cruciale, una svolta decisiva che bisogna cogliere, se non si vuole perdere l’appuntamento con se stessi e il futuro.
Paolo Farinella, prete
(6, continua)