Lavorare nella cooperazione: miraggio o realtà?
Sono tanti i ragazzi che, freschi di laurea o in procinto di ottenere il titolo, avanzano candidature spontanee inviando email e curriculum alle organizzazioni che operano nella cooperazione. E, d’altro canto, l’offerta formativa delle università italiane negli ultimi quindici anni si è arricchita di corsi di laurea e master in cooperazione e solidarietà internazionale proprio per rispondere alla richiesta crescente di figure professionali adatte al lavoro nelle Ong o negli enti pubblici che si occupano di sviluppo. In questo numero vi proponiamo una panoramica sul fenomeno.

In molti casi, i ragazzi sembrano preferire una permanenza sul campo di qualche settimana, e magari il loro intento è quello di trascorrere un periodo nel Sud del mondo per chiarirsi le idee su che cosa scegliere per specializzarsi ulteriormente, una volta rientrati dal campo. Non sono rare, tuttavia, le manifestazioni di disponibilità per esperienze più lunghe, di mesi o anche anni.
La cooperazione, almeno dai primi anni Duemila, è entrata in modo piuttosto deciso all’interno delle aule universitarie: i master su questo tema sono ormai numerosi e la loro offerta formativa spesso si completa con la possibilità di fare tirocini sul campo presso organizzazioni convenzionate con le università. In questi casi l’entrata nel mondo del lavoro è, se non più facile, almeno più regolata.
I numeri: chi lavora nella cooperazione
Ma vediamo un po’ di numeri sul lavoro nella cooperazione. Secondo il più recente censimento Industria e Servizi dell’Istat, nel 2011 la cooperazione e solidarietà internazionale – inteso dall’Istituto di Statistica come sotto settore del non profit – poteva contare su oltre 3.500 istituzioni attive con circa 1.800 dipendenti, quasi tremila collaboratori e poco meno di ottantamila volontari. Sempre secondo lo stesso studio, rispetto a dieci anni prima la cooperazione ha visto raddoppiare gli addetti del settore, più che raddoppiare i volontari e aumentare del 148% – da 1.400 a 3.500 circa – il numero di enti attivi.
Altri dati indicativi si possono ottenere da Siscos – Servizi per la cooperazione, un’associazione senza fini di lucro che fornisce a chi si occupa di cooperazione internazionale assistenza, informazione e consulenza per quanto riguarda la gestione delle risorse umane. Fra i servizi che Siscos offre c’è quello delle coperture assicurative per gli operatori delle Ong, buon indicatore del movimento di addetti che gravita nel mondo nella cooperazione per quanto riguarda le assegnazioni a incarichi all’estero. Fra le pubblicazioni Siscos c’è Un mestiere difficile, dossier dedicato appunto lavoro del cooperante. Confrontando il numero di operatori assicurati annualmente da Siscos dal 2006 al 2014 emerge che a partire sono circa seimila persone all’anno, sebbene con una lieve flessione negli ultimi anni (nel 2014 gli assicurati Siscos sono stati 5.773, mentre nel 2011 erano 6.392).
Il primo dei dossier, relativo ai dati 2006, riportava l’incremento degli operatori per anno: dai 601 operatori del 1976 si era passati agli oltre cinquemila del 2006 e fra il 1996 e il 2006 si era registrato un incremento nell’ordine del 150%, dato che sembra confermare il trend emerso dai dati Istat visti sopra.
La professione si è, nel frattempo, specializzata, poiché se negli anni Settanta a partire erano solo volontari «generici», un trentennio dopo a essere assegnati sul campo erano collaboratori e cooperanti, cioè figure professionali definite, e volontari, non più «generici», inquadrati insieme ai cooperanti nella vecchia legge sulla cooperazione (la 49/87), regolarmente stipendiati.
Nel dossier 2014, la suddivisone in fasce d’età vede prevalere gli operatori fra i 31 e i 40 anni, pari a poco meno di un terzo del totale. La fascia fra i 19 e i 25 include tredici su cento degli assicurati e quella dai 26 ai 30 il 17 per cento. La suddivisone fra maschi e femmine è quasi alla pari, con una leggera prevalenza delle donne.
I numeri: chi cerca di entrare nel settore
Vediamo ora il versante del primo ingresso nella cooperazione, a partire dagli studi e cominciando dall’offerta formativa disponibile nelle Università per chi desidera studiare cooperazione.
Universitaly, il portale del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), elenca otto corsi di laurea di primo livello (triennale) in altrettanti atenei, e quindici corsi di secondo livello (biennale) in tredici Università. Quanto ai master, uno studio del ministero degli Affari esteri del 2007 ne contava oltre sessanta.
L’anagrafe nazionale studenti del Miur per il 2013/2014 riporta 408 laureati al corso di secondo livello in Scienze per la cooperazione allo sviluppo. Quattro anni prima erano 151. Il consorzio interuniversitario Almalaurea, che rappresenta circa il novanta per cento dei laureati italiani, effettua regolari indagini sulla loro condizione occupazionale. Per quanto riguarda chi ha completato il percorso di studi di secondo livello in cooperazione, dal campione di laureati analizzato per il 2014, a un anno dalla laurea, risulta che 114 su 254 intervistati hanno un impiego. Il non profit assorbe un quarto degli occupati, mentre oltre il 60% lavora nel privato e circa uno su dieci nel pubblico. Uno su quattro degli intervistati dice di usare molto, nel suo attuale lavoro, le competenze acquisite con gli studi mentre il 44 per cento non le utilizza per niente. Uno su tre giudica utile la propria laurea magistrale nello svolgere la propria attività lavorativa, mentre il 77 per cento sostiene che era sufficiente una laurea di primo livello o anche un titolo non universitario. Lo stipendio medio è poco meno di 1000 euro, con un divario notevole fra uomini e donne. I primi infatti percepiscono circa 1.300 euro contro i meno di novecento delle colleghe.
Per i giovani intervistati sempre nel 2014, ma laureati da cinque anni, la situazione appare meno difficile: a lavorare è il 70 per cento; la quota di chi lavora nel non profit rimane praticamente invariata (quasi il 27%), mentre il venti è impiegato nel settore pubblico e oltre il cinquanta nel privato. Si dimezza, inoltre, la percentuale di persone che non usa per niente le conoscenze ottenute grazie alla laurea e lo stipendio aumenta a poco meno di 1.300 euro: 1.479 per i maschi e 1.184 per le femmine.
Questi dati sono ovviamente molto parziali poiché si concentrano solo su chi ha scelto la cooperazione come percorso di studi specialistici e non tiene in considerazione chi invece arriva a lavorare in questo ambito per altre vie. Basta pensare a quanti medici, infermieri, economisti, antropologi, ingegneri sono attivi nei progetti realizzati sul campo – quindi a tutti gli effetti operatori del settore – per capire che gli studi in cooperazione non sono certo l’unico canale di entrata nel mondo dello sviluppo.
Emerge tuttavia un quadro nel quale i ragazzi che hanno via via scelto la cooperazione per il loro percorso di formazione è aumentato più o meno con gli stessi ritmi di crescita degli enti che si occupano di questo tema. Purtroppo l’entrata di questi laureati nel mercato del lavoro appare non impossibile ma certamente non immediata.
In rete sono molti i siti che cercano di fornire indicazioni utili per chi intende intraprendere da professionista la strada della solidarietà internazionale: dalle federazioni di Ong – che propongono spesso loro stesse master e percorsi formativi – alle università, ai blog individuali di cooperanti e addetti ai lavori, non è difficile farsi un’idea delle caratteristiche e delle difficoltà di questo lavoro. La prima di queste indicazioni è molto chiara: essere buoni non basta, occorre avere un’elevata professionalità e dotarsi di conoscenze tecniche precise. Queste conoscenze hanno a che fare con la gestione del ciclo di progetto, ma è bene tenere in considerazione anche tutta quella serie di competenze delle quali qualunque organizzazione necessita a prescindere dal settore in cui opera: amministratori, logisti, informatici, non hanno meno probabilità di venire reclutati da una Ong, anzi. Per rendersene conto basta dare un’occhiata alle offerte di lavoro sulla bacheca Volint – da anni punto di riferimento in Italia per chi cerca lavoro nella cooperazione – o sulla pagina della vacancy di Lavorare nel mondo. Altro aspetto importante è ovviamente quello delle lingue, indispensabili per lavorare in un ambito come quello dello sviluppo che è per sua stessa natura internazionale. L’inglese prima di tutto, certo, ma senza dimenticare le altre lingue parlate nei paesi in cui si fa cooperazione, comprese quelle locali.
Chiara Giovetti
Che cosa non fare: avventurieri e improvvisatori
The Volontourist è un documentario uscito quest’anno per far riflettere sul fenomeno del «volonturismo» – termine nato dall’unione di «volontariato» e «turismo» -, sul business creatosi intorno a esso e sui danni che rischia di generare nei luoghi in cui arriva.
La campagna di raccolta fondi della Ong francese Solidarité Inteationale presenta in tre video i colloqui con potenziali volontari (interpretati da attori) che danno voce ai peggiori stereotipi legati alla cooperazione. «Non ho esperienza nell’umanitario», dice una ragazza con abiti e gioielli etnici che si offre come volontaria, «ma ne ho già parlato con mia cugina, ho fatto tantissimo la baby sitter e poi un bambino che muore di fame è come un bambino normale, ha bisogno d’amore. Qui ho un cuore e il cuore è fatto per dare amore alla gente». «Posso aiutare a fare delle iniezioni», propone invece un pensionato in un altro dei tre video, «non le ho mai fatte, ma ci posso provare». (Ch.Gio.)
 Dopo gli anni
Dopo gli anni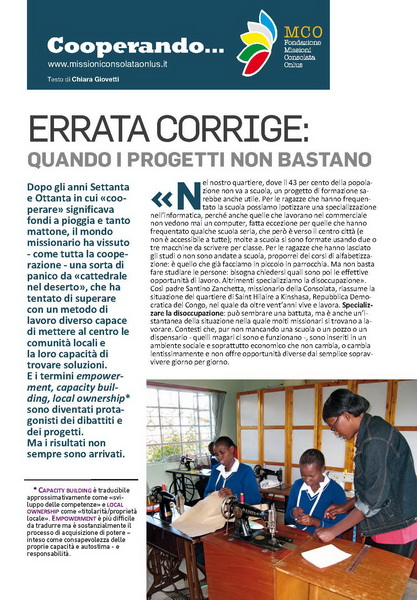

.jpg)
.jpg)

.jpg)




















 Chi finanzia lo
Chi finanzia lo(1).jpg)













 Caritas ambrosiana: il valore di un percorso
Caritas ambrosiana: il valore di un percorso









.jpg)










 Se si guarda al settore dell’istruzione, la situazione
Se si guarda al settore dell’istruzione, la situazione Quanto agli immigrati adulti, è a loro che si rivolge
Quanto agli immigrati adulti, è a loro che si rivolge