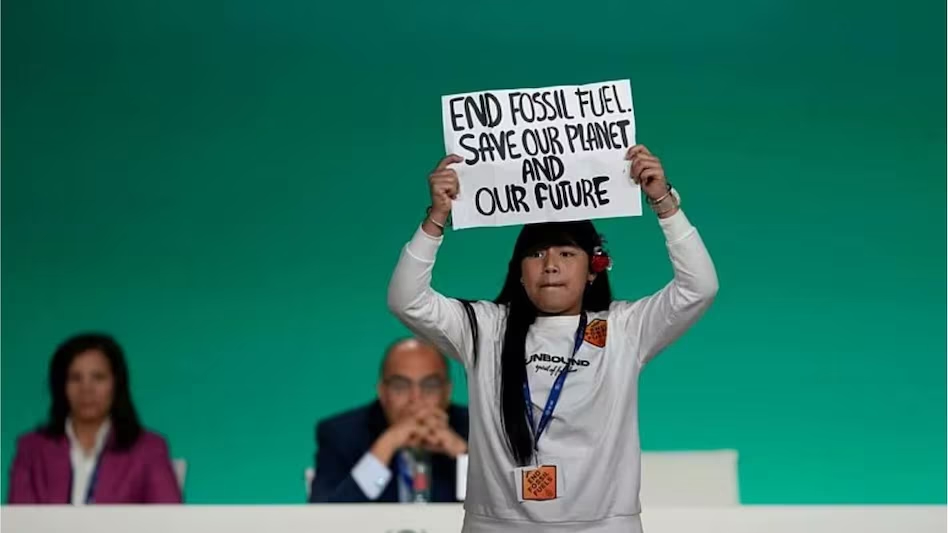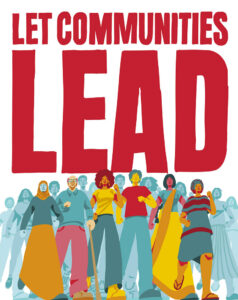Congo Rd. Elezioni o parodia?
Il 20 dicembre scorso i congolesi sono stati chiamati a eleggere il presidente della Repubblica, 500 deputati dell’Assemblea nazionale (Parlamento), quelli delle 26 Assemblee provinciali e, per la prima volta con la nuova Costituzione, i membri di circa 300 Consigli municipali. Gli elettori erano 44 milioni sui 100 milioni di abitanti. Queste cifre danno anche una misura di quanto giovane sia la popolazione.
I vescovi hanno incoraggiato i fedeli a partecipare al voto, chiedendo anche: «Diamo mandato ai nuovi leader che hanno dimostrato senso del bene comune, amore per la patria e generosità nei loro progetti sociali». I vescovi hanno a messo in guardia verso chi semina l’odio tribale e pure sulla compravendita dei voti. Coloro che usano pratiche simili «sono moralmente discutibili e vogliono prendere il potere tramite mezzi fraudolenti, non per servire, ma per servirsene, e continuare ad asservirci».
Il processo elettorale che doveva iniziare alle 6 del mattino del 20 e concludersi la sera, si è protratto ancora fino al giorno seguente giovedì 21, a tarda notte. Alcuni seggi nelle provincie del Bas-Uélé, Sud Kivu e Tanganyka, hanno addirittura aperto venerdì mattina, perché non avevano ricevuto i materiali. Ma anche nella capitale Kinshasa molti sono stati i casi problematici rilevati dagli osservatori elettorali.
Difficoltà logistiche per il raggiungimento dei seggi (ci sono ancora le piogge e molte strade sono impraticabili), ritardi nella consegna del materiale elettorale, ma anche problemi tecnici alle macchine per il voto (sono elettroniche e spesso le batterie risultavano scariche), hanno causato chiusure temporanee e lunghe code per il voto.
In alcune zone, inoltre, sono stati segnalati anche casi di violenze.
Secondo la Ceni (Commissione elettorale nazionale indipendente), i congolesi sono riusciti a votare nel 97% dei seggi, il che sarebbe, secondo loro, un ottimo risultato, viste le dimensioni e la cattiva rete di comunicazione del Paese. Gli osservatori, invece, ritoccano questo numero al ribasso.
La Ceni parla ufficialmente di un tasso di partecipazione elevato, e dichiara di voler presentare i primi risultati già oggi. In realtà per quelli definitivi si dovrà attendere almeno una settimana.
Il candidato di gran lunga favorito è il presidente uscente, Félix Tshisekedi, mentre altri nomi importanti sono Moise Katumbi (ricco uomo d’affari già governatore del Katanga), Martin Fayulu (politico influente, già deputato) e il premio Nobel per la pace Denis Mukewge.
«Queste elezioni sono una parodia», ci dice John Mpaliza, attivista congolese per i diritti umani. Gli altri candidati avrebbero potuto non presentarsi, ma in quel modo ci sarebbe stato un candidato unico (il presidente uscente, ndr), invece così hanno anche fatto vedere i brogli e i malfunzionamenti del sistema elettorale». Si riferisce alla Ceni guidata da Denis Kadima. In effetti
ci sono state irregolarità nella pubblicazione delle liste elettorali, sull’indicazione del seggio in cui votare, problemi con i documenti d’identità, cancellazione liste elettorali. Questioni denunciate da Fayulu, Mukewge e anche la Cenco (Conferenza episcopale nazionale del Congo).
Tra qualche giorno o settimana si conosceranno i risultati della consultazione elettorale, che per il presidente paiono scontati.
Marco Bello