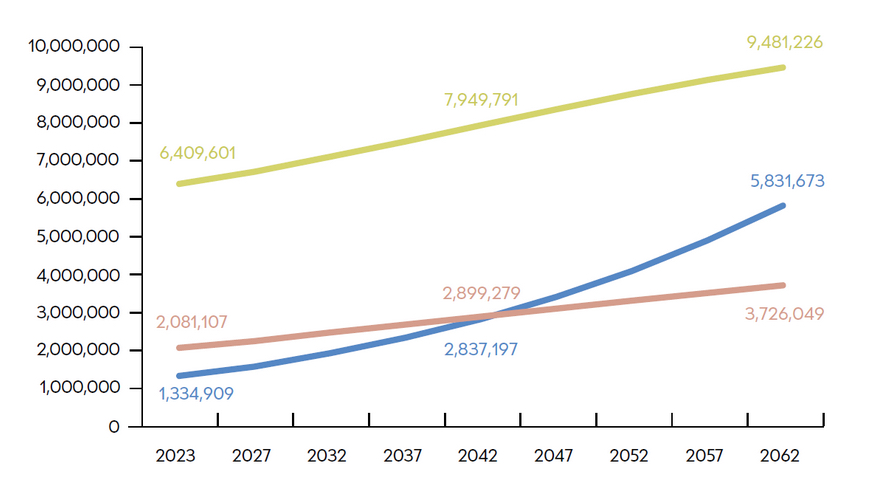Argentina. «El maligno es santo»
«Il maligno è santo», «Javier Milei, ai piedi di papa Francesco», «Da maligno a benigno»: sono alcuni dei titoli con cui il sito di «Página|12» apriva i servizi sull’incontro tra il presidente Javier Milei e papa Francesco, avvenuto in Vaticano domenica 11 (durante la canonizzazione di Mama Antula, la prima santa argentina) e lunedì 12 febbraio (in forma privata). L’ironia del quotidiano argentino era giustificata, forse addirittura doverosa.
Nei mesi precedenti la sua elezione, il presidente argentino era stato, infatti, prodigo di insulti verso l’illustre connazionale. Papa Francesco era stato definito da Milei, tra l’altro, «il rappresentante del diavolo sulla Terra», mentre ora è diventato «l’argentino più importante del mondo».
Pur non avendo (ancora) visitato il suo Paese, papa Francesco ha sempre ricevuto i vari presidenti argentini: da Cristina Kirchner a Mauricio Macri fino ad Alberto Fernández. L’incontro di lunedì con Milei – senza la presenza di altri – si è protratto per 70 minuti, ben più del previsto. È stato definito cordiale, ma non è chiaro come le loro (opposte) visioni sull’economia e sul capitalismo abbiano trovato punti in comune.
Javier Milei – libertario e anarcocapitalista come lui ama autodefinirsi – è arrivato a Roma dopo una visita in Israele e proprio nei giorni in cui la sua (ambiziosissima) Ley ómnibus veniva affossata. La legge omnibus era la legge d’esordio del suo governo, un unico progetto di 664 articoli che includeva varie riforme in materia economica, fiscale, amministrativa, con una base ideologica fondata su liberalizzazioni e privatizzazioni. Si prevedeva, per esempio, di togliere le limitazioni attualmente in vigore sull’acquisto delle (preziosissime) terre agricole argentine da parte degli stranieri.

Ospite più che apprezzato a una trasmissione di «Retequattro» (Nicola Porro) e sul quotidiano «Libero» (Mario Sechi), Milei ha rilasciato interviste che dipingono il personaggio. «Milei – ha scritto un entusiasta Sechi – ha l’aria di chi sta tessendo una tela, non solo per dare corpo e sostegno al suo piano per l’Argentina. La sua rivoluzione è quella di un uomo di pensiero che conduce una battaglia delle idee […]». Una di esse riguarda la concezione dello Stato: «Filosoficamente – ha spiegato il presidente – sono un anarcocapitalista e quindi nutro un profondo disprezzo per lo Stato. Credo che il nemico sia lo Stato, un’associazione per delinquere».
Sarebbe bello sapere se Milei abbia fatto le stesse osservazioni al cospetto del papa. Più personale ma comunque sorprendente un’altra affermazione fatta davanti alle telecamere di Retequattro: «Sono cattolico e pratico anche un po’ di ebraismo».
L’Argentina, potenzialmente molto ricca, è abbonata alle crisi economiche, che si ripresentano con la stessa puntualità con cui il paese sforna campioni di calcio, che poi costituisce la vera religione del paese. Peccato che il calcio non basti a risollevare le sorti dei 46 milioni di argentini. Vedremo se ci riuscirà Javier Milei, nuovo pifferaio magico del paese latinoamericano.
Paolo Moiola